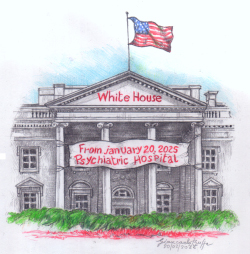La inammissibilità del referendum pro maggioritario proposto da otto regioni (ma sostanzialmente dalla Lega), dichiarata dalla Corte costituzionale in seguito agli argomenti da noi avanzati, rimette al centro del dibattito politico la questione della legge elettorale. Che è la madre di tutte le questioni, essendo relativa alle modalità di selezione della classe dirigente e quindi alla qualità della nostra politica.
Partiamo da cosa ha detto la Corte con la sentenza di ieri, sul piano generale in ordine all’uso dello strumento referendario (su quello tecnico specifico dovremo aspettare le motivazioni). Tre principi: 1) il quesito da rivolgere ai cittadini deve essere chiaro ed intellegibile per tutti, senza incomprensibili richiami o rimandi. 2) Il parlamento può delegare il governo ad emanare un atto avente forza e forma di legge. La stessa delega non può, però, darla il popolo attraverso il referendum perché così si creerebbe un corto circuito nella architettura della democrazia parlamentare. 3) Il quesito referendario non può essere «eccessivamente manipolativo», cioè proposto mediante un cosiddetto «ritaglio per sottrazione», per incastro linguistico e terminologico, così che la normativa residuale all’abrogazione abbia l’effetto di creare una nuova norma senza passare per il percorso legislativo parlamentare. Ad esempio, nel caso specifico: cambiare il metodo elettorale mediante l’abrogazione per via di referendum di parole o frasi inserite in leggi non afferenti al metodo elettorale.
La Corte ha ritenuto la proposta priva dei requisiti della chiarezza e della omogeneità logica del quesito, insomma della semplicità essenziale necessaria ed indispensabile per sottoporre ai cittadini questioni importanti, e non ve n’è di più importante sul piano istituzionale di quella del metodo elettorale.
Da qui dobbiamo (ri)partire se vogliamo convincere anche chi, destato dal campanello della Corte, si riassopisce subito con le tranquillanti, superficiali e pericolosissime parole di Prodi e Veltroni (ieri) e di Beppe Sala (oggi): dobbiamo pensare alla «governabilità», dunque al maggioritario. Ma in nessuna parte della Costituzione è scritto che le elezioni debbano garantire la «governabilità» o, addirittura, che la sera dello scrutinio si debba sapere chi ha vinto e chi ha perso. Questo succede alla Domenica sportiva.
La governabilità non è la ragione, il fine delle elezioni, ma il necessario, auspicato effetto, determinabile dalla convergenza delle forze politiche rappresentate in parlamento sui programmi proposti agli elettori e sulle mediazioni imposte dalle alleanze atte a costituire le maggioranze utili per governare. Questa è la governabilità.
Dunque non è affatto vero che con il maggioritario (cioè con un sistema che assegna alla formazione che non ha raggiunto la maggioranza ma è prima in classifica, un premio in seggi), sia assicurata ipso facto la «governabilità» stabile. A meno di un risultato elettorale con una maggioranza assoluta (i «pieni poteri»), ci vogliono sempre un’alleanza e un compromesso. La differenza tra i due sistemi, cioè tra quello attuale, con le nomine dei capi partito e quello proporzionale con le preferenze degli elettori è decisiva: la qualità della classe dirigente.
La storia di questo ultimo anno e mezzo e dell’annesso cambio al governo (ma possiamo dire la storia del paese da quando c’è il maggioritario per nomina, sia esso Porcellum, Italicum o Rosatellum con i suoi ribaltoni, cambi di casacche, compravendita di parlamentari) lo dimostra. La spiegazione è semplice: il sistema pensato dai costituenti, cioè il proporzionale puro con le preferenze, non fu scelto solo per impedire nuove temute derive autoritarie. La paura o meglio il rifiuto della tirannide era il presupposto. Ma il sistema recava in sé un fine tessuto di ingegneria costituzionale. Esso fotografava la realtà politica, il sentire del popolo italiano, fino a quello dell’ultimo cittadino, con un voto «diretto, libero ed uguale» per cui la sera dello scrutinio si sapeva chi eravamo, cosa pensavamo, quali erano gli orientamenti condivisi e in quale misura, appunto proporzionale, si traducevano in seggi parlamentari.
Così che i rappresentanti istituzionali sin da subito potevano/dovevano avviare i confronti per giungere alle alleanze con le quali costituire le maggioranze necessarie affinché un governo potesse avere la fiducia delle camere. Un lavoro duro e affascinante che si chiama politica. Così il quadro era stabile, poteva mutare sulla base di questioni politiche non di migrazioni di senatori e deputati fondate su posizionamenti e convenienze personali. E ciò per il semplice fatto che, essendo i parlamentari eletti con le preferenze, rispondevano del loro comportamento agli elettori che tali preferenze avevano espresso e non, come oggi avviene, al capo del partito che li nomina o che gli promette la rinomina.
In questo sciagurato mo(n)do il parlamento viene nominato dai cosiddetti leader, non viene assicurata alcuna governabilità politica, le maggioranze sono drogate dai premi, la vera volontà popolare non conta niente e le elezioni sono solo esercizi di posizionamento personale. Ciò è peraltro affermato dalle ripetute sentenze della Corte costituzionale sui parlamenti che ormai da un decennio sono eletti sulla base di leggi dichiarate incostituzionali. Il problema si acuirà con la riduzione del numero dei parlamentari. Meno rappresentanti, più potere nella nomina, più controllo di pochi. Si chiama oligarchia.
In pieno mese di agosto questo giornale ha pubblicato un appello, «Il governo riparta dalla Costituzione», sottoscritto da tanti autorevoli osservatori. Ne riproponiamo il brevissimo, fulminante ed imprescindibile punto 1: «Legge elettorale, proporzionale pura: l’unica che faccia scattare tutte le garanzie previste dalla Costituzione. Per mettere in sicurezza la Costituzione stessa, cioè la democrazia».