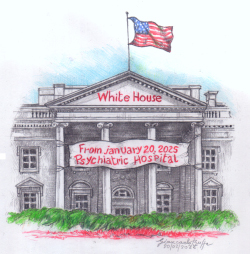C’è un punto di partenza che voglio chiarire con nettezza: nessuno mette in discussione il diritto alla legittima difesa, sancito dalla Carta delle Nazioni Unite, dall’articolo 51, e riconosciuto tanto nella Costituzione italiana (art. 11, che ripudia la guerra “come strumento di offesa”) quanto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che proclama solennemente il diritto alla sicurezza, alla dignità e alla libertà.
Difendersi è un diritto. Ma come, da chi, con quali mezzi e con quali fini? È su questo che si gioca oggi la partita politica e morale più profonda dell’Europa. E la proposta avanzata dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, con il piano “ReArm Europe”, non convince. Non per ideologia, non per sentimentalismo, ma per logica, storia e realtà dei fatti.
Una difesa comune? Senza una politica estera comune è un’illusione
C’è poi un punto fondamentale, troppo spesso ignorato nel dibattito pubblico: nessuna vera politica militare europea può nascere o funzionare senza una politica estera europea unitaria, coerente e condivisa.
La difesa non è solo una questione di eserciti, armi e spese. È, prima ancora, l’estensione della politica estera. Senza una visione comune sugli obiettivi internazionali, sugli alleati strategici, sulla gestione dei conflitti, sull’approccio al Mediterraneo, all’Africa, all’Asia, ogni esercito europeo rimarrà un contenitore vuoto, o peggio, uno strumento di interessi nazionali in concorrenza tra loro.
Oggi l’Unione Europea non ha una voce unica nel mondo. Non ha un seggio autonomo all’ONU. Non ha un ministro degli Esteri con potere esecutivo. I 27 Stati membri continuano a esprimere posizioni divergenti sulla Cina, sul Medio Oriente, sulla guerra in Ucraina, sulle relazioni transatlantiche.
In questo contesto, parlare di “difesa comune” senza una politica estera comune è come costruire il tetto senza le fondamenta. È un gesto simbolico, retorico, o peggio, un alibi per lasciare ogni Stato libero di armarsi come preferisce, senza alcuna regia politica sovranazionale.
Una vera difesa europea potrà esistere solo quando esisterà una diplomazia europea, autonoma dai blocchi, credibile, dotata di strumenti e visione. Solo allora si potrà parlare con serietà di sicurezza europea, perché la sicurezza non è solo protezione dai missili: è una strategia di convivenza nel mondo.
L’Europa della difesa… o dei 27 arsenali?
La proposta è chiara: un totale di 800 miliardi di euro per armare gli Stati membri. Di questi, 150 miliardi verranno prestati dall’Unione, attraverso uno strumento finanziario gestito con il coinvolgimento della Banca Europea per gli Investimenti. Gli altri 650 miliardi saranno spese “liberate” grazie alla decisione politica di escludere gli investimenti in armamenti dal Patto di Stabilità. In sostanza: chi può, spenda. E chi non può? Si arrangi.
Non si tratta dunque di costruire un esercito europeo, un sistema condiviso, un’architettura politica e militare integrata. No: si tratta di incentivare i singoli Stati a potenziare i propri arsenali, senza coordinamento, senza standard comuni, e senza un comando politico unitario.
Questa non è una politica europea di difesa. È una resa all’idea che ciascuno debba pensare per sé, armandosi quanto può, e magari comprando armi da chi gliele offre prima e meglio. È la negazione di quel principio di unificazione progressiva che l’Unione Europea ha posto al centro della sua missione.
L’Europa nasce dalla guerra, per superare la guerra
I padri fondatori dell’Europa – De Gasperi, Adenauer, Schuman, Monnet – non sognavano un’Europa forte perché armata, ma un’Europa forte perché capace di impedire la guerra tra europei. La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio nacque per rendere impossibile un nuovo conflitto tra Francia e Germania. La stessa Costituzione italiana, nata dalla Resistenza, mette il ripudio della guerra non alla fine, ma nel cuore del proprio patto fondativo.
Eppure, oggi, a ottant’anni dalla fine della Seconda guerra mondiale, ci troviamo di fronte a una retorica che invoca il riarmo come necessità storica, come inevitabile reazione al “nuovo mondo brutale” che ci circonda. Lo si fa nel nome della sicurezza, ma senza un’analisi seria dei rischi reali e delle alternative possibili.
Ma davvero l’Europa è indifesa?
Facciamo un esercizio di realtà. La Russia ha circa 146 milioni di abitanti, e nel pieno della guerra in Ucraina fatica a sostenere un’offensiva di lungo termine contro un solo Stato confinante. L’Unione Europea conta più di 450 milioni di cittadini, una spesa militare superiore del 58% a quella russa, un numero di effettivi paragonabile, e un’alleanza militare – la NATO – che, nonostante le incertezze americane, resta formalmente attiva, vincolante e operativa compreso l’articolo cinque.
Non si tratta di sottovalutare la minaccia russa. Ma neppure di sopravvalutarla al punto da perdere lucidità strategica. La Russia non ha le forze né la logistica per occupare militarmente l’Europa occidentale. Il suo arsenale nucleare, certo, è potente, ma ha una funzione dissuasiva. Nessuno “conquista” un Paese usando le armi atomiche: lo annienta. Ma se lo annienti, non puoi tenerlo, né governarlo.
In altre parole: l’equilibrio deterrente esiste già. Allora la domanda è: a cosa serve oggi un riarmo massiccio e disordinato? Segui il denaro, e capirai.
In ogni grande svolta geopolitica, è lecito porsi una domanda antica e fondamentale: “cui prodest?” A chi giova tutto questo?
Esistono think tank – RAND Corporation, CSIS, Carnegie Europe, RUSI – che analizzano, producono scenari, influenzano decisioni. Ma molti di questi centri ricevono finanziamenti diretti e indiretti dalle grandi aziende del comparto bellico: Lockheed Martin, BAE Systems, Northrop Grumman, Raytheon, Leonardo. La “ricerca” si intreccia con la produzione, la strategia con il profitto. I risultati? Spesso perfettamente allineati con gli interessi dei finanziatori.
Nessuno scandalo, se lo si dichiara. Ma è un errore politico gravissimo prendere per “scienza oggettiva” ciò che è spesso prodotto di lobbying e marketing. Un esempio è Procopio da Cesarea, nel VI secolo, quando scriveva due versioni della storia: quella ufficiale, per l’imperatore Giustiniano, e quella segreta (Anekdota), per la verità.
La differenza è che oggi l’aneddoto viene pubblicato come rapporto ufficiale, e il dibattito pubblico si costruisce intorno a ciò che è stato pensato per vendere, non per comprendere.
La guerra costa. Ma la pace è un investimento.
Spendere per la difesa non è un tabù. Ma bisogna capire quanto, come e a scapito di cosa. Con 800 miliardi si potrebbero: costruire ospedali, scuole, università; potenziare la transizione ecologica; garantire un reddito minimo europeo; finanziare un sistema sanitario paneuropeo; sostenere l’Ucraina anche con strumenti civili, umanitari, diplomatici.
Invece, cosa faremo? Comprare aerei e missili, ciascuno per conto proprio, perpetuando la frammentazione già esistente: Rafale, Mirage, Eurofighter, F-35; Leopard, Leclerc, Ariete, Twardy… E ognuno con il proprio software, i propri pezzi di ricambio, le proprie forniture. Altro che “efficienza”. Resteranno 27 Stati maggiori della difesa e altrettanti dell’esercito della marina e dell’aviazione. Migliaia di generali…
Se davvero volessimo una difesa comune, un’economia di scala, una interoperabilità vera, il primo passo sarebbe fermare questo caos di arsenali nazionali e creare un unico corpo europeo, una filiera europea, un controllo democratico comune. Non c’è nulla di questo nel progetto della von der Leyen.
Siamo all’alba di una nuova corsa agli armamenti? La storia ci ammonisce: le grandi corse agli armamenti non hanno mai garantito la pace, ma spesso l’hanno solo rimandata fino alla prossima esplosione. Le Conferenze dell’Aia del 1899 e 1907, nate per promuovere il disarmo e regolare la guerra, furono rapidamente spazzate via dallo scoppio del primo conflitto mondiale. Tutti i Paesi europei si sentivano minacciati, e per questo si armavano. Nessuno voleva davvero la guerra, eppure la guerra venne. Perché le paure accumulate, le armi acquistate e le alleanze opache fecero da miccia a un incendio globale.
Oggi vediamo il ritorno di quella logica. Si parla di deterrenza, ma si tace sulla diplomazia. Si costruiscono arsenali, ma non sedi negoziali. La parola “pace” è scomparsa dal lessico politico. E se c’è un sintomo di malattia culturale in Europa, è questo: aver reso la pace un argomento sospetto.
Un’ultima domanda: a cosa serve l’Europa?
Torniamo alle origini. L’Europa nasce perché i singoli Stati, da soli, hanno fallito. Hanno costruito nazionalismi, colonialismi, guerre. L’Unione Europea è stata una risposta, fragile ma nobile, a secoli di violenza. Allora chiediamoci: che Europa vogliamo costruire oggi? Un’Unione fondata su 27 bilanci della difesa, 27 industrie belliche, 27 logiche di potenza? O un’Unione che abbia il coraggio della cooperazione, del dialogo, della sicurezza condivisa? Io credo ancora che l’Europa possa essere una potenza di pace. Che possa parlare con autorità nel mondo non perché ha più missili, ma perché ha più idee, più diritti, più fiducia nella convivenza.
Per questo mi oppongo al piano così com’è. Per questo chiedo: fermiamoci. Riflettiamo. Discutiamo. E se davvero dobbiamo costruire una difesa europea, facciamolo insieme, nel rispetto delle regole, della democrazia e del nostro destino comune.
Come diceva Aldo Moro: “la pace si costruisce. Non si compra.”