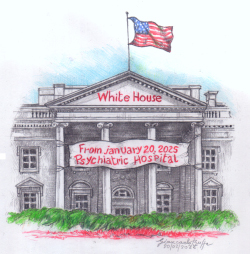“Regalo un rifugio a te e ai piccoli,
i piccoli addormentati come pulcini nel nido.
Non camminano nel sonno verso i sogni.
Sanno che la morte è in agguato.
Le lacrime delle madri sono ora colombe
che li seguono, trascinandosi dietro
ogni bara.”
Hiba Abu Nada, 20/10/2023, uccisa da
bombe israeliane lo stesso giorno in cui
aveva postato questi versi.1
1 Il brano fa parte di una poesia “Rifugio” inserita nella raccolta La terra più amata. Voci della letteratura palestinese, a cura di Wasim Dahmash (traduttore del presente testo), Tommaso Di Francesco, Pino Blasone, Manifestolibri, Roma 2024, pp. 262
Chissà che cosa avrebbe scritto oggi Nuto Revelli, ufficiale degli Alpini nella tragica missione in Russia prima, comandante partigiano poi, e autore del testo di quello splendido canto partigiano che è Pietà l’è morta, la cui musica risale a una canzone – Il ponte di Perati – cantata dagli Alpini ai tempi della Prima guerra mondiale. Chissà se l’orrore del genocidio del popolo palestinese in corso in questi mesi, senza che nessuno riesca a fermarlo, avrebbe trovato modo e spazio per esprimersi nei versi di una canzone di rabbia e di lotta. Allo stesso tempo un inno alla pietà per quelle vittime della ferocia e della stupidità umana. Come è appunto Pietà l’è morta. Come si ricorderà, nel 1949 Adorno aveva dichiarato che «scrivere una poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie» Con questo aforisma, diventato subito famoso – oggi si direbbe virale - non voleva certo stilare un atto di morte per un intero genere letterario quanto segnalare una estrema difficoltà, anche per un pensiero critico, di misurarsi in modo congruo con le problematiche di un sistematico sterminio, cioè un genocidio. Inoltre segnalava che quel genocidio fissava una cesura epocale nella storia umana e del pensiero. Tanto è vero che Adorno cercò in seguito di precisare il senso di quel suo aforisma, senza peraltro disconoscerlo. Nel saggio “Meditazioni sulla metafisica”, che conclude il volume Dialettica Negativa, apparso per la prima volta in Germania nel 1966, scrive «Forse dire che dopo Auschwitz non si può più scrivere una poesia è falso: il dolore incessante ha tanto il diritto ad esprimersi quanto il martirizzato ad urlare. Invece non è falsa la questione, meno culturale, se dopo Auschwitz si possa ancora vivere, specialmente lo possa chi vi è sfuggito per caso, e di norma avrebbe dovuto essere liquidato…». Purtroppo la seconda parte di questa sua previsione si è più volte verificata nella storia del dopoguerra.
Ma la prima, un’autocritica implicita dopo il fitto dibattito fra intellettuali di tutto il mondo successivo alla sua dichiarazione del ’49, libera il dolore dalla cappa di silenzio o meglio dalla paura e dall’orrore che il suo richiamo, il suo tornare alla memoria, il suo esprimersi può creare in tutti noi. Quel dolore anzi va esplicitato, urlato, raccontato nei modi più precisi e nelle forme più efficaci. E’ un modo per combatterlo, perché le circostanze tremende che lo hanno generato possano non verificarsi più. Questo è il senso e il valore della memoria. Ma perché ciò accada bisogna che le parole siano precise, congrue ad esprimere l’accaduto o ciò che sta accadendo.
Il termine più appropriato: genocidio
Non ci può essere un mal riposto pudore a chiamare le cose con il loro nome per timore di turbare qualcuno o fare torto all’unicità esperienziale di un determinato popolo, l’ebraico in questo caso. Per questa ragione chiamare la mattanza in corso a Gaza con il termine più appropriato – genocidio – è una questione politicamente, giuridicamente e storicamente rilevante, come giustamente afferma Gilles Keppel in un suo recente scritto.1 Nel titolo del suo libro usa il termine olocausto al plurale – cosa quasi indicibile fino a non molto tempo fa – pur ribadendo l’unicità della shoah, per le dimensioni e le modalità di quell’orrendo genocidio del popolo ebraico della diaspora, quindi perseguito in ogni luogo ciò fosse possibile, non solo nei campi di concentramento, luoghi tecnicamente adibiti all’omicidio seriale.
Chi infatti può dimenticare Babji Jar, nei pressi di Kiev, ove tra il 29 e il 30 settembre del 1941 furono uccisi 33.771 persone di religione ebraica, secondo il computo puntualmente riportato dalle autorità militari tedesche (ma la mattanza continuò anche nei giorni successivi, massacrando rom, disabili e comunisti, o ritenuti tali, fino ad arrivare a cifre incalcolabili). O scordare il massacro di Odessa, compiuto da truppe tedesche e romene, tra il 22 e il 24 ottobre 1941, comparabile per dimensioni, forse addirittura superiori, a quello di Babji Jar.
Ma purtroppo alla shoah hanno fatto seguito altri massacri genocidiari, come quelli in Ruanda e nella ex Jugoslavia sul finire dello scorso secolo. In sostanza la giusta sottolineatura del carattere specifico e unico della shoah va ribadito, ma non per negare ad altri tragici avvenimenti caratteristiche che li fanno rientrare nell’orrendo computo dei genocidi che l’hanno preceduta (si pensi a quello degli armeni) o che l’hanno seguita. Non aveva certo torto Shakespeare quando scriveva che “il male che gli uomini compiono sopravvive loro;/il bene è spesso sepolto con le loro ossa.”2
La Convenzione del 1948
E’ bene quindi ricordare quali sono le condizioni che definiscono secondo il diritto internazionale un genocidio. La Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre del 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio del 1951, le indica con chiarezza negli articoli 2 e 3.3 L’articolo 2 precisa che: ”… per genocidio si intende ciascuno degli atti seguenti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religiose, come tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; e) trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.”
L’articolo seguente stabilisce che: “Saranno puniti i seguenti atti: a) il genocidio; b) l'intesa mirante a commettere genocidio; c) l'incitamento diretto e pubblico a commettere genocidio; d) il tentativo di genocidio; e) la complicità nel genocidio.” Per definire e sostenere l’accusa di genocidio è dunque necessario e sufficiente che si realizzi una delle situazioni previste nell’articolo 2 della Convenzione. Israele è certamente colpevole di almeno quattro di questi crimini. Il quinto, ovvero il trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo all’altro, può essere escluso per il semplice fatto che i bambini vengono uccisi in loco, a casa loro, dai soldati dell’Idf. L’intenzione di distruggere un popolo tagliandone radici e virgulti è ben chiara nelle modalità aggressive dell’esercito israeliano. Le testimonianze al riguardo sono molteplici, una vera carrellata degli orrori; provengono sia dal personale sanitario internazionale, sia da alcune coraggiose ammissioni di membri dell’Idf.
L’obiettivo della Convenzione è prevenire il genocidio
La foglia di fico dei cosiddetti “effetti collaterali” non nasconde più alcuna vergogna, se mai lo ha fatto. Un bambino colpito più volte e in più parti del corpo da proiettili non può essere vittima di un errore, ma solo di un mirato e criminale cecchinaggio. Il predecessore nella stessa funzione di Francesca Albanese - oggi nel mirino di sanzioni Usa per avere rivelato in un documentato rapporto la responsabilità attiva di aziende americane nel finanziamento e nel sostegno ad operazioni militari israeliane - il giurista canadese Michael Lynk, che è stato Relatore speciale dell’Onu per i Territori palestinesi occupati dal 2016 al 2022, ha chiarito che “il punto della Convenzione sul genocidio del 1948 non è fornire prove agli storici del futuro perché stabiliscano se questo o quello era o no un genocidio. Il punto è prevenirlo” e, aggiungo io, impedire che nel futuro si ripeta in altri luoghi e in altre forme, ma con la stessa barbara carica omicida. Ma, continua Lynk, “i leader del nord del mondo non hanno imparato la lezione: stanno seduti a guardare un genocidio in diretta senza prendere alcuna azione decisiva né contro Israele né contro gli Stati Uniti. […] L’articolo 3 della Convenzione del 1948 vieta chiaramente anche la complicità nel genocidio […] Gli Usa lo sanno, eppure continuano a fornire armi. Questa decisione li rende complici del crimine di genocidio”.4
Anche la Ue, con il suo sostanziale immobilismo da un lato e lo schiacciamento sulle posizioni iper filoatlantiche dall’altro, non può tirarsi fuori da questa responsabilità. Siamo tutti complici e colpevoli se non riusciamo a bloccare la marcia del genocidio.
Nelson Mandela sulla questione palestinese
Una quindicina di anni fa, Nelson Mandela scrivendo al giornalista Thomas Friedman del New York Times, affermava: “L’apartheid è un crimine contro l’umanità. Israele ha privato milioni di palestinesi della loro proprietà e della loro libertà. Ha perpetuato un sistema di grave discriminazione razziale e disuguaglianza. Ha sistematicamente incarcerato e torturato migliaia di palestinesi, contro tutte le regole della legge internazionale. Esso ha sferrato una guerra contro una popolazione civile, in particolare bambini.”5 In sostanza Mandela riteneva che la questione palestinese fosse la grande questione morale irrisolta del XXI secolo. Sulla base di questa eredità il Sudafrica ha portato Israele davanti alla Corte internazionale di giustizia con l’accusa di genocidio. Anche Lynk si inserisce in questa accorata denuncia quando afferma che “Gaza è il punto di rottura della legge internazionale: se le regole molto severe su come si conducono guerre e occupazioni non vengono osservate e addirittura apertamente violate, la crepa sarà fatale e distruggerà il diritto internazionale e le Nazioni unite”6.
Le dimensioni del massacro genocidiario
Intanto il teatro dell’orrore diventa sempre più tremendo più si cerca di valutare e studiare l’impatto in termini di vite umane del genocidio in atto a Gaza. Il bilancio delle vittime appare ad un esame più approfondito addirittura maggiore di quello stimato dal ministero della salute della Striscia. Uno studio indipendente realizzato da ricercatori di varie università di Londra, degli States, della Norvegia e di quella di Lovanio in Belgio stima, alla data del 5 gennaio 2025, le vittime palestinesi direttamente dovute ad azioni militari come circa 75mila, e comunque certamente fra le 64mila e le 86mila. A queste vanno aggiunte, nella misura di 8mila, quelle che si riferiscono a cause conseguenti, anche se non direttamente, alla guerra in atto. La stima alla stessa data da parte del ministero della salute di Gaza era pari a 45.650, il 39% in meno. I risultati della ricerca devono ancora passare la tradizionale revisione per essere pubblicati da una rivista scientifica, ma l’autorevole Nature accredita di serietà e di attendibilità la ricerca tanto da averne pubblicato un’ampia sintesi.7 Altre ricerche hanno valutato persino queste cifre come inferiori alla realtà, soprattutto se si considerano i morti per fame.
Ma non è indispensabile per noi rincorrere questi numeri in continuo accrescimento per capire che il genocidio è in corso. Se si affama una popolazione, se si privano i neonati del latte materno, vista la sottonutrizione delle madri, se si impedisce l’arrivo di aiuti alimentari in misura sufficiente, se si giunge fino a calcolare il minimo di calorie necessarie per la semplice sussistenza delle persone e conseguentemente determinare la quantità di aiuti “necessari” e poi si spara sulle persone che accorrono ai centri di smistamento provocando continue stragi, cosa avvenuta in maniera sistematica da quando è stata imposta la militarizzazione della distribuzione degli alimenti, se si fa tutto questo sistematicamente e continuativamente non si possono nutrire dubbi che è in atto un genocidio, che va chiamato con il suo nome, proprio perché bisogna fermarlo.
La guerra delle calorie
La “guerra delle calorie” non è neppure una novità dell’ultima ora. E’ dal 2008 che gli israeliani decidono quale debba essere il consumo calorico per ogni palestinese. Raed Sabbah, un medico palestinese così riferisce a un giornalista: “Immaginate cosa significhi, per un padre, dipendere interamente dal proprio oppressore per nutrire i suoi figli. Immaginate cosa significhi sapere che quello stesso oppressore decide quante calorie può ricevere suo figlio, con quale cibo si può sfamare ed in che tempi. Ed immaginate, infine, che, nel silenzio, tutto questo va avanti da quasi venti anni”. Ovviamente con un peggioramento drammatico dall’inizio dell’invasione israeliana di Gaza in poi, ove tali scelte sono diventate una strategia pianificata.
Un rapporto dell’International Crisis Group ci fa sapere che “Dal luglio 2024 fino al cessate il fuoco del gennaio 2025, le restrizioni israeliane hanno limitato il Programma alimentare mondiale a fornire meno di 1.600 calorie al giorno per persona.” Molto meno di prima. La compagnia americana a cui Israele ha affidato la gestione degli aiuti, la Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), ha aumentato leggermente la quantità di calorie a 1.750 giornaliere, ma solo nei centri di distribuzione “fortificati” ovvero militarizzati, dove, appunto, i destinatari degli aiuti vengono presi di mira con svariati strumenti di morte. Lo stesso Onu ha reso noto i dati sulle vittime colpite nei pressi dei centri di assistenza: “Fino allo scorso 7 luglio abbiamo registrato 798 uccisioni, di cui 615 nelle vicinanze dei siti gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation e 183 presumibilmente sulle strade per arrivare ai centri di assistenza”.8 In ogni caso tale quantità di calorie è assolutamente insufficiente per persone già fortemente debilitate, il che equivale ad accompagnarle alla morte per fame facendo finta di aiutarle.9
Ma tutto ciò non si deve sapere, o quantomeno se ne deve conoscere il meno possibile. Ecco perché il governo israeliano impedisce l’ingresso ai giornalisti stranieri nella Striscia di Gaza. La violazione dell’articolo 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani, fondamento internazionale della libertà di stampa, è apertamente calpestata. Non solo, ma le autorità israeliane vietano persino l’ingresso ai media dalla propria frontiera verso un territorio esterno ai suoi confini. Le petizioni e gli appelli giunti da associazioni di operatori dell’informazione, fra i quali l’Ordine italiano dei giornalisti, sono caduti nel vuoto. Sui pochi reporter e operatori palestinesi pesa l’intero onere di informare e documentare sulla guerra in corso. Non a caso ne sono stati uccisi circa 200 e 150 feriti. La notizia non embedded si paga con la vita. Una situazione che non ha precedenti nella pur lunga e tragica storia delle guerre in giro per il mondo.10
Il terrorismo dei coloni in Cisgiordania
Così come poco trapela dei continui assalti dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania. Almeno fino a quando l’aggressività dei coloni non supera una certa soglia che mette in imbarazzo lo stesso governo di Tel Aviv, come è accaduto nel caso di un assalto dei coloni alle stesse forze armate israeliane che ne volevano in qualche modo contenere gli eccessi.11 Ma la cosa che desta ancora più indignazione è la tattica usata dai coloni: quella di mandare avanti dei bambini, armati di sassi e di coltelli per preparare l’assalto nei confronti dei palestinesi che poi viene eseguito dalle milizie dei coloni adulti. Spesso sono bambini israeliani, istruiti allo scopo, che si fronteggiano con bambini palestinesi.12 Ma purtroppo non si tratta delle baruffe dei ragazzi della via Pal.
Così la strazio prosegue. Le voci di momentanei cessate il fuoco si alternano con l’incrudelirsi degli attacchi dell’Idf a Gaza. Allo stesso modo avviene altrove, sul fronte russo-ucraino, ove la guerra continua, malgrado non ci sia giorno in cui non appaiano notizie distensive, poi immediatamente smentite dai fatti, su una possibile pace, il cui raggiungimento sperato non avverrebbe peraltro che sui presupposti già delineati pochi mesi dopo l’invasione russa ma che gli inglesi, interpreti dell’Occidente, hanno respinto nel mito della vittoria sulla Russia, in realtà per la più terrena convenienza alla prosecuzione della guerra. Sia in Ucraina che in Medioriente l’evocazione della pace produce l’effetto contrario, ovvero l’intensificarsi della guerra. Sarebbe cosa ben diversa – ma non accade – se invece di parlarne intendendo il contrario si lavorasse effettivamente per la pace, radunando i “volonterosi” non per fornire armi, alimentando il conflitto, ma per costruire concretamente le condizioni per la sua fine. Ma ciò non è quello che sta accadendo, malgrado che in Ucraina il numero dei renitenti alla chiamata alle armi sia in continua crescita e che in Israele recenti sondaggi indichino come il 74% dei cittadini di quel paese sia favorevole a un accordo con Hamas che preveda il rilascio di tutti gli ostaggi in cambio della fine della guerra a Gaza, fermando quindi il genocidio.13
Superare il senso di impotenza
Che fare, quindi, perché avanzi effettivamente la causa della pace? E’ inutile nasconderlo. Di fronte alla profondità della tragedia in corso, di fronte alla possibilità, tutt’altro che definitivamente esclusa, che la cosiddetta “guerra dei 12 giorni” contro l’Iran possa riprendere di vigore a trascinare il mondo verso un conflitto nucleare, siamo presi da un senso di impotenza. Abbiamo cercato e lo stiamo facendo ogni giorno, di dare vita a mobilitazioni ed azioni contro la guerra. Senza mai raggiungere però quell’ampiezza, dimensione e intensità che ebbe la manifestazione mondiale del 15 febbraio del 2003 e che tuttavia non fu in grado di impedire l’aggressione statunitense all’Iraq.
Recentemente in Italia si sono realizzate manifestazioni di ragguardevoli dimensioni. Stabilendo collegamenti con movimenti e associazioni nel resto dell’Europa che promettono di durare e di potere costituire una catena di resistenza all’avanzare dello spirito bellico e delle sue conseguenti scelte in materia di spesa militare. Tuttavia non si è riusciti a superare diversità e divisioni malgrado si sia di fronte ad un genocidio in corso, un processo di riarmo europeo in atto, un avvicinarsi del pericolo di una terza guerra mondiale. Si cinguetta sul “fronte largo”, ma questo viene ridotto ad un’esigenza elettorale finalizzata alla conquista di una maggioranza o, vista l’ingiusta legge elettorale tuttora in vigore, di una maggioranza di una minoranza per arrivare al governo. Così anche il rischio di una guerra nucleare e la necessità primaria di opporvisi, viene assorbito da logiche incongrue di alleanza partitica. In questo modo ci mischiamo ai sonnambuli che camminano incoscienti del burrone fatale che li aspetta.
L’immobilismo complice della Ue
Non possiamo attenderci nulla da questa Unione europea, tutta assorbita da una rigida osservanza filoatlantica, come si evince chiaramente dal fluviale documento, in 197 punti, varato dal Parlamento europeo che punta tutto a prepararsi ad una guerra contro la Russia e a infilare nel campo dei nemici la Cina.14 Anziché porsi sulla scena mondiale come soggetto autonomo di pace. Forse un episodio vale più di tante parole per descrivere lo stato in cui versa la Ue.
La famosa giornalista palestinese Rula Jebreal così racconta nel suo ultimo libro la delusione provata al termine di incontri fatti insieme a una delegazione di diplomatici statunitensi e israeliani, con rappresentanti del Parlamento europeo a Bruxelles nel maggio del 2023. L’obiettivo era lanciare un allarme sul genocidio in atto nei territori palestinesi: “Ma il mio sconforto fu totale quando mi resi conto che la disponibilità ad accogliere il nostro allarme era scarsa o nulla. Pina Picierno15 mi aveva chiamata qualche giorno prima del mio arrivo a Bruxelles per chiedermi se volevo parlare all’Europarlamento dei crimini di guerra commessi dalla Russia in Ucraina. Accettai subito e senza riserve. Era chiaro che Putin stava usando la fame come arma di guerra e stava bombardando ospedali e infrastrutture civili, commettendo crimini di guerra; il mio impegno per la difesa del diritto umanitario internazionale, dell’ordine internazionale basato sulle regole e dei diritti umani è universale, non selettivo in base all’identità della vittima o del carnefice. Quando però, in una seduta privata, presentammo alla deputata i nostri allarmi rispetto all’escalation in corso nei territori palestinesi e ai rischi che si delineavano, il suo entusiasmo, così palpabile quando si parlava di Russia, si affievolì visibilmente. Accolse il nostro racconto con indifferenza e freddezza e non trovò niente di meglio da dire che suggerirmi di reindirizzare le mie rimostranze all’ambasciatore israeliano a Bruxelles”16.
La coraggiosa scelta del Pkk
Eppure non tutto il mondo presenta lo stesso orrido volto. Mentre la guerra pare diventata il sostituto della politica e non solo la sua prosecuzione con altri mezzi, vi sono donne e uomini che rinunciano dopo quarant’anni alla lotta armata e in una emozionante e commovente cerimonia bruciano i loro Kalashnikov. “Noi combattenti per la libertà, donne e uomini, ci siamo uniti al Pkk in tempi diversi e da regioni diverse. Oggi qui rispondiamo all’appello del leader del popolo kurdo Abdullah Ocalan. […] Distruggiamo volontariamente le nostre armi, davanti a voi, come gesto di buona volontà e determinazione […] Vista la crescente pressione fascista, lo sfruttamento in tutto il globo e il bagno di sangue in corso in Medio Oriente i nostri popoli hanno più che mai bisogno di una vita pacifica, libera, uguale e democratica”. E’ una sfida ardita e coraggiosa quella lanciata, direi al mondo intero, dai rappresentanti del popolo kurdo. Una sfida per la pace nella nonviolenza. Riuscirà? La dialettica democratica e la non violenza non possono essere praticate da una parte sola. Sappiamo che ora la parola passa a Erdogan. Non bisogna abbandonarsi a troppo facili ottimismi. Ma la scelta fatta in primo luogo da Ocalan non è fondata solo sulla speranza, ma anche sull’osservazione di quanto è cambiato nel contesto della Turchia e fuori da essa. La mano tesa ai kurdi è arrivata dalle forze che sono sempre state le più accanite nel discriminarli e combatterli. Un segno di un cambiamento reale, dovuto anche alla nuova situazione generata in Medioriente dalle guerre scatenate da Israele. In fondo - si commenta - Ocalan aveva detto: “i turchi verranno da noi” e sono venuti.
Luce d’Eramo, nella prefazione scritta alla prima edizione del 1988 – ma sembrerebbe scritta ora - del volume di poesie e prose palestinesi già citato, concludeva con parole di un poeta palestinese, Tawfiq Zayyad, che per lei rappresentavano una spinta alla vita, un flusso ininterrotto di speranza: “Sulle macerie e sotto la macerie,/ sulle soglie divelte delle case/e sopra i pali della luce,/e sui rami degli alberi infuocati,/ e nei vicoli arati dai carri,/è veloce il passaggio delle cose”.17
Il summit dei Brics
Conviene allora volgere lo sguardo da un’altra parte del mondo, dove sta prendendo corpo una iniziativa che ci auguriamo sia destinata a costituire un’alternativa agli attuali assetti di potere mondiali.
Preceduto dalla riunione a Rio de Janeiro dei rispettivi ministri degli esteri, si è tenuto tra il 6 e7 luglio scorsi, sempre nella capitale brasiliana, con la presidenza di Lula da Silva, il 17° Summit dei paesi Brics+. Come al solito l’attenzione dei mass-media italiani, del filone mainstream, non si può certamente dire che sia stata di particolare riguardo, con l’eccezione, non a caso e che quindi va segnalata, del Sole 24 Ore. Anzi abbiamo letto e assistito a commenti peggio che riduttivi, poiché l’attenzione è stata posta prevalentemente sulle assenze di alcuni leader e sul tentativo di fornirne la spiegazione.
Se quella di Putin è facilmente comprensibile, visto il mandato di cattura che pende sulla sua persona emesso dalla Corte penale internazionale – che il Brasile essendo firmatario dello Statuto di Roma, avrebbe dovuto in teoria eseguire -, come pure non appare difficile scusare l’assenza di Pezeshkian, visto che gli attacchi recentemente subiti dal suo paese da parte di Usa e Israele lo tengono impegnato in patria, l’attenzione dei nostri mass-media si è concentrata sull’assenza di Xi Jimping intorno alla quale si sono sbizzarrite diverse ipotesi. Da quella che imputava al leader cinese l’intenzione di non compromettere presunte relazioni future con Trump, a quella che lo vedeva geloso dell’accoglienza riservata da Lula a Modi, il primo ministro indiano, che assumerà il prossimo anno la presidenza dei Brics+ com’era del resto previsto, fino alla più ridicola ricostruzione basata sul fatto che la moglie di Lula, durante la sua visita a Pechino, avrebbe rivolto critiche sgradite a TikTok. Insomma il gossip non è mancato neppure in questa occasione.
Tutto ciò corrisponde esattamente alla tendenza a guardare il mondo dal buco della serratura, non cogliendo l’essenziale di questo incontro internazionale. L’altra tecnica usata per trascurarlo è stata quella, già usata del resto in occasione della riunione dei ministri economici, di considerare l’appuntamento deludente rispetto alle attese, ovvero un flop o giù di lì. Infine si è tentato di derubricare l’importanza della dichiarazione finale in 126 punti che toccano, si può dire, tutto lo scibile umano e tutte le questioni politiche, sociali, economiche e culturali che abbiamo di fronte in questo mondo squassato dalle guerre.
In realtà la dichiarazione finale riprende il filo già tessuto nel precedente Summit di Kazan del 21-24 ottobre 2024, alla luce dei nuovi accadimenti ed ampliando il quadro delle tematiche prese in considerazione. Come già in quella dichiarazione il linguaggio è coerente con la sede internazionale nella quale è stato elaborato il documento, che deve tenere conto delle diverse condizioni e sensibilità in cui si trovano i rappresentanti dei vari paesi.
Ci ha pensato il presidente Lula a tagliare alla radice ogni possibilità di letture artatamente minimaliste, aprendo l’incontro con un discorso dai toni assai netti sulle questioni più dolorose in campo, accusando la Nato di “investire nella guerra piuttosto che nella pace”, ribadendo, non senza avere prima condannato l’azione di Hamas del 7 ottobre, che è impossibile “rimanere indifferenti al genocidio perpetrato da Israele a Gaza, all’uccisione indiscriminata di civili innocenti e all’uso della fame come arma di guerra” e denunciando “le violazioni dell’integrità territoriale dell’Iran”, cosa che il governo brasiliano aveva già fatto nei confronti del conflitto russo-ucraino e quindi auspicando il cessate il fuoco e una pace duratura anche in questa parte del mondo.
I passi avanti rispetto al summit di Kazan
A conti fatti il Summit di Rio de Janeiro è stato tutt’altro che una occasione fallita o un brusco ridimensionamento. Anzi. La riunione ha consolidato quanto già si era venuto costruendo nei precedenti vertici ed ha aperto nuove possibilità di adesione. L’ultimo punto della dichiarazione finale saluta l’ingresso tra i Brics+ dell’Indonesia, e contemporaneamente ha accolto altri nuovi paesi come partner con l’impegno di integrare da subito la loro partecipazione nei lavori del gruppo. Si tratta di Bielorussia, Bolivia, Kazakistan, Cuba, Nigeria, Malesia, Thailandia, Vietnam, Uganda, Uzbekistan. In questo modo i Brics, tra membri (ai cinque fondatori si sono aggiunti Egitto, Etiopia, Iran, Emirati Arabi Uniti e appunto Indonesia) e partner, rappresentano il 41% del pil globale, se calcolato in parità di potere d’acquisto (ppa), il 37% del commercio mondiale e oltre il 50% della capacità energetica totale. Ma non si tratta di fermarsi solo alla misurazione delle quantità. Infatti il presidente Lula ha dichiarato che “abbiamo minerali strategici che sono essenziali per la transizione energetica. I Brics concentrano l'84% delle riserve mondiali di terre rare, il 66% del manganese e il 63% della grafite”. Non poco e non poca cosa, come si vede. Inoltre altri 30 paesi del Sud del mondo hanno già fatto richiesta di diventare membri. Soltanto per un veloce raffronto si tenga conto che gli Usa, sempre a parità di potere d’acquisto, rappresentano il 15,5% del pil globale e il G7 il 29%. In forte declino rispetto al 52% registrato nel 1990.
In altre parole se si guarda il mondo non con l’occhio rivolto al “mitico” Occidente ma in direzione dell’Oriente e di quello che si è in uso chiamare il Global South se ne ha un’altra visione. Quella di una parte del globo che diventa sempre più consistente dal punto di vista del numero e della rilevanza dei Paesi che la compongono, dell’incremento demografico in corso, della capacità produttiva, dell’innovazione tecnologica e persino di un “uso pacifico dello spazio extra-atmosferico”, come si legge in uno dei punti del lungo documento finale, che è opportuno ricordare, seppure in estrema sintesi per dare conto dell’ampiezza delle tematiche affrontate.
La dichiarazione finale di Rio de Janeiro
I leader dei vari paesi presenti hanno riaffermato lo spirito del Brics, fondato su rispetto reciproco, solidarietà e inclusione, impegnandosi nei tre pilastri: politico-sicurezza, economico-finanziario e culturale. Con l’obiettivo principale di costruire un ordine internazionale più rappresentativo e giusto.
Si è sottolineata la necessità di riformare la governance globale, in particolare l’Organizzazione mondiale della sanità e l’Organizzazione mondiale del commercio, puntando in particolare a garantire maggiore legittimità e rappresentanza per i paesi in via di sviluppo. E’ stata sviluppata una forte critica alle misure coercitive unilaterali e forte sostegno a un sistema commerciale equo e multilaterale.
E’ stata ribadita la richiesta di una riforma dell’Onu, in particolare di un Consiglio di sicurezza più rappresentativo, con seggi per Brasile e India.
La Dichiarazione sui finanziamenti climatici invita i paesi sviluppati a offrire risorse e protezione delle foreste tropicali (con creazione del fondo “Tropical Forests Forever”).
E’ stata adottata una dichiarazione specifica sulla governance globale dell’Intelligenza artificiale, affidata all’Onu, ed è stato costituito un gruppo di lavoro per la sicurezza Ict (Information and Communicatios Technology), promuovendo norme e cooperazione tra le nazioni.
L’impegno per la pace è stato sottolineato anche dalla ripresa del tema del disarmo nucleare, oltre che dalla richiesta del cessate il fuoco nei conflitti in corso, mentre è stata rivolta una forte critica all’uso delle sanzioni come strumenti unilaterali. E’ stato chiesto il rafforzamento del ruolo dell’Oms e l’impegno nel trattato pandemico globale, per garantire accesso equo a farmaci, vaccini e servizi sanitari.
Con particolare forza è stato ribadito l’impegno contro discriminazioni, razzismo, in favore dei diritti delle donne, delle persone con disabilità e delle generazioni future.
Infine è stato approvato il Piano economico Brics 2025–2030 per rafforzare il commercio, la digitalizzazione, la finanza e lo sviluppo; ed è stato assicurato il sostegno alla presidenza brasiliana del 2025 e l’appoggio a quella indiana del 2026.
In conclusione la Dichiarazione finale del Brics 2025 riflette un impegno strategico del blocco: rafforzare il Sud Globale, promuovere riforme multilaterali, impegnarsi per la sostenibilità climatica, garantire sicurezza tecnologica e sanitaria, difendere i diritti umani ed espandere la cooperazione economica e culturale, nella ricerca costante della pace.
La composizione dei Brics
A nessuno può sfuggire naturalmente la eterogeneità dei paesi facenti parte dei Brics+ e dei partners in attesa di un totale coinvolgimento. Abbiamo repubbliche come monarchie, paesi di diversissima struttura sociale, paesi le cui istituzioni democratiche sono a dir poco fragili. Queste diversità spingono esponenti e commentatori del filone mainstream persino a negare l’esistenza del blocco in quanto tale dal punto di vista geopolitico. Ma non tutti la pensano allo stesso modo. Ad esempio Giuliano Noci, editorialista sul Sole 24 Ore, scrive, si potrebbe dire persino con enfasi, che “l’assenza di unanimità [fra i Brics] non ne indebolisce il peso: il solo fatto che esista un blocco alternativo, capace di generare proposte strutturali è già rivoluzionario”. Ed è infatti così che dobbiamo guardare all’esistenza dei Brics e al loro allargamento. Se si pensasse di paragonarli al movimento dei non allineati, sorto nella conferenza di Bandung del 1955 o addirittura di considerarli una loro tardiva propaggine, si andrebbe fuori strada. Il testo e il contesto nel quale si sono sviluppate queste due importanti esperienze internazionali sono troppo diversi. Negli anni cinquanta il mondo usciva dalla Seconda guerra mondiale, era rigidamente diviso in blocchi. Da un lato gli Usa dall’altro l’Unione sovietica, con i rispettivi campi. Il movimento dei non allineati voleva rompere la logica dei due blocchi stabilendo indipendenza e distanza da entrambi. Il che si accentuò con la critica radicale del Partito comunista cinese al sistema sovietico, giunto ad identificarlo come una forma di socialimperialismo. Ed era evidente che la spinta del processo rivoluzionario di decolonizzazione diventava il perno e il riferimento di fondo di quella forma di aggregazione.
Ora il mondo è mutato. Assistiamo, con tutti suoi contorcimenti e colpi di coda, al declino del secolo americano e al contempo alla crescita della Cina e dell’India con modalità del tutto diverse rispetto a quelle che si erano manifestate nel corso di altre transizioni egemoniche, ad esempio con guerre mondiali come fu nel novecento il passaggio dello “scettro” dal Regno Unito agli Usa.
L’obiettivo del multilateralismo
Il problema che oggi si pone è dunque duplice, da un lato come evitare che questo passaggio egemonico in corso ormai da anni, ma affrettato dalla crisi delle magnifiche sorti e progressive della globalizzazione finanzcapitalista, possa avvenire senza trascinare il mondo intero in una nuova guerra mondiale dal potenziale distruttivo incalcolabile; dall’altro lato come si possa evitare che all’unipolarismo se ne sostituisca un altro, seppure di diverso segno e posizionamento geografico.
E qui incontriamo il grande tema della dedollarizzazione e di come e con cosa sostituire il primato del dollaro. Pretendere la nascita di una nuova moneta per il commercio internazionale che rifletta un paniere di divise monetarie dei Brics resta un obiettivo, ma la sua realizzazione è ancora prematura. Intanto però, come si è visto anche in questa conferenza, si rafforzano le tendenze a stabilire relazioni commerciali e a regolare i relativi pagamenti internazionali attraverso lo scambio di monete locali, ovvero evitando l’ingombrante presenza del dollaro. E’ un passo in avanti, non è ancora la soluzione del problema. Ma sapevamo che la strada verso la grande utopia di John Maynard Keynes, sconfitta a Bretton Woods, la creazione di una moneta che aveva chiamato bancor, è ancora lunga. Ma l’importante è che il cammino sia concretamente iniziato. Trump stesso pare averlo capito: infatti ha iscritto il Brasile tra i cattivi e minaccia dazi elevatissimi e sanzioni a non finire, sia primarie che secondarie, nei confronti dei Brics+ e di collabora con loro. Ma questo non sembra particolarmente spaventare i membri del gruppo. In particolare la Cina che non si lascia facilmente intimorire. Per questo economisti come Paul De Grauwe e Marcello Messori, per citarne solo alcuni, indicano alla Ue che il modo giusto per reagire alla cupidigia di potere di Trump, manifestata con i dazi, non è quello di chinare il capo ma di guardare verso questo gruppo di paesi. Parole destinate, per ora, a restare nel vento.
1 Gilles Kepel Olocausti. Israele, Gaza e lo sconvolgimento del mondo dopo il 7 ottobre, Feltrinelli, Milano 2024.
2 William Shakespeare The Tragedy of Julius Caesar, 1599 (secondo alcuni storici 1600-1601)
3 Per quanto riguarda l’Italia l’autorizzazione alla ratifica e all’ordine di esecuzione nel nostro paese sono stati dati con la legge 153 dell’11 marzo 1952; mentre la data dell’adesione risale al 4 giugno dello stesso anno e l’entrata in vigore è del 2 agosto sempre del 1952.
4 Vedi Chiara Cruciati “Israele non può più essere un’eccezione del diritto”. Intervista al giurista Michael Lynk, il manifesto del 4 luglio 2025
5 https://contropiano.org/news/internazionale-news/2013/12/07/mandela-e-un-terrorista-020803
6 Intervista cit.
7 Vedi Andrea Capocci, “Nella Striscia è genocidio, non propaganda. Centomila morti. Lo studio che rivede le stime al rialzo” in il manifesto del 5 luglio 2025
8 La nota dell’Onu è riportata in Roberto Bongiorni “Gaza, Onu: in sei settimane uccisi 798 civili in fila per il pasto” in Il Sole 24 Ore del 12 luglio 2025
9 Vedi R.Es “La lunga guerra delle calorie di Israele per affamare Gaza”, Il Sole 24 Ore del 9 luglio 2025
10 Vedi Roberto Bongiorni “Guerra senza verità, senza giornalisti” in Il Sole 24 Ore del 5 luglio 2025
11 Vedi Francesca Caferri “Israele, i coloni assaltano la base Idf, si infiamma la Cisgiordania. Netanyahu: ‘Anarchici’ [!?!]” in la Repubblica del 1 luglio 2025
12 Ne parla Roberto Bongiorni: “A Burin la nuova arma di guerra dei coloni sono i bambini” in Il Sole 24 Ore del 12 luglio 2025
13 Il sondaggio è stato diffuso dall’emittente Channel 12, ne dà notizia in una nota redazionale Il Sole 24 Ore del 12 luglio 2025
14 Vedi: Risoluzione del Parlamento europeo 2 aprile 2025 sull’attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune – Relazione annuale 2024, in particolare ai punti 84,85,86,87,88
15 Vicepresidente del Parlamento europeo facente parte del Partito democratico
16 Rula Jebreal Genocidio. Quello che rimane di noi nell’era neo-imperiale Piemme, Milano 2025, pp. 295; il racconto dei colloqui a Bruxelles si trova nelle pp. 80 e 81”
17 La terra più amata cit. Luce d’Eramo, prefazione alla prima edizione, maggio 1988, riportata nell’ultima edizione a pag. 8.