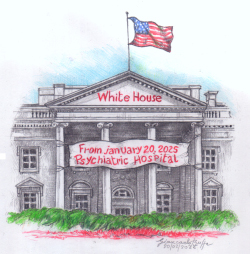Non è infrequente che la sinistra, che conveniamo chiamare d’alternativa, cada spesso vittima delle proprie analisi, anche di quelle giuste, e delle conseguenti definizioni. Il che è un sintomo di una certa staticità di capacità analitica, di una fissità intellettuale che inibiscono la possibilità di cogliere, ancor più di prevedere, i cambiamenti in atto. Con la conseguenza di trovarsi sempre un poco in ritardo, fuori tempo e spiazzati rispetto alle modificazioni in atto a livello internazionale e interno, come sul terreno politico ed economico, istituzionale e sociale. Ed è chiaro che si tratta di una constatazione in primo luogo autocritica.
Un caso classico è rappresentato dal termine globalizzazione e ciò che esso sottende e intende. Già prima della grande crisi economico-finanziaria che prese le mosse dallo scoppio della bolla dei subprime nell’estate del 2007 negli USA, si potevano cogliere elementi concreti che indicavano come l’espansione di quell’insieme di processi economici e produttivi che afferivano alla globalizzazione, incontrava degli ostacoli, battute d’arresto e inversioni di marcia. Il sopraggiungere della crisi pandemica e poi della guerra in Europa ha ulteriormente accentuato quelle tendenze, tanto che oggi parlare di deglobalizzazione – un termine, come vedremo, troppo riassuntivo rispetto alla complessità dei processi in corso e quindi generico – non stupisce quasi nessuno.
Certamente la “globalizzazione non è finita” come ribadisce Moises Naim (la Repubblica, 10 ottobre 2022), ma sicuramente non è la stessa che abbiamo conosciuto negli ultimi lustri del secolo scorso. Chi opera direttamente sul terreno economico, cioè le imprese, grandi o piccole che siano, sanno invece cogliere per tempo tali cambiamenti – ne va della loro sopravvivenza – e cercano di porvi rimedio – ovviamente non sempre con successo – sia rispetto alle scelte individuali sia fornendo elementi per l’elaborazione di una più generale strategia che poi fa irruzione nel dibattito politico.
In una recente intervista (Il Sole 24 Ore, 18 novembre 2022) Alberto Dal Poz, già presidente di Federmeccanica, a commento dei buoni risultati della sua azienda che opera nel campo della componentistica per automotive, afferma che “sono risultati che non mi stupiscono, il mondo sta affrontando una nuova fase in termini di globalizzazione e questa crescita del nostro export lo conferma”, il che lo ha spinto a cambiare strategia dal momento che “il nuovo assetto della globalizzazione porta a un riordino delle catene di fornitura”. Ma i cambiamenti non riguardano soltanto quest’ultimo aspetto, sono di carattere ben più generale.
L’ultimo Outlook dell’Ocse (Il Sole 24 Ore, 23 novembre 2022) esprime un giudizio appena un poco meno drammatico di quello espresso pochi giorni prima dal Fondo monetario internazionale. Entrambi non escludono per l’anno a venire una recessione globale, ma certamente per il secondo la possibilità che si realizzi è maggiore. In ogni caso nessuno dei due vede la situazione economica mondiale in termini rosei. Lo scenario tracciato dall’Ocse mette in evidenza che la crescita mondiale rallenterà nell’anno in corso al 3,1% (nel 2021 era del 5,9%), per calare al 2,2% nel 2023 e risalire di poco, al 2,7%, nell’anno successivo. Il segretario dell’Ocse, Mathias Cormann, ha quindi parlato non di recessione, ma di “un periodo di marcata debolezza”. Sottigliezze linguistiche? Forse non solo, ma comunque la stessa Ocse, quasi a premunirsi delle eventuali accuse di avere sbagliato previsione, avverte che più gravi carenze nelle forniture di gas avranno effetti a cascata su crescita e inflazione, e quindi la stagflazione potrebbe diventare una dolorosa realtà. Soprattutto in Europa, aggiunge l’Ocse, dove la guerra non accenna a finire. D’altro canto – sia detto qui per inciso – la definizione della Russia quale Stato terrorista assunta nella risoluzione della Assemblea parlamentare della NATO, tenutasi a Madrid pochi giorni fa, cui ha fatto seguito un’analoga risoluzione del Parlamento europeo, non può certamente facilitare il cessate il fuoco e l’avvio di trattative. Per l’Ocse quindi la crescita nel biennio 2023-2024 sarà dovuta soprattutto ai paesi emergenti dell’Asia, mentre Europa, Nord America e Sud America non potranno che offrire scarse performance.
Se estrapoliamo questa ultima previsione, surrogata da analisi ben precise degli andamenti economici delle varie zone del mondo, dalla contingenza internazionale nella quale siamo immersi e la consideriamo in un più lungo periodo, trova nuova e rafforzata conferma quella tendenza alla transizione egemonica mondiale che sta spostando il baricentro economico e politico – anche se non ancora militare – da Ovest ad Est già individuata da diversi autorevoli studiosi, quali ad esempio Giovanni Arrighi (ne cito uno solo, poiché qualsiasi elencazione comporta un’esclusione indebita). Questi dati dell’Ocse non costituiscono quindi una sorpresa, quanto una conferma. Già nel 2016, considerando il Pil (indicatore barbaro come sappiamo, ma finora non sostituito) a parità di potere d’acquisto, si poteva misurare il superamento della Cina nei confronti degli USA, anche se la misurazione del Pil pro capite indica tuttora un’enorme distanza tra i due paesi, a favore degli USA, seppure in diminuzione. Si può ben dire che tutta la politica americana, in particolare quella estera, degli ultimi anni è finalizzata a riconquistare il primato del “secolo americano”. Con maggiore determinazione e rozzezza con Trump, con il suo protezionismo e la sua guerra dei dazi, ma continuando anche con Biden. Ne è un esempio la guerra russo-ucraina che non è solo un confronto fra NATO e Russia – innescata dalla tragica decisione di Putin di invadere l’Ucraina – ma, neppure troppo sullo sfondo, fra USA e Cina.
La grande crisi economico-finanziaria, quella pandemica e il conflitto in corso hanno solo affrettato i processi di deglobalizzazione, le cui cause, a ben vedere, erano implicite nello stesso successo della globalizzazione nella sua fase montante. Quella fase non era tanto caratterizzata dall’incremento del commercio internazionale o dalla finanziarizzazione del capitale. Ciò che la distingueva veramente da altre fasi di globalizzazione che il mondo aveva conosciuto – dal momento che lo scavalcamento delle frontiere e l’uniformazione del mondo al proprio modello sta nel dna della borghesia, come ci ha insegnato Marx – era la decentralizzazione produttiva, ovvero un gigantesco processo di centralizzazione senza concentrazione, seguendo una felice definizione di Riccardo Bellofiore. Ed è questo specifico processo che ha mostrato la corda. Siamo di fronte a una significativa contrazione nel processo di delocalizzazione e di articolazione delle strutture produttive guidate dalle grandi multinazionali. Trump e i suoi epigoni sono stati preceduti dai processi reali e materiali. Già nei cinque anni che precedevano il 2007 i profitti delle multinazionali erano crollati del 25% (vedi “In retreat. The multinational company is in trouble” in The Economist, 28.01.2017). La quota di profitti globali rappresentata dalle multinazionali era scesa in dieci anni dal 35% al 30%. Diversi sono i motivi che hanno determinato questa situazione e i processi di reshoring, ovvero di ritorno in patria delle produzioni in precedenza delocalizzate ben prima della più recente sfilacciatura delle catene delle forniture e della formazione del valore. Fra questi certamente vi è stata la rilevante diminuzione della possibilità di arbitraggio fiscale con le amministrazioni locali e, per converso, l’incremento di diritti e salari dei lavoratori. Nonché la migliore adattabilità delle imprese locali alle esigenze di consumo delle popolazioni. Senza scomodare qui le teorie sulla caduta tendenziale del saggio di profitto e le complicate discussioni che questa comporta, si può dire che la profittabilità degli investimenti all’estero in impianti fissi e in lavoro umano sono da tempo diminuite. Questo non significa che l’impresa capitalistica abbia smesso di espandersi spazialmente. Solo che vengono avanti nuove figure, slegate almeno in grande parte da investimenti fissi nei territori. Si tratta del cosiddetto platform capitalism, capitalismo da piattaforma. Come osservava il citato articolo dell’Economist se le tradizionali multinazionali arretrano, “le stars di Silicon Valley, da Uber a Google, stanno ancora espandendosi all’estero”. E l’elenco potrebbe continuare.
Di fronte alla crisi della globalizzazione, colpita a sua volta dalle specifiche crisi che ha prodotto, si è cercato di rispondere con il ritorno in auge di misure protezionistiche da parte dei singoli stati e in primo luogo da parte degli USA con America first. La spinta al protezionismo è piuttosto un prodotto di questi processi di deglobalizzazione che non la loro causa, anche se poi le idee, soprattutto quelle sbagliate, come avvertiva Keynes, hanno a loro volta agito e sospinto i processi decisionali delle classi dirigenti. Proprio per questo è però necessario introdurre una precisazione sul concetto di protezionismo, per evitare che esso assuma un carattere puramente negativo. Vi è anche un protezionismo che si presenta come leva possibile e utile entro un governo pragmatico dell’economia. Quello cui faceva riferimento Federico Caffè in un noto articolo pubblicato su L’Astrolabio nel 1977 il cui titolo era costituito da un interrogativo retorico, rivelatore fin dall’inizio del punto di vista del suo autore: “È consentito discutere di protezionismo economico?”. Infatti Caffè, dopo avere criticato con il consueto garbo, ma con tagliente durezza, le tesi del “liberismo oltranzistico”, concludeva il suo breve scritto con il seguente ammonimento: “L’accorto dosaggio tra le misure intese ad accrescere le esportazioni, mantenendole competitive, e quelle rivolte a favorire l’incremento delle produzioni sostitutive di importazioni andrebbe ricercato su un piano di mutua comprensione e di reciproco rispetto. Colpire ogni voce di dissenso con l’addebito di tendenza all’autarchia è mera espressione di arroganza intellettuale ben poco lodevole”.
Ma ora siamo in tutt’altra situazione. Il protezionismo viene brandito come una bandiera, prima per conquistare voti, poi per solidificare un ancora incerto consenso. E viene fatto non da un paese debole e fragile, ma dalla potenza fin qui leader nel processo di globalizzazione. E non vi è dubbio che le pulsioni protezionistiche abbiano raggiunto pure l’Unione europea, anche se la sua natura, quella di essere un’entità che opera tra l’intergovernativo e il sovrannazionale, non la qualifica come federale e quindi la questione si pone in modo assai diverso che non gli USA. È stato però osservato – e giustamente – che la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha fatto proprio lo slogan inventato da Emmanuel Macron “Un’Europa che protegge”. Il che non ha fatto mancare contrasti con gli USA e la Cina, allarmati da un atteggiamento di chiusura dell’Europa che li priverebbe di un mercato di sbocco privilegiato. Del resto il premio Nobel per l’economia Maurice Allais aveva già discettato di una scelta esplicita, la “preferenza europea” a favore delle imprese del nostro continente. Ne ha ampiamente ragionato Paolo Gerbaudo in una serie di articoli pubblicati sull’online Le Grand Continent. Ma per mettere in atto una vera politica protezionista a livello Ue sarebbe necessario che la stessa si dotasse di un unico bilancio, di una politica industriale ed economica coerente con obiettivi comunemente scelti. Tanti Pnrr, seppure vagliati dagli organi europei, non sono sufficienti a formare una politica precisa. E ci vorrebbe soprattutto una crescita del mercato interno unico che potrebbe essere sostenuta solamente da uno slancio della crescita in settori innovativi e da un aumento delle retribuzioni che incrementino la capacità d’acquisto. Di tutto ciò nulla si vede. Anzi la politica della Ue si concentra sulle scelte della Bce che ora puntano al rialzo dei tassi e quindi non certo a politiche espansive, seguendo con molti ondeggiamenti le scelte della Federal Reserve americana.
Gli aspetti fin qui descritti, seppure assai sommariamente, non mettono fine alla globalizzazione, ma ne modificano caratteristiche e modulazioni. La tendenza più evidente è quella a una regionalizzazione, tanto a Ovest quanto a Est. Che comportano un accorciamento delle filiere e l’avvicinamento tra sistemi economici e modalità di consumo più simili. Così si esprime il cosiddetto multipolarismo in campo economico. Gli americani sono stati antesignani. Si pensi al NAFTA, il travagliato trattato di libero commercio con Messico e Canada. Oppure più recentemente, dall’altra parte del mondo, al RCEP (il Regional Comprensive Economic Partnership) tra Cina, Giappone, Australia, Filippine, Corea del Sud, Indonesia e altri paesi dell’area Asia-Pacifico.
Ma tutto ciò non riporta la situazione ai tempi del primato dello Stato-nazione. Malgrado che il nazionalismo sia una delle cifre finanche esasperate della destra che attualmente ci governa. Giorgia Meloni, che nella sua conferenza stampa sulla manovra economica ha ripetuto infinite volte la parola “nazione” laddove altri prima di lei avrebbero detto “il nostro paese”, è del resto filo-atlantica e in questa chiave del tutto europeista. D’altro canto i disastri della Brexit hanno raffreddato di molto gli anti-europeisti. Piuttosto siamo di fronte al riproporsi e al rinnovarsi di idee che erano state influenti negli anni novanta. Mi riferisco in particolare a quelle contenute in un famoso libro di Kenichi Ohmae “La fine dello Stato-nazione”, che parlava dell’emergere delle economie regionali. Solo che proporle in una fase montante della globalizzazione era un conto, farlo entro un processo di quasi recessione economica globale è ben altro. Anche per questo il progetto di autonomia differenziata che viene avanzato nel nostro paese è una sciagura non solo per il Sud d’Italia ma per quello di tutta l’Europa e per la Ue stessa.
In conclusione vale la pena di tornare a ricordare che in più parti della sua opera Karl Marx ribadisce che “la tendenza a creare il mercato mondiale è data immediatamente con il concetto stesso di capitale. Ogni limite si presenta qui come un ostacolo da superare” (Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, La Nuova Italia, 1978, vol. II, p. 9). Tuttavia questa “astrazione concreta” deve fare i conti con l’intreccio tra capitale e Stato, tra capitale e territorialità. Quest’ultima va ben al di là dei confini dello Stato-nazione e dà luogo a inedite configurazioni spaziali e geografiche. Il capitale quindi ridisegna e “crea” lo spazio, come ha scritto David Harvey (La crisi della modernità, Il Saggiatore, Milano, 1993). In questo processo il capitalismo assume diverse forme nella sua lunga storia. Quella individuata nella felice definizione di “capitalismo estrattivo” è solo uno degli ultimi esempi.
Sandro Mezzadra ci ricorda al riguardo la crescente importanza del lavoro dei geografi nel cogliere le mutazioni proteiformi del sistema capitalistico. Due di questi, Jamie Peck e Nick Theodore, hanno insistito, coniando la definizione di “capitalismo variegato”, sul “poliformismo dinamico” del capitalismo contemporaneo capace di una “produzione sistemica di differenziazione geo-istituzionale” (“Le geografie della crisi e dello sviluppo capitalistico. Appunti preliminari e ipotesi di ricerca” in euronomade.info, 29.03.2013). Ed è con questa nuova e mutante dimensione del capitalismo che le teorie protezioniste devono fare i conti.