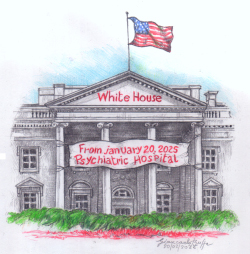Il dibattito in corso (da anni) sull’educazione sessuale (e sentimentale) nelle scuole ha implicazioni che vanno al di là del mondo della scuola: investe le radici della cultura di cui si nutre la società. Sesso, passioni e sentimenti sono strutture portanti del mondo in cui viviamo; espellerle dall’educazione scolastica, come si fa ora, ma anche confinarle in un recinto affidato a un “addetto ai lavori” (e chi, poi? E a che titolo?), pregiudica tutto quello che si fa a scuola. E i risultati si vedono: a scuola i più si annoiano mentre il contatto con i fatti fondamentali della vita viene affidato ai siti porno (e il tema della morte alla cronaca nera o ai reportage da un fronte di guerra).
Ma in realtà sesso, passioni e sentimenti attraversano e potrebbero impregnare tutte le materie curricolari dell’educazione scolastica a tutti i livelli. Basterebbe farli emergere. Costumi e comportamenti, strutture delle famiglie e delle parentele, questioni di genere, forme delle relazioni sia tra pari che tra chi è sopra e chi è sotto nella gerarchia sociale, ma soprattutto la relazione fondamentale tra uomini e donne, quella in cui si radicano (e da cui si sradicano) sia il patriarcato che, con esso, tutte le altre forme di potere, sono tutte chiavi di lettura ineludibili tanto di una storia che di una geografia che guardino ai popoli, quanto del diritto, delle letterature, delle arti, delle filosofie, delle religioni.
Ma sesso, passioni (dal verbo patire, subire) e sentimenti (dal verbo sentire) riguardano ovviamente anche tutto il mondo animale nei suoi rapporti reciproci, e tutto il vivente, perché anche le piante e i fiori si accoppiano, patiscono ed esercitano tra loro attrazioni o repulsioni; il che, attraverso lo studio della chimica e della biologia potrebbe aiutarci a considerare meno misterioso, meno oggetto di pruderie e più ordinario molto di quello che succede tra gli esseri umani. E persino il sostrato minerale del pianeta, se considerato con un approccio olistico e non minerario, può essere letto attraverso reazioni di affinità e di rigetto, mentre astronomia e astrofisica potrebbero aiutarci a ridimensionare la nostra pretesa di unicità.
Dunque? Fare dell’educazione sessuale e sentimentale una materia curricolare a sé stante è una sciocchezza, a prescindere dalla figura a cui è assegnato il compito di svolgerla, mentre la presenza dirompente di sessualità, passioni e sentimenti dovrebbe poter affiorare e imporsi in tutte le materie di insegnamento. Ma ad opera di chi?
Solo immaginare gli attuali insegnanti (con le dovute ma scarse eccezioni) impegnati a fare proprio un approccio del genere alle rispettive materie, o in sedute interdisciplinari, evidenzia in modo incontrovertibile l’abisso che separa scuola e vita. Intanto ci sono i vincoli istituzionali: programmi ministeriali e offerte formative sono concepiti per eludere una tale prospettiva. Ma poi nessuno, o quasi, sarebbe in grado di farlo (né lo sono altri, anche al di fuori del mondo della scuola). D’altronde anche la formazione all’Università ha per lo più evitato di metterli in grado non solo di farlo, ma anche solo di prospettarlo.
Allora, come superare, posto che lo si voglia – e sicuramente lo vorrebbero le nuove generazioni, quelle che la scuola la frequentano come allievi e allieve, studenti e studentesse - questa impasse? C’è una sola via: auto-educarsi insieme, studenti e insegnanti, aprendosi al contraddittorio anche all’interno di una comunità educante più vasta. Si tratta di fare delle lezioni, in aula e fuori aula, una palestra di confronto, non tra “opinioni” e “posizioni” diverse, ma tra diverse interpretazioni di fatti storici, sociali, biologici, artistici e letterari, a partire dalla loro conoscenza documentata. Interpretazioni che emergono da un libero interrogarsi sul senso di ciò che viene proposto come oggetto di apprendimento. Che cosa di meglio che farsi educare ai fatti della vita che più contano, soprattutto per i giovani, da chi quelle esperienze le ha fatte prima o lontano da noi, in altri contesti, con altre regole, rielaborandole con l’arte, la letteratura, il pensiero, la ricerca? O anche da quello che si svolge dalla notte dei tempi nel mondo del vivente, anche al di fuori della ristretta cerchia della specie umana? Anche questioni oggi così controverse come quelle del genere di appartenenza o di libera ascrizione ne verrebbero illuminate. Governare un processo del genere non è certo facile e richiede uno spirito di collaborazione tra le diverse “componenti” di una comunità educante, interne o esterne alla scuola, che la sua organizzazione odierna fa di tutto per distruggere e soffocare.
Ma è proprio dalla rivendicazione di aprire la scuola al confronto sui “fatti della vita” che può nascere e svilupparsi una rivoluzione culturale in grado di salvare dall’arteriosclerosi che le sta necrotizzando non solo la scuola, ma anche e innanzitutto quella che chiamiamo ancora “la nostra cultura” – in via di dissoluzione - e la nostra stessa “civiltà”.