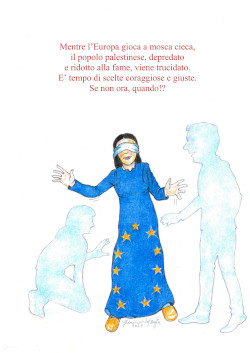«Non vi ho subito risposto», caro Bracco, «perché non sapevo veramente che rispondere al desolante resoconto della vostra situazione». Il destino del drammaturgo tacitato dal Duce lasciò interdetto Armand Bour, attore francese anni ’30, come lascia ancora esterrefatti noi, oggi. Un solidissimo autore napoletano di fama internazionale che però il Novecento postbellico si perse per strada invece di beatificarlo, sia per meriti artistici che per intransigenza antifascista quale nessun altro intellettuale non politico strictu sensu. Storia nota, ma non a tutti. Come la vicenda del Nobel che il fascismo praticamente gli strappò dalle mani.
E torniamo a Bour, che scrisse una lettera a Bracco perché vinto dal suo genio dopo aver recitato in alcune piéce: Francesco Soverina ha recuperato e tradotto nel libro Il caso Bracco – Una ferita non sanata(Alessandro Polidoro editore) la missiva, inedita, di cui abbiamo citato l’incipit e ora indicheremo l’epilogo. Questo: «(…) anche Zola dopo il suo J’accuse venne insultato da tutti e i suoi ultimi anni furono deplorevoli. Ma fu reso più grande dal suo comportamento. Vivete questa idea che è la sola vera. L’avvenire non è arrivato. Esso è per voi». Vi si compara dunque il coraggio dei due letterati, Zola e Bracco, l’uno per il caso Dreyfus l’altro per il diniego assoluto del Ventennio. Bour sbaglia però la previsione. L’avvenire non è stato per l’autore, morto a Sorrento nel ’43, a una manciata di settimane dalla destituzione di Mussolini (altra beffa).
La copertina del libro
Scambiamo
due chiacchiere con Soverina, che riaccende col suo testo l’attenzione
sul «caso»; richiamino necessario, a mo’ di vaccino, giacché nonostante
taluni sforzi storiografici Bracco non è stato ancora pagato.
Come ha scoperto la lettera di Armand Bour?
«L’ho
trovata nel Fondo Bracco-Del Vecchio conservato nell’archivio
dell’Istituto campano per la Storia della Resistenza, dell’antifascismo e
dell’età contemporanea - spiega -. Nel 2007 la nipote, Aurelia Del
Vecchio, ha versato tutta la documentazione in suo possesso raccolta nel
corso degli anni dal grande drammaturgo. È una fonte preziosa che
comprende anche un cospicuo epistolario. La lettera dell’attore Bour è
particolarmente significativa per il suo contenuto, in quanto fa
esplicito riferimento al momento in cui fu scritta (maggio 1933),
segnato dal dilagare della protervia fascista contro gli artisti
liberi».
Perché
Bracco è stato dimenticato? Persino la pagina su Wikipedia,
generalmente compilata dagli ammiratori più che da studiosi, è
striminzita.
«L’individuazione
e l’analisi delle ragioni della mancata riscoperta sono tra gli aspetti
principali del mio libro. Si è trattato di un caso artistico e
politico. Fu condannato al silenzio dal fascismo e colpevolmente rimosso
dall’Italia repubblicana. Sarebbe risultato imbarazzante rinverdire il
ricordo di un artista che durante il Ventennio - a differenza di
tantissimi altri intellettuali - non aveva accettato compromessi,
rifiutando vantaggi e onori pur di non piegarsi. Un percorso esemplare e
istruttivo, dunque, quello di Bracco, che rinvia all’accantonata resa
dei conti, da parte degli italiani, con il fascismo, tassello cruciale
del loro recente passato. A ciò si aggiunga il reinsediamento o il
perdurare, in posti-chiave delle istituzioni afferenti al mondo del
teatro, di uomini compromessi con il regime come Nicola De Pirro,
Leopoldo Zurlo e Silvio D’Amico. Ha pesato pure, non poco, la pigrizia,
la mancanza di coraggio dell’editoria e degli ambienti teatrali».
«Il
piccolo santo» di Bracco sembra anticipare un po’ la figura del prete
di Walter Siti che nell’ultimo libro, «Bruciare tutto», scrive di un
sacerdote che pur attratto da un ragazzino non cede alla tentazione. Ha
fatto scandalo (feroce dibattito sui media, ecc.). E il prete ‘santo’ di
Bracco come venne accolto negli anni Venti?
«L’opera,
messa in scena per la prima volta al Mercadante di Napoli nel 1912,
riscosse un grandissimo successo. Un regista del calibro di Luigi
Squarzina, che negli anni ’80 aveva in animo di rappresentarla, la
considerava un capolavoro, il migliore testo teatrale italiano del
Novecento unitamente al Cardinale Lambertini di Giovanni Testori. Al di
là del tema scabroso per l’epoca - l’attrazione di don Fiorenzo per una
giovane, figlia della donna sposata di cui il sacerdote si era
innamorato prima di diventare prete, ma con cui non aveva imbastito
nessuna relazione - Il piccolo santo si è ben presto segnalato come
un’opera che esplora il subconscio dei personaggi, anticipando di alcuni
anni il «teatro del silenzio», dell’«inespresso», lanciato in Francia
da Jean Jacques Bernard. Per tali motivi andrebbe riproposta sul
palcoscenico quest’opera di Bracco, nonché l’altro suo capolavoro, I
pazzi, il cui testo appena uscito (1922) ricevette ben 200 recensioni e
fu al centro di un’aspra polemica fra Adriano Tilgher e Lucio D’Ambra.
Sarebbe la via principale per far conoscere un autore a lungo
trascurato, a cui il regime fascista negò la possibilità di concorrere
al premio Nobel, non appoggiando la sua candidatura, la quale era stata
avanzata da un gruppo di intellettuali scandinavi, a riprova della stima
e della fama di cui Roberto Bracco godeva in Europa».
Come
mai anche la sinistra napoletana (e italiana) non ha mai ripreso, sia
pure in maniera interessata, la figura di Bracco quale paradigma di
«militanza» antifascista?
«Innanzitutto vorrei ricordare sia il numero de L’Italia liberata
(aprile 1944) - pubblicazione del Partito d’Azione interamente dedicata
a Roberto Bracco - sia la commemorazione data alle stampe nel 1945 dal
comunista nolano Vincenzo La Rocca, che nel 1947 terrà alla Camera dei
deputati un’orazione sul drammaturgo napoletano. Tuttavia, è vero che la
figura di Bracco non è stata valorizzata quale paradigma di ‘militanza’
antifascista e questo perché non rientrava nei canoni - per così dire -
classici dell’antifascismo clandestino di sinistra. Sul piano generale,
non sono da sottovalutare il clima da guerra fredda e l’imperversare
dell’anticomunismo che nel secondo dopoguerra hanno fortemente
condizionato il radicarsi di una coscienza antifascista nel Mezzogiorno e
le politiche della memoria. Comunque, sia pure in maniera
intermittente, sono stati esponenti della sinistra cittadina o studiosi
vicini ad essa a rievocare il percorso di un antifascista che, dopo
essere stato oggetto della violenza squadristica - gli venne devastata
la casa nel 1926 - e del controllo poliziesco della dittatura
mussoliniana, è diventato idealmente a Napoli l’anello di congiunzione
tra l’Italia del dissenso esplicito e l’Italia del dissenso carsico. Due
componenti, due pezzi d’Italia che, insieme con quella delusa e
duramente provata dalla guerra, hanno scritto la pagina resistenziale,
che si è aperta proprio qui, a Napoli, con l’insurrezione delle Quattro
Giornate».
Quanto
sarebbe utile la lezione di Bracco oggi sia in politica – terra di
trasformisti – sia nel campo morale laddove l’etica pubblica è resa
liquida, relativa, ambigua dal parlamentare scomposto su internet?
«Sicuramente
controcorrente risulterebbe la sua ‘lezione’, e proprio per questo
utilissima, anche se - temo - sarebbe poco ascoltata. Nell’Italia di
oggi, dove il trasformismo e la corruzione sono fenomeni palesi e
corposi, la sua dirittura morale, la sua coerenza intellettuale sono
beni difficili da trovare. Questo vale anche per l’Italia dell’epoca
fascista. Mentre Roberto Bracco veniva oscurato, non pochi gerarchi del
regime - tra cui Farinacci - accumulavano ingenti patrimoni, e numerosi
intellettuali, dopo aver talvolta compiuto veri e propri voltafaccia, si
mostravano inclini al più bieco opportunismo e servilismo».
Bracco si distinse da altri intellettuali italiani in modo evidente.
«Un
altro insegnamento o monito ci viene dalla sua figura: il dovere - in
un certo senso - per l’intellettuale, per l’artista di non rincorrere le
mode, di non inseguire il successo per il successo, ma di farsi
interprete del suo tempo, di fornire, con gli strumenti che gli sono
propri, chiavi di lettura per comprendere, per decifrare il presente
nelle sue dimensioni e implicazioni, assumendo - se è il caso, se le
circostanze lo impongono - posizioni non dettate da tornaconto
personale, ma dai principi e ideali in cui ci si riconosce. Bracco l’ha
fatto in tre momenti cruciali per la storia italiana ed europea,
manifestando la sua disapprovazione per l’ingresso dell’Italia nella
prima guerra mondiale; firmando nel 1919 - insieme con Croce, Einstein,
Russell, Barbusse, Zweig e altri - la Déclaration di Romain Rolland per
l’autonomia degli intellettuali dal potere politico; schierandosi nel
1924 contro il fascismo al fianco di Giovanni Amendola».