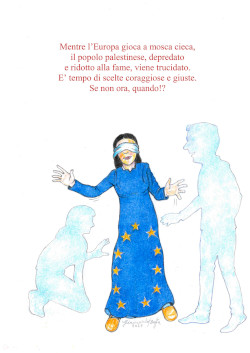L’attuale disciplina di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (Cpr) non è compatibile con la Costituzione, non rispettando in particolare la riserva di legge assoluta prevista dall’articolo 13, secondo comma.
La Consulta non ritiene però di poter porre rimedio a questa situazione di accertata incostituzionalità, ricadendo sul legislatore il «dovere ineludibile» di introdurre una «normativa compiuta, la quale assicuri il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona trattenuta». Una decisione che si fonda sul presupposto del rispetto del principio di leale collaborazione tra organi costituzionali. Ma quanto si può confidare sulla volontà dei poteri chiamati in causa? Di fronte all’inerzia di Governo e Parlamento che farà la Corte?
Com’è noto la storia delle sentenze “monito” non è incoraggiante, essendo rimaste perlopiù inascoltate. Tant’è che la Consulta si è dotata, nel corso del tempo, di uno strumentario processuale sin troppo ricco, per cercare di affermare la superiore legalità costituzionale in ogni caso. Anzi, può dirsi che l’ultima stagione è stata caratterizzata da una certa audacia e ha visto diverse e importanti sentenze forzare le regole processuali al fine di affermare le ragioni sostanziali di tutela dei diritti fondamentali compromessi: dalle decisioni del 2014 sulle leggi elettorali all’introduzione di meccanismi in grado di rimediare all’inerzia del Parlamento (additive, doppie pronunce, rinvio della decisione a data certa, definizione di una nuova normativa dedotta da principi rinvenibili nel sistema normativo vigente). In quest’ultimo caso la Corte è stata più cauta, nel doveroso rispetto della discrezionalità del legislatore. Tuttavia, a questo punto è lecito domandarsi cosa potrà succedere nell’ipotesi (direi più che probabile) che dovesse permanere la grave situazione lesiva di diritti fondamentali dentro le strutture dei Cpr. Non solo nell’eventualità che non vi fosse nessuna reazione da parte del legislatore, ma anche qualora la riserva di legge portasse a definire una normativa non rispettosa della dignità delle persone costrette nella propria libertà personale.
L’inerzia o l’uso in contrasto con la Costituzione del potere legislativo credo imporrebbe un intervento più incisivo della Corte se e quando dovesse riproporsi la questione di legittimità costituzionale in un prossimo futuro. Le occasioni rilevanti non mancheranno e l’opportunità (oltre alla non manifesta infondatezza) è in fondo scritta nella decisione oggi assunta. L’invito è dunque ai giudici di monitorare con attenzione la situazione e non esitare, nel caso in cui il legislatore non dovesse svolgere il suo «dovere ineludibile», ma anche nel caso di una nuova normativa non costituzionalmente compatibile, a chiedere di nuovo alla Consulta una seconda pronuncia che sia il coerente seguito dell’attuale. A quel punto sarà difficile per il giudice delle leggi sottrarsi ad una decisione nel merito, il cui esito è stato preannunciato sin d’ora.
Ma quale forma – quale tipo di sentenza – potrà essere adottata? Si tratterà di vedere il “chiesto” del giudice che solleverà la questione, sin d’ora però almeno una considerazione in base allo stato dei fatti può essere formulata.
La situazione drammatica e le modalità degradanti di detenzione amministrativa sono ben note e ormai acclarate dal giudice costituzionale. La Corte tiene a precisare – sin dalla sua prima sentenza, n. 105 del 2001 – che il trattenimento dei migranti irregolari non può essere equiparato a quello dei detenuti, non ha carattere sanzionatorio, rappresenta solo un’extrema ratio giustificata dalla necessità di verificare le condizioni per poter dare esecuzione nel più breve termine possibile all’accompagnamento alla frontiera. In ogni caso – com’è persino scritto nella disattesa normativa vigente – devono essere garantiti adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa allo status, l’assistenza e il pieno rispetto della dignità. Questi presupposti sono attualmente tutti smentiti dalla realtà: i “modi” di trattenimento degli stranieri, affidati quasi esclusivamente a fonti subordinate e ad atti amministrativi, sono di fatto più degradanti che non quelli, già assai poco rispettosi della dignità, dei detenuti nelle carceri.
La Corte scrive che l’ordinamento penitenziario non può rappresentare un punto di riferimento perché la detenzione amministrativa deve restare estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio. Ma se neppure questa tutela minima può essere applicata a chi è ristretto nella propria libertà personale «senza aver commesso reati» il vuoto di tutela costituzionale appare insopportabile, e irragionevole appare la disparità tra situazioni soggettive equiparabili almeno per quanto riguarda la comune limitazione della libertà. Le garanzie di cui al terzo comma dell’articolo 13 si devono applicare a chiunque sia sottoposto a restrizioni di libertà, la dignità deve essere garantita a tutte le persone, stranieri inclusi, poiché – scrive sempre la Corte – i diritti che la nostra Costituzione proclama inviolabili «spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani».
Che si debba auspicare l’estensione delle garanzie previste dall’ordinamento giudiziario per i migranti trattenuti in via amministrativa è certo anomalo, ma rispetto al vuoto di tutela costituzionale anche il poco è meglio del nulla.