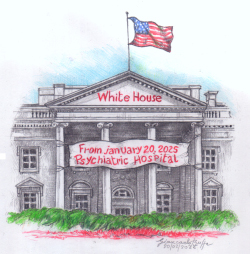L’Italia non è uno Stato federale come la Svizzera o la Germania, come gli Stati Uniti d’America o il Canada, ma durante tutta la gestione della pandemia ci si è comportati come se lo fosse, affidando alle regioni funzioni mai assegnate nel passato. Nel nostro Paese è in vigore solo un regionalismo “rafforzato”, con alcuni poteri delegati che non configurano però “Stati autonomi”. Insomma, le regioni-Stato sono un’invenzione dei loro presidenti, non un’interpretazione della nostra Costituzione.
Il conflitto tra potere centrale e poteri regionali a cui stiamo assistendo in queste ore è la conseguenza di una frammentazione della catena decisionale, ideata per coinvolgere nella gestione della crisi sanitaria (e delle sue conseguenze economiche e sociali) le forze politiche di opposizione che guidano le regioni più ricche del Nord, piuttosto che di obblighi costituzionali. Poiché le forze politiche di opposizione non si lasciavano coinvolgere in parlamento o a Roma, si è pensato di coinvolgere nelle regioni, aumentandone i poteri. Il risultato non è stato brillante, anzi. La pandemia ha spinto verso la “poliarchia”, e la poliarchia stava per degenerare in anarchia, con una interpretazione del tutto originale dell’autonomia differenziata: scaricare sul governo centrale le colpe delle misure drastiche prese per i singoli territori, attribuirsi i meriti qualora dovessero funzionare. Alcuni presidenti di regione si stanno segnalando più per una furbizia gretta che per una corresponsabilità istituzionale.
È, dunque, nel rapporto Stato centrale-regioni che si manifesta oggi il punto di maggiore crisi dell’articolazione istituzionale della nazione. Ed è venuta l’ora di prenderne atto e di cominciare ad uscire da questa paradossale situazione nella quale alla identica pandemia si risponde con venti differenti sistemi sanitari e con venti modalità diverse di farvi fronte. La necessità di ripristinare in tutti i suoi aspetti un sistema sanitario nazionale è la principale lezione che non dovremo dimenticare quando tutto (speriamo) sarà finito.
Ma chiedersi come si è arrivati a questa situazione, vuol dire anche fare un rapido tuffo nella mostra storia. La tradizione italiana è una tradizione municipalista non regionalista né tanto meno federalista. L’Italia non ha conosciuto differenze religiose, etniche, linguistiche o di altro tipo tali da giustificare un’organizzazione federale dello Stato. L’unica grande e storica differenziazione è quella tra Nord e Sud, cioè un divario economico non etnico, non religioso, non istituzionale.
La scelta federalista fu scartata nel 1861 per ragioni ampiamente note: l’accentramento era suggerito dalle profonde differenze economiche e sociali esistenti tra gli stati preunitari che avrebbero nuociuto, se non governate dal centro, alla nascita di una nazione forte, unita e autorevole anche nel confronto internazionale.
Il problema di un diverso assetto istituzionale si pose durante la discussione sulle caratteristiche dello Stato repubblicano subito dopo la fine del fascismo. Fu prevista in Costituzione la nascita delle regioni, ma ciò si realizzò solo nel 1970, cioè ben 22 anni dopo la sua approvazione. E nel corso degli anni cambiarono nettamente le posizioni dei principali partiti sulla questione. Il Pci e il Psi erano antiregionalisti perché pensavano che solo uno Stato accentrato poteva giovare alle esigenze delle masse popolari che rappresentavano, mentre la Dc, il partito d’azione e il partito repubblicano erano filo-regionalisti. Successivamente le posizioni cambiarono, con il Pci e il Psi favorevoli all’istituzione delle regioni e la Dc contraria.
Le forze di sinistra intravidero la possibilità di governare in Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, mentre la Dc temeva proprio questa eventualità. Si arrivò alla nascita delle regioni nel 1970 sia per la spinta dei socialisti (allora al governo) sia per una valutazione che si faceva strada tra le menti più illuminate del cattolicesimo democratico, cioè attutire i caratteri oppositivi e antisistema del Pci attraverso il suo coinvolgimento nella gestione dei governi locali. La seconda svolta si ebbe nel 2001. Il centrosinistra cercò di sopperire alle sue difficoltà di radicamento nel Nord del Paese, dopo la crisi di identità dell’universo operaio, sposando la causa federalista e avviando una gara con la Lega di Bossi a chi lo era di più: un errore storico e politico clamoroso. Si realizzò così una riforma del Titolo V della Costituzione affrettata e confusa.
E a quali esigenze corrisponde questa cessione di potestà da parte del governo centrale, almeno fino ad oggi? Essa è sembrata più un omaggio ai potentati locali, all’interno di ogni partito, che una necessità di migliorare la gestione della crisi. Ed è paradossale che tra i maggiori oppositori al governo centrale e tra i più accesi sostenitori dell’autonomia regionale ci sia proprio un rappresentante del Sud, e non del Nord, un membro del Pd e non della Lega. È Vincenzo De Luca a rappresentare tutti i limiti del regionalismo e tutte le insidie che questa cessione di podestà porta alla salute dei cittadini e a quel che resta del sistema dei partiti.