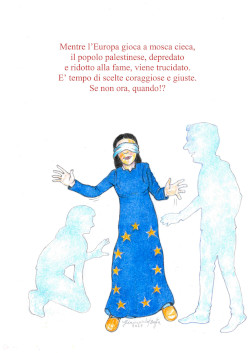Nel gennaio del 2025, mentre è in corso la guerra iniziata nel 2022 con l’invasione russa dell’Ucraina, il Parlamento europeo approva una Risoluzione che – oltre a definire «ingiustificata e illegale» l’aggressione; condannare il ricorso alla «disinformazione», anche con l’uso di «argomentazioni storiche distorte»; ricordare «l’imperdonabile» responsabilità dell’Unione sovietica nell’avvio «della Seconda guerra mondiale» con la firma del «patto Molotov-Ribbentrop del 1939» – al punto 14 «deplora il continuo utilizzo negli spazi pubblici di simboli dei regimi totalitari e chiede di vietare, all’interno dell’Unione, l’uso dei simboli nazisti e comunisti sovietici, così come dei simboli dell’attuale aggressione russa contro l’Ucraina» [1].
Questa risoluzione – che sembra ridurre l’esperienza comunista a quella dell’Unione sovietica – chiede quindi di vietare l’uso sia della svastica che della falce e martello, mettendo sullo stesso piano il nazismo e il comunismo. Per quanto riguarda l’Italia, tale equivalenza risulta poco accettabile, come è ovvio, per i partiti che sono oggi all’opposizione del governo Meloni. E infatti contro il paragrafo 14 hanno votato i parlamentari italiani del Partito Democratico, dell’Alleanza Verdi-Sinistra e del Movimento 5 Stelle; contro l’intera Risoluzione, invece, hanno votato solo AVS e M5S, mentre gli eurodeputati del PD non hanno partecipato al voto.
La Risoluzione, tuttavia, è stata approvata a larga maggioranza, senza che ciò abbia provocato accesi dibattiti sui mezzi d’informazione. Proteste che, invece, aveva suscitato un’altra Risoluzione del Parlamento europeo, del settembre 2019, anche questa approvata a larga maggioranza, che al punto 5 invitava «tutti gli Stati membri dell’UE a formulare una valutazione chiara» sui crimini e sugli «atti di aggressione perpetrati dai regimi totalitari comunisti e dal regime nazista» [2].
L’equiparazione fra nazismo e comunismo aveva prodotto nel 2019 – parliamo sempre solo dell’Italia – numerose e indignate reazioni anche per una ragione: mentre gli eletti del Movimento 5 Stelle si erano astenuti, il testo era stato approvato da quelli del Partito Democratico, nato nel 2007 dalla fusione di due partiti, la Margherita e i Democratici di Sinistra, eredi a loro volta, questi ultimi, del Partito Comunista Italiano! Mi limito qui a citare, tra le tante voci contrarie a un’equiparazione contestata da studiosi qualificati, la presa di posizione di Gianfranco Pasquino, professore di scienza politica nell’Università di Bologna che, ritenendo «profondamente sbagliato mettere sullo stesso piano il totalitarismo nazista e quello comunista», ricordava che «Per quanto variamente distorta nella sua applicazione, l’ideologia comunista, almeno nella versione originaria marxista, è un’ideologia di emancipazione e liberazione che mira non alla distruzione, ma alla ‘creazione’ dell’uomo nuovo e di una società senza conflitti, senza sfruttamento, senza oppressione» [3].
Non intendo certo mettere qui in discussione la gravità degli atroci crimini commessi dai regimi totalitari, né fare paragoni riguardanti il numero delle vittime. Credo però che una sintetica esposizione delle due ideologie, che sono alla base delle relative esperienze storiche, faciliti il confronto tra due concezioni dell’uomo e della società che sono radicalmente differenti, cosa di cui, come notava Pasquino, il Parlamento europeo non tiene minimamente conto nelle sue Risoluzioni. Il mio obiettivo è quello di offrire elementi per rispondere con maggior cognizione di causa alla domanda che pongo in questo articolo: equiparare quei simboli è corretto?
L’ideologia nazista
I principi fondamentali dell’ideologia nazista sono esposti nel Mein Kampf (La mia battaglia) di Adolf Hitler (1889-1945): anzitutto un forte nazionalismo, che tende a trascurare la dimensione individuale dell’uomo per accentuare la sua appartenenza alla comunità. Il naturale istinto di sopravvivenza dell’uomo viene così esteso alla collettività, al popolo caratterizzato dalla propria identità razziale, tanto che popolo e razza sono termini intercambiabili. Ogni popolo possiede infatti caratteri propri, trasmessi di generazione in generazione, e la storia umana non è che lotta tra razze diverse.
Le possibilità di sopravvivere in tale lotta dipendono dalla capacità di un popolo di riprodursi e di conquistare il territorio necessario al sostentamento della popolazione, sicché la guerra di conquista è considerata un’esigenza ineliminabile. Le diverse razze, poi, non stanno tutte sullo stesso piano: c’è una gerarchia delle razze, e Hitler era convinto che i tedeschi fossero membri di un gruppo di razze superiori, quelle ariane. Tutto ciò che, nel corso della storia, è stato creato di nobile e di grande, per Hitler era opera di popoli o individui ariani. Solo questi soggetti storici possono essere definiti creatori di civiltà. Gli altri popoli, al massimo, possono tentare di imitare gli ariani, oppure distruggere quanto gli ariani hanno costruito.
Ecco le parole di Hitler:
«Ciò che noi vediamo oggi, in materia di cultura o di arte o di scienza o di tecnica è quasi esclusivamente il prodotto geniale dell’ariano. E ciò ci conduce alla conclusione ovvia che egli solo è stato il fondatore dei valori umani più alti e rappresenta quindi il prototipo di ciò che noi designiamo con la parola uomo. Egli è il Prometeo dell’umanità, dalla cui fronte radiosa scoccò in ogni tempo la scintilla del genio, accendendo ogni volta la fiaccola che illuminò di conoscenza la notte del silenzioso mistero; e così preparò la strada all’umanità, per dominare le altre creature terrene. Lo si elimini – e quella oscurità tornerà ad avviluppare di nuovo la terra, la cultura umana tramonterà e il mondo si rifarà deserto» [4].
Il pericolo maggiore era quindi rappresentato dall’inquinamento razziale, conseguenza dell’unione con razze inferiori. Il compito principale dello Stato era perciò la difesa della purezza della razza da ogni contaminazione, come scrive Hitler nello stesso testo: «La mescolanza di sangue e la conseguente diminuzione del livello della razza è l’unica causa della morte delle antiche culture; gli uomini non si distruggono in conseguenza di guerre perdute, ma soltanto per la perdita di quella forza di resistenza che è peculiare a un sangue puro». Arrivati al potere nel 1933, i nazisti infatti imposero subito in Germania una minuziosa legislazione che imponeva la sterilizzazione forzata degli alcolisti e di tutti coloro che fossero affetti da malattie ereditarie.
Per quanto riguarda i rapporti con gli altri Stati, Hitler riteneva che la Germania avrebbe potuto raggiungere una vera e duratura (millenaria) prosperità solo se fosse riuscita a conquistare quello che chiamava lo spazio vitale, cioè un vasto impero, il cui primo scopo sarebbe stato quello di fornire i mezzi per lo sviluppo del popolo tedesco. Tale spazio vitale era costituito dagli immensi spazi russi, abitati da popoli razzialmente inferiori rispetto agli ariani, cioè dagli slavi, guidati e manipolati dai marxisti ebrei. L’obiettivo finale era quindi la costruzione di un gigantesco impero continentale germanico, che esercitava il suo dominio sulle masse slave, decimate e ridotte a servire, in condizioni di semi-schiavitù, la superiore razza padrona.
Ammessi tali presupposti – dovere di salvaguardare la purezza del proprio patrimonio genetico, di cui la natura l’ha dotata, e diritto di sottomettere le razze inferiori – secondo Hitler, la razza ariana era minacciata, in particolare, dagli ebrei: una razza caratterizzata non da credenze religiose ma da un patrimonio biologico ereditario, che inquinava le razze superiori diffondendo ora il progetto delle democrazie parlamentari dei Paesi capitalisti, ora l’idea bolscevica che la lotta di classe dovesse sostituire la competizione tra le razze. Ma da eliminare, per legge di natura, erano anche gli zingari, i disabili, gli omosessuali e gli individui asociali: i matrimoni misti tra tedeschi ariani e membri di razze inferiori avevano, infatti, causato la procreazione di individui geneticamente degenerati, come handicappati mentali o fisici, criminali abituali, alcolizzati…
Per raggiungere questi obiettivi, la Germania doveva diventare uno Stato totalitario, in cui veniva coltivato il culto di una guida infallibile, il Führerprinzip (Principio del capo): il governo doveva controllare ogni aspetto della vita pubblica e privata, la libertà di espressione doveva essere assolutamente limitata, e alla propaganda doveva essere assegnato il compito di diffondere l’ideologia del partito, puntando sull’esaltazione di sacrificio e morte in guerra, e sul mito della superiorità tedesca di sangue e suolo.
L’ideologia comunista
Per Marx (1818-1883), invece, l’essere umano è caratterizzato non dalla appartenenza alla comunità nazionale ma dal lavoro: è proprio nell’attività lavorativa che l’uomo può esprimere la sua creatività e realizzarsi, collaborando con altre persone, poiché è un essere fondamentalmente sociale. Ma nell’economia capitalistica – opera di una borghesia di cui Marx riconosce il ruolo rivoluzionario: «La borghesia ha creato opere ben più mirabili delle piramidi egizie, degli acquedotti romani e delle cattedrali gotiche» [5]– il lavoro si svolge in condizioni alienanti. Qui, infatti, il lavoratore è costretto a vendere, come una merce, la sua forza-lavoro per ottenere un salario che non corrisponde alla durata della sua prestazione ma che gli consente solo di soddisfare i suoi bisogni primari, per essere in grado di continuare a vendere l’unica merce di cui dispone e per procreare la prole che lo sostituirà al momento opportuno. È proprio il lavoro non pagato, il plus-lavoro, che costituisce il profitto del capitalista, condizione dell’accumulazione della proprietà privata.
Il lavoratore non può scegliere liberamente cosa e come produrre, e inoltre il prodotto del suo lavoro non appartiene a lui ma al capitalista, che si appropria anche del tempo di chi lavora per lui. A queste condizioni, è evidente che il lavoro diventa qualcosa di alienante: «Rende estraneo all’uomo il suo proprio corpo, come la natura fuori di lui, e la sua essenza spirituale, la sua essenza umana» [6].
Per esercitare il suo dominio di classe, la borghesia non ha, ovviamente, difficoltà ad appropriarsi dell’organizzazione statale, una sovrastruttura che, pur presentandosi quale espressione di tutta la società, risponde in realtà agli interessi della borghesia, sicché «Il potere politico dello Stato moderno non è che un comitato, il quale amministra gli affari comuni di tutta quanta la classe borghese» [7]. E poiché non è possibile governare solo con la forza, la borghesia si assicura anche il controllo dei mezzi d’informazione, che riescono a far accettare al proletariato, come se fossero naturali, condizioni economiche che sono invece frutto del processo storico della lotta di classe, perché «Le idee dominanti di un’epoca furono sempre soltanto le idee della classe dominante» [8].
Una simile struttura determina, quindi, una profonda diseguaglianza economica e sociale tra capitalisti e lavoratori, che non può essere corretta con un aumento dei salari ma solo con una rivoluzione violenta che abolisca la proprietà privata. Finiranno così la lotta di classe e lo sfruttamento dei lavoratori, e si creeranno le condizioni perché tutti gli uomini possano finalmente godere di pari opportunità e sviluppare liberamente le loro potenzialità, impegnandosi nell’interesse dell’intera società.
La proprietà privata che Marx vuole abolire, poi, è solo quella dei mezzi di produzione non quella dei prodotti del proprio lavoro: «Il comunismo non toglie a nessuno la facoltà di appropriarsi dei prodotti sociali; toglie soltanto la facoltà di valersi di tale appropriazione per asservire lavoro altrui». Questa proprietà, per la maggioranza della società, è invece abolita proprio in un’economia di tipo capitalista: «nell’attuale vostra società la proprietà privata è abolita per nove decimi dei suoi membri; anzi, essa esiste precisamente in quanto per quei nove decimi non esiste. Voi ci rimproverate dunque di voler abolire una proprietà che ha per condizione necessaria la mancanza di proprietà per l’enorme maggioranza della società». Il progetto di Marx, invece, vuole promuovere un’appropriazione collettiva dei beni, che mira a soddisfare i bisogni di tutti, piuttosto che a generare profitto per pochi.
Con la rivoluzione, che Marx crede imminente, cambieranno poi non solo le strutture economiche ma anche quelle politiche, e cadranno quelle ideologie che servivano a giustificarle. Nell’immediato ci sarà un periodo transitorio di dittatura rivoluzionaria del proletariato, necessaria per evitare i possibili tentativi controrivoluzionari della borghesia, ma poi lo Stato scomparirà perché, abolite le classi, in una società che si riorganizza come libera e uguale associazione di produttori non ci sarà posto per quello strumento di dominio di classe che è la macchina statale. Aboliti quindi «il potere organizzato di una classe per l’oppressione di un’altra» e la «vecchia società borghese con le sue classi», nascerà «un’associazione nella quale il libero sviluppo di ciascuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti».
Si cominceranno a mettere in atto, perciò, misure «per rivoluzionare l’intero modo di produzione […] diverse a seconda dei diversi Paesi». E in quelli più progrediti potranno essere applicate, tra le altre, le seguenti: «Imposta fortemente progressiva… Uguale obbligo di lavoro per tutti… Educazione pubblica e gratuita di tutti i fanciulli. Abolizione del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche».
Così tutti potranno essere messi in condizione, con un lavoro libero e creativo in armonia con la natura, di realizzare le proprie aspirazioni, in un primo momento ricevendo un compenso proporzionato al rendimento. In occasione del Congresso di Gotha, Marx scrive però che in una fase successiva, quando sarà «scomparsa la subordinazione servile degli individui alla divisione del lavoro» e saranno cresciute «le forze produttive e tutte le sorgenti delle ricchezze sociali», ciascuno riceverà una retribuzione adeguata ai suoi effettivi bisogni. Ed è facile percepire l’entusiasmo con cui Marx formula quello che, sino a oggi, resta solo un sogno: la società potrà «scrivere sulle sue bandiere: – Ognuno secondo le sue capacità; a ognuno secondo i suoi bisogni!» [9].
Un’equiparazione scorretta
Ricordate sinteticamente le due ideologie, alla domanda iniziale, risponderei dunque così: l’equiparazione di quei simboli non sembra corretta, perché frutto di una doppia confusione. Anzitutto, non si distinguono due piani: quello dell’ideologia e quello delle realizzazioni storiche. Sul primo, quello dell’ideologia, mi pare che il comunismo abbia, assieme a quelli negativi, anche aspetti positivi, che non trovo nel nazismo: da una parte, nazionalismo, razzismo, antisemitismo; dall’altra, una società caratterizzata da uguaglianza, giustizia e cooperazione. Si può ignorare tutto ciò?
Si cancellano, poi, le differenze esistenti tra le esperienze storiche nate da quelle due ideologie. Se il nazismo, infatti, si può identificare col totalitarismo della Germania di Hitler, non è possibile identificare l’esperienza comunista col totalitarismo sovietico, – un regime, ripeto a scanso di equivoci, assolutamente da condannare – ignorando il contribuito dato dai comunisti al miglioramento delle condizioni dei lavoratori in diversi Paesi democratici. Aumento dei salari, progressività delle imposte, istruzione obbligatoria: davvero si può onestamente affermare che questi obiettivi siano stati raggiunti senza il concorso di partiti e sindacati, operanti in diversi Paesi europei, che si dichiaravano comunisti?
Se prendiamo come esempio il caso italiano, non possiamo dimenticare che l’attuale Costituzione è il frutto dell’intesa tra democristiani, liberali, socialisti e comunisti. E la Costituzione afferma che l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, che è necessario rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, che la tassazione deve essere progressiva, che il lavoratore ha diritto a una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa… Tutto ciò sarebbe stato possibile senza il contributo dei parlamentari comunisti?
Mi sembra che abbia ragione, quindi, Elena Basile, che è stata ambasciatrice d’Italia in Svezia e in Belgio, quando critica la Risoluzione di un Parlamento europeo che, lasciandosi condizionare dall’attuale contesto storico dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin, dimentica l’enorme «differenza tra una ideologia nazista e razzista, basata sul disprezzo del debole e del malato, e prona a giustificare il predominio di una ‘razza’, e il sogno comunista di un mondo senza classi e ingiustizie sociali. […] Rimane inquietante che si sia voluto sporcare un simbolo – falce e martello – di lotta e liberazione degli oppressi, senza comprenderne il legame con le speranze umanistiche, e assimilarlo all’infame nazismo» [10].
Ma, poiché al peggio non c’è fine, come escludere che fra qualche anno, se si consolida l’attuale clima politico, il Parlamento europeo finisca col proibire solo il simbolo comunista!? Questa può sembrare una battuta, ma non lo è affatto, se si riflette sui preoccupanti cambiamenti avvenuti nelle votazioni dell’ONU sul tema del nazismo. La Russia, infatti, regolarmente e da diversi anni propone all’assemblea dell’ONU una Risoluzione, approvata sempre a larga maggioranza, che condanna il nazismo e il neonazismo [11]; presente, quest’ultimo, in Ucraina con numerosi movimenti neonazisti e ultranazionalisti, sostenuti dagli USA [12], e operanti sia a livello politico che a livello militare. Ebbene, mentre prima del 2014 i Paesi europei, in genere membri della NATO, votavano a favore di quella condanna, a partire da quella data gli stessi Paesi (inclusa l’Italia) hanno cominciato ad astenersi, e addirittura nel 2024 hanno votato contro. Allineandosi – con un cambiamento radicale da non sottovalutare: prima favorevoli, poi astenuti, infine contrari – a due Stati, uno particolarmente influente e l’altro infettato da organizzazioni neonaziste, che già dal 2014 votavano contro: Stati Uniti e Ucraina. A questo punto, siamo sicuri che sia infondata la domanda: a quando una esplicita rivalutazione del nazismo?
Dialoghi Mediterranei, n. 74, luglio 2025
Note
[1] Risoluzione del Parlamento europeo sulla disinformazione e la falsificazione della storia da parte della Russia per giustificare la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina (23 gennaio 2025).
[2] Risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull’importanza della memoria europea per il futuro dell’Europa.
[3] G. Pasquino, L’illusione dell’equivalenza tra nazismo e comunismo, Reset 20/7/2020.
[4] Mein Leben (La mia vita), capitolo 11. Si tratta della prima parte del Mein Kampf, 1925-1926.
[5] K. Marx – F. Engels, Manifesto del Partito Comunista, capitolo I, 1848.
[6] K. Marx, Manoscritti economico-filosofici del 1844, quarta sezione del primo manoscritto.
[7] K. Marx – F. Engels, Manifesto del Partito Comunista, capitolo I.
[8] K. Marx – F. Engels, Manifesto del Partito Comunista, capitolo II, così come le successive citazioni.
[9] K. Marx, Critica del programma di Gotha, manoscritto del 1875.
[10] E. Basile, Comunismo = Nazismo? È pura propaganda Ue, Il Fatto Quotidiano, 9/2/2025.
[11] Questo il titolo della Risoluzione: Combattere la glorificazione del nazismo, neonazismo e altre pratiche che contribuiscono ad alimentare le contemporanee forme di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza.
[12] Questi movimenti, scriveva qualche anno fa, in un articolo molto documentato, la giornalista Maria Grazia Bruzzone, “il governo USA li aiuta e li finanzia” (M. G. Bruzzone, I neo-Nazi imperversano in Ucraina, ma il Nazismo non è più il “male assoluto” (per l’Occidente), La Stampa, 30/11/2014).