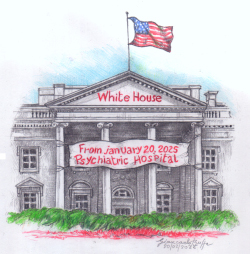“Gli operai della Fiat sono ritornati al lavoro. Tradimento? Rinnegamento delle idealità rivoluzionarie? Gli operai della Fiat sono uomini in carne ed ossa. Hanno resistito per un mese. Sapevano di lottare e di resistere non solo per sé, non solo per la restante massa operaia torinese, ma per tutta la classe operaia italiana. Hanno resistito per un mese. Erano estenuati fisicamente perché da molte settimane e da molti mesi i loro salari erano stati ridotti e non erano più sufficienti al sostentamento famigliare, eppure hanno resistito per un mese […] sapevano che ormai alla classe operaia erano stati tagliati i tendini, sapevano di essere condannati alla sconfitta, eppure hanno resistito per un mese. Non c’è vergogna nella sconfitta degli operai della Fiat”[1].
Questo articolo de L’Ordine nuovo fa riferimento alla cocente sconfitta subita dai lavoratori della Fiat dopo l’estrema lotta ingaggiata all’annuncio da parte della dirigenza dell’azienda e di altre fabbriche di Torino di voler licenziare migliaia di operai.
In particolare il 16 marzo 1921 la Fiat, in crisi, come altre aziende costrette a riconvertire la produzione da bellica in civile, comunicò la volontà di licenziare 1500 operai e di ridurre l’orario di lavoro agli altri. Alle proteste operaie Agnelli contrappose la serrata e fece presidiare le officine dall’esercito. Il 6 maggio dopo una lunga resistenza gli operai, quelli non licenziati, furono richiamati al lavoro uno ad uno, su chiamata individuale[2]. Col capo chino, a testa bassa, sconfitti, umiliati rientrarono nei loro stabilimenti dove pochi mesi prima avevano innalzato le bandiere rosse sulle ciminiere.
Tra i licenziati soprattutto i lavoratori comunisti, le avanguardie operaie.
A distanza di pochi giorni, il 25 aprile 1921 una squadra fascista, pagata dagli industriali, con la connivenza delle istituzioni e delle forze dell’ordine assaltava la Camera del lavoro di Torino. Tre giorni prima, il 22 aprile, lo stesso Antonio Gramsci fu picchiato da un gruppo di fascisti.
Il controllo delle fabbriche era pienamente ritornato nelle mani dei padroni. “La piena ripresa del controllo padronale alla FIAT ebbe luogo tanto con le armi della repressione (i licenziamenti politici e l’uso del terrore fascista), quanto con quelle della riorganizzazione tecnica del processo produttivo in base ai principi del taylorismo e del fordismo”[3]. La Fiat Lingotto divenne in Italia l’avanguardia dell’organizzazione scientifica del lavoro. La Stampa di Torino nel maggio 1923 poteva con orgoglio scrivere: “l’operaio è una specie di cellula assegnata a un dato posto. Molte volte non ha più di uno o due metri quadrati di spazio per muoversi. Non ha bisogno di muoversi, non deve. Ogni movimento suo inutile rappresenterebbe una perdita o distruzione di energia”[4].
Molto realisticamente, tre anni prima, nel settembre 1920, L’Ordine nuovo, rivista che esercitava tra il proletariato torinese una forte opera di formazione politica e di organizzazione delle lotte, dava questa descrizione della condizione dei lavoratori: “L’operaio nella fabbrica ha mansioni meramente esecutive. Egli non segue il processo generale del lavoro e della produzione; non è un punto che si muove per creare una linea; è uno spillo conficcato in un luogo determinato e la linea risulta dal susseguirsi degli spilli che una volontà estranea ha disposto per i suoi fini, [….] l’operaio si acconcia dappertutto all’ufficio di esecutore materiale, di “massa” guidata da una volontà estranea alla sua”[5].
L’articolo venne scritto in due riprese, tra il settembre e l’ottobre del 1920, poiché nel frattempo si era svolta quella che probabilmente può essere definita come la più radicale lotta del proletariato italiano: l’occupazione delle fabbriche, iniziata il 31 agosto a seguito della serrata dell’Alfa Romeo, ed estesasi rapidamente ad oltre 300 stabilimenti solo in Piemonte, a seguito dell’adesione alla serrata da parte della Confederazione degli industriali, e come un incendio ad altre regioni.
Oltre 500.000 operai parteciparono all’occupazione delle fabbriche, proseguirono la produzione, issarono le bandiere rosse sulle ciminiere e difesero in armi gli stabilimenti. La posta in gioco era altissima: gli operai non ponevano rivendicazioni di natura sindacale – aumenti salariali, orari, turni, garanzie sul lavoro – ma la questione del controllo della produzione, da attuarsi attraverso i Consigli di fabbrica, veri e propri organi attraverso i quali esercitare una reale democrazia operaia. Alla catastrofe capitalistica, incapace di garantire “le elementari esigenze della vita umana”, all’imperversare di crisi nazionali e internazionali, di cui la grande guerra aveva costituito il detonatore, la classe operaia ed in rapida successione il proletariato agricolo posero in modo drammatico la questione della proprietà privata dei mezzi di produzione: l’occupazione delle fabbriche e l’occupazione delle terre, al grido di “la terra a chi la lavora” (o la socializzazione della terra).
In queste forme di lotta vi era la prefigurazione di nuovi modi di produzione e di distribuzione, nuovi fini della produzione, una diversa società, non più fondata sullo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Senza una diversa prospettiva la vita di milioni di operai e di contadini poveri sarebbe stata stritolata nella morsa della più umiliante penuria e di un disumanizzante sfruttamento. Era una questione “di vita e di libertà”.
“Il comunismo è la loro civiltà, è il sistema di condizioni storiche nelle quali acquisiranno una personalità, una dignità, una cultura, per il quale diventeranno spirito creatore di progresso e di bellezza”[6]. È un grande Gramsci quello che già nel 1919 prefigura una società comunista, evocata nel rapporto e nel dialogo con la classe operaia torinese. In virtù di questa forte condivisione di vita e di lotte Gramsci pensa che, se la rivoluzione ha un senso, questo vada trovato nel compito storico che il proletariato povero dovrà/saprà svolgere: quello etico-politico di creare una nuova civiltà, una riforma intellettuale e morale, per ricongiungersi con la propria e l’altrui umanità liberata, restituita alla dignità di un’esistenza capace di produrre cultura, solidarietà, creatività, alternativa alla società del profitto.
L’occupazione delle fabbriche fu certamente “il momento culminante dell’attacco operaio alle strutture della società borghese”[7], così come il movimento consiliare rappresentò un radicale “punto di rottura” nei confronti del riformismo opportunistico, politico e sindacale, del massimalismo parolaio, dell’attesismo inconcludente.
Nei Consigli di fabbrica i lavoratori erano i produttori, coloro che potevano prefigurare un’organizzazione diversa della società, non forza-lavoro, venduta come merce sul mercato dei “pescecani” capitalisti. In essi cadevano le distinzioni tra dirigenti e diretti, tra chi decide e chi esegue. I Consigli, espressione di tutta la classe lavoratrice senza distinzioni politiche o ideologiche, costituivano le nuove istituzioni della classe operaia, simili ai soviet, attraverso cui realizzare l’embrione di una “democrazia proletaria”, un auto-governo dei produttori.
Non solo: nel Consiglio di fabbrica si formava quello che Gramsci definì come il “lavoratore collettivo”, un soggetto collettivo che riemerge dalla divisione del lavoro, propria del sistema di produzione capitalistica, che isola ogni lavoratore alla sua condizione di “spillo umano”, parcellizzando sempre di più il processo lavorativo in operazioni parziali che impediscono al singolo operaio di riferirsi al prodotto del suo lavoro e al suo lavoro stesso, ridotto ad una esigua funzione che si ripete meccanicamente. Come scrive Marx nel Capitale ai lavoratori “sfugge la complessità dell’opera comune” e per il lavoratore “nella sua coscienza stessa il proprio contributo si deprezza sino a sembrare sostituibile facilmente in ogni istante”.
Il sapere operaio, colto e ricomposto attraverso la sua dimensione collettiva, la relazione dei lavoratori dentro la produzione, la coscienza della maggiore produttività “sociale” all’interno dei Consigli di fabbrica, consentivano altresì di slegare i progressi tecnici dal profitto della classe dominante per legarli agli interessi della classe subalterna. Per Gramsci, organizzatore delle cellule sui luoghi di lavoro, i tempi erano maturi: gli operai avevano dimostrato di comprendere questo processo e di essere capaci di uscire dalla loro condizione subalterna, di comprendersi come “lavoratore collettivo” all’interno dei Consigli, non solo in riferimento alla propria fabbrica ma più in generale rispetto al più complesso processo di divisione del lavoro.
Il “lavoratore collettivo” si stagliava come capace di ricucire la separazione tra lavoro manuale e intellettuale, tra produzione intellettuale e politica e produzione materiale. Il socialismo non doveva consistere solo nella sostituzione di uno stato ad un altro, o di un sistema economico ad un altro, ma in una società alternativa, già prefigurata, pensata, agita, incarnata nei Consigli di fabbrica.
Il proletariato industriale e agricolo da oggetto poteva assurgere a soggetto storico ed essere forza storica della trasformazione. La posta in gioco era la più alta: il potere operaio. Esso doveva trasformare i rapporti di produzione esistenti, assicurando nuove e migliori condizioni di vita e di lavoro, ma al contempo doveva rideterminare i rapporti sociali, fondarli su nuove forme di soggettività, su nuove istanze etico-politiche.
Eppure l’occupazione delle fabbriche fu svenduta “per un piatto di lenticchie”, come fu scritto: Giolitti, che aspettava che il cadavere passasse sotto la finestra del governo, apparecchiò, in combutta con i vertici sindacali e i dirigenti del PSI, la resa: aumenti salariali ed un generico controllo della produzione “congiunto”, di stampo “collaborazionista” nei confronti dei padroni, da definirsi in un prossimo futuro, in cambio della smobilitazione.
Dopo un mese d’occupazione durissima, con le fabbriche circondate da reparti dell’esercito e scontri a fuoco, l’opera di sabotaggio del processo rivoluzionario in corso condotto dalla Camera del lavoro e dal PSI pagò. CGL e PSI assicurarono che la lotta si svolgesse in condizioni di isolamento e solitudine, rispetto al resto del paese e soprattutto rispetto al mondo contadino, che le altre categorie del mondo del lavoro non fossero coinvolte a sostegno del proletariato insorto, e si prodigarono in rassicurazioni ai gruppi dominanti. I dirigenti socialisti ed i sindacalisti riformisti non seppero e non vollero organizzare alcuna risposta, né indicare sbocchi politici, né fornire parole d’ordine chiare, in grado di orientare il movimento di lotta che si era spinto su fronti così avanzati. Nessuna direzione politica delle lotte, ma la esplicita, aperta sfiducia nel carattere rivoluzionario della fase in corso e la professata previsione del suo inevitabile esito fallimentare. “Chi parla di “illusioni fallaci” (leggi: i socialisti – ndr) sottintende necessariamente che la classe operaia deve sempre piegare il collo dinanzi ai capitalisti, sottintende necessariamente che la classe operaia deve persuadersi di essere solamente una mandria di bestiame, un’accolta di bruti senza coscienza e senza volontà, che la classe operaia deve persuadersi di essere incapace di avere una propria concezione da contrapporre alla concezione borghese, di avere nozioni, sentimenti, aspirazioni, interessi contraddittori con le nozioni, i sentimenti, le aspirazioni, gli interessi della classe borghese”[8].
Tutto il “biennio rosso”, che coinvolse masse enormi, fu lasciato morire per inedia, senza alcuna direzione politica.
“I socialisti hanno, supinamente spesso, accettato la realtà storica prodotto dell’iniziativa capitalistica; sono caduti nell’errore di psicologia degli economisti liberali: credere alla perpetuità delle istituzioni dello Stato democratico, alla loro fondamentale perfezione. Secondo loro la forma delle istituzioni democratiche può essere corretta, qua e là ritoccata, ma deve essere rispettata fondamentalmente”[9]. Ormai rimasto un mero partito parlamentare, il PSI “si mantiene immobile entro i limiti angusti della democrazia borghese”.
Con drammatica chiaroveggenza, Gramsci nella relazione dal titolo Per un rinnovamento del Partito socialista, presentata al Consiglio nazionale del PSI a Milano del 19-20 aprile 1920, aveva sostenuto che “la fase attuale della lotta di classe in Italia è la fase che precede: o la conquista del potere politico da parte del proletariato rivoluzionario… o una tremenda reazione da parte della classe proprietaria e della casta governativa”. Lo squadrismo fascista già negli ultimi mesi del 1920 iniziava ad incalzare, accanendosi in modo particolare con coloro che si erano distinti nelle lotte.
Gramsci, divenuto segretario nazionale del Partito comunista, ebbe modo di interrogarsi sulla tardiva scissione e sulla insufficiente battaglia condotta all’interno del PSI da parte della “frazione comunista”. Tale riflessione sorgeva nel quadro di un ripensamento del rapporto tra spontaneità delle lotte e direzione politica del partito, entrambe da far coesistere, essendo indispensabili sia il protagonismo e la soggettività delle lotte, il radicamento di massa, il rapporto con le masse, sia al contempo il ruolo dirigente del partito, concepito come sezione della III Internazionale comunista, “fortemente centralizzato”, “con proprie articolazioni disciplinate in tutti gli ambienti” dove lavorava, che è unito e lotta con la classe operaia.
Il Partito della classe operaia, del proletariato del nord e dei contadini poveri del sud: questa era l’originaria ispirazione che stava a fondamento della costituzione di un partito nuovo. I suoi quadri dovevano venire da lì, “dai campi e dalle officine”, temprarsi nella lotta, formarsi sulla base del materialismo storico marxista nell’interpretare i processi e le fasi storiche e per organizzare la rottura distruttiva del “disordine capitalista” alla luce di prospettive strategiche e tattiche, discusse analiticamente ed in forma collettiva. In questo consisteva la sua diversità e irriducibilità al PSI.
La scelta di costituire il Partito della classe operaia cadde paradossalmente nel momento di maggiore sconfitta del proletariato industriale ed agricolo, sospinto nel più pesante arretramento, che ne avrebbe oscurato il ruolo di soggetto storico per molto tempo.
Perchè? Certamente c’era la consapevolezza della indifferibile opera di direzione politica da assicurare ai conflitti sociali, nonché della necessità di coinvolgere nell’opera di trasformazione ampi strati del corpo sociale, guadagnandone il consenso attivo e organico. C’era la consapevolezza della “mancanza di coordinamento e di concentrazione rivoluzionaria nelle forze operaie italiane”[10]. Aspetti cruciali, che erano mancati durante tutto il “biennio rosso”.
Ma soprattutto c’era la certezza della centralità della classe operaia, anche se sconfitta ed ormai avviluppata nella morsa del pesante riflusso rivoluzionario. C’era la consapevolezza della centralità della classe operaia nei processi di valorizzazione del capitale: il capitale è lavoro espropriato, la proprietà privata dei mezzi di produzione non è il presupposto, ma è il prodotto del lavoro espropriato.
Possono cambiare le condizioni, ma non questo rapporto.
E allora? “Se dunque noi siamo stati sconfitti è nostro dovere ricominciare da capo: l’intervallo di sosta [….] ci lascia tempo per un lavoro quanto mai utile: lo studio delle cause che determinarono, col loro confluire, la recente rivoluzione e la sua sconfitta; cause che non debbono essere ricercate negli sforzi, nella genialità, nelle colpe, negli errori o nei tradimenti di alcuni capi, ma nello stato generale della società”[11].
E allora? ”Non c’è nessuna vergogna nella resa degli operai della Fiat. La classe operaia è livellata sotto il rullo compressore della reazione capitalistica.[…] Gli operai hanno bagnato del loro sangue le strade, hanno sofferto la fame ed il freddo; essi rimangono[… ] all’avanguardia del proletariato italiano[….] Hanno fatto quanto è dato fare a uomini in carne ed ossa; togliamoci il cappello dinanzi alla loro umiliazione, perché anche in essa è qualcosa di grande che si impone ai sinceri ed agli onesti”[12].
Che ne è oggi della classe operaia, privata addirittura del suo partito?
Continua…
[1] Non firmato, Uomini in carne ed ossa, in L’Ordine nuovo, 8 maggio 1921.
[2] P. Spriano, Nota, in A. Gramsci, Scritti politici, a cura di P. Spriano, Editori riuniti, Roma 1973, p. 216.
[3] V. Giacchè, Cent’anni di improntitudine. Ascesa e caduta della Fiat, in Proteo, n. 2002-3.
[4] E prosegue: “Il pezzo di sua lavorazione giunge a lui lungo un piccolo binario ricco di rulli: giunge sotto la spinta d’un braccio vicino, è lavorato, e sotto un’altra spinta riparte e va da un altro operaio a farsi raffinare o aggraziare”, in V. Giacchè, cit.
[5] Non firmato, Il Partito comunista, in L’Ordine nuovo, 4 settembre e 9 ottobre 1920.
[6] A. Gramsci, Operai e contadini, in L’Ordine nuovo, 2 agosto 1919.
[7] P. Nenni, Intervista sul socialismo italiano, a cura di G. Tamburrano, Laterza, Bari, p. 40.
[8] Non firmato, Superstizione e realtà, in L’Ordine nuovo, 8 maggio 1920.
[9] Non firmato, La conquista dello Stato, in L’Ordine nuovo, 12 luglio 1919.
[10] Non firmato, Uomini in carne ed ossa, in L’Ordine nuovo, 8 maggio 1921.
[11]Non firmato, Superstizione e realtà, in L’Ordine nuovo, 8 maggio 1920. Il passo riprodotto nell’articolo è in realtà tratto da K.Marx, Revolution et contre-revolution en Allemagne, Paris, 1900, pp. 2-3
[12]Non firmato, Uomini in carne ed ossa, in L’Ordine nuovo, 8 maggio 1921