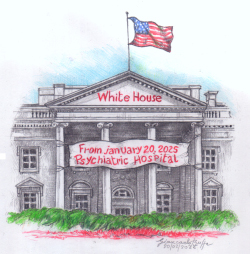Lo storico dell’America settentrionale Gian Giacomo Migone, già presidente della Commissione Esteri del Senato, analizza la sconfitta di Kamala Harris, che attribuisce all’incapacità di mobilitare nuovi elettori. Piuttosto che rivolgersi ai giovani elettori interessati alle questioni mediorientali, i democratici hanno tentato di conquistare elettori moderati repubblicani. E hanno lasciando campo libero a Trump per consolidare il supporto dell’elettorato conservatore. Migone sottolinea la crisi del sistema americano, evidenziata dallo strapotere dell’1% più ricco della popolazione e dal ruolo delle lobby, come AIPAC che sostiene gli interessi israeliani. La spesa elettorale astronomica e l’influenza del complesso militare-industriale, che portano a una militarizzazione delle crisi internazionali, rappresentano serie minacce alla democrazia statunitense.
Kamala Harris ha perso per un motivo chiaro. Quando tu insegui l’orso nella sua tana, l’orso ti mangia. In altre parole, se tu ti attesti su una posizione politica che è in qualche maniera simile o costituisce una versione moderata della posizione dell’avversario, l’elettorato nella sua maggioranza non ti vota. Perché preferisce votare per il prodotto autentico.
Per capire la débâcle democratica, bisogna partire dal fatto che Joe Biden ha resistito come candidato a oltranza, malgrado il suo declino cognitivo fosse evidente a tutti. Mi faceva venire in mente il Segretario generale del PCUS Leonid Brezhnev, quando stava seduto a un tavolo contornato da persone che in realtà erano quelle che decidevano.
Ora, le persone che invece decidevano al posto di Biden volevano continuare a gestire il potere in quella situazione di monarchia decaduta. Quindi lo inducevano a non dimettersi. Quando tale situazione è diventata insostenibile, hanno cercato una soluzione che garantisse continuità con il contesto precedente. E hanno scelto Kamala Harris, che come vicepresidente aveva sempre avuto un profilo e anche un ruolo politico assolutamente secondari. Come risultato, Kamala Harris non è stata in grado di garantire quello per cui era stata scelta, cioè la continuità con l’amministrazione precedente.
Ma che cosa avrebbe potuto costituire una vera sfida a Donald Trump? Un’apertura verso quella fetta di elettorato che non era disposto ad andare a votare. Mentre Trump ha fatto il pieno tra i non elettori collocati a destra del partito repubblicano, Kamala Harris ha inseguito i repubblicani moderati, anziché mobilitare i non elettori, cioè la massa di persone – per lo più giovani – che si era mobilitata in vario modo sulla questione mediorientale.
È anche vero però che, viste le sue posizioni nettamente filo israeliane, Kamala non era il candidato ideale per riuscire a mobilitare la fascia di elettorato sensibile alle sofferenze dei palestinesi. Ci sarebbe voluto un altro candidato. Non Bernie Sanders per ragioni di età (ormai la questione anagrafica era diventata centrale per il partito democratico), ma qualcuno con una posizione assolutamente critica nei confronti dell’amministrazione Biden.
Quanto al paragone con Brezhnev, c’è tutta una discussione in corso, iniziata nel 2020 dallo storico Harold James con l’articolo Late Soviet America e su cui ha scritto anche lo storico Niall Ferguson, sul fatto che gli Stati Uniti stanno diventando come l’URSS degli Settanta. È un fatto incontrovertibile che stiamo assistendo al declino della democrazia degli Stati Uniti, un fenomeno pericoloso per le conseguenze che può avere per la politica estera. Faccio un esempio molto chiaro. Il New York Times ha scritto pagine intere su presunte influenze della Russia delle manipolazioni del processo elettorale americano. Ma non ha detto una parola (così come non l’ha detta la nostra grande stampa) sul fatto che AIPAC, un’organizzazione che obbedisce agli ordini di uno Stato straniero, cioè Israele, controlla attraverso i suoi finanziamenti un terzo del Congresso degli Stati Uniti.
Un altro segno di crisi della democrazia americana che non viene sottolineato abbastanza è il costo stratosferico delle campagne elettorali, che fa sì che quell’1% della popolazione che detiene metà della ricchezza del Paese diventa assolutamente determinante durante le presidenziali. Racconto un episodio. Nel 2000 ricevetti una delegazione di senatori americani, come si usa in quelle occasioni. La senatrice Barbara Boxer della California mi chiese quale legislazione stessimo discutendo in quel momento al Senato italiano. Io citai la legge sulla par condicio.
Lei mi disse di non parlare di quella questione, perché per affrontare le spese della campagna elettorale per essere rieletta senatrice della California (non per candidarsi alla presidenza!) doveva farsi dare da qualcuno 52 mila dollari al giorno. Tutti i giorni dell’anno… Poiché stimavo la Boxer, le chiesi come facesse a non diventare schiava di coloro che le davano i 52 mila dollari al giorno. La sua risposta fu: «Non chiedermi quello che fanno i miei colleghi o i candidati alla presidenza. Quello che faccio io è che, se l’establishment ebraico di Hollywood mi dà dei soldi, vado dagli esponenti arabi a farmi dare altrettanti soldi».
A distanza di 24 anni, la questione è ormai sotto gli occhi di tutti. Via via che cresce il costo della politica, se ne impadroniscono coloro che hanno o dispongono di grandi capitali. Che sono o Paesi stranieri, come nel caso di Israele, oppure grandi interessi economico-finanziari. In altre parole, il complesso militare industriale. Io faccio continui soggiorni a New York per via di una sorella anziana che vado a trovare. Ebbene, le pubblicità alla televisione sono o di case farmaceutiche oppure di conglomerati finanziari che fabbricano direttamente o indirettamente armi.
E qui c’è un altro punto da sottolineare. Se gli Stati Uniti sono in declino dal punto di vista finanziario (vedi BRICS), restano ancora i più forti dal punto di vista militare. Questo è il motivo per cui esiste una continua propensione a militarizzare le crisi. Perché in tal modo i conflitti e le divergenze internazionali vengono portati su un terreno più favorevole agli Stati Uniti.
È un problema che ha radici molto lontane. Già nel 1961, il presidente Dwight D. Eisenhower aveva messo in guardia contro lo strapotere del complesso militare-industriale, che considerava una minaccia alla stessa democrazia americana. Sessantatré anni dopo, il monito più che mai attuale. Tornando a Biden, coloro che gli stavano seduti intorno sono Antony Blinken, Victoria Nuland e, se fosse ancora viva, Madeleine Albright. Personaggi che, se andiamo a vedere chi sono, provengono tutti dall’Europa centro-orientale e hanno fortissimi legami con Israele. Ovviamente però non erano loro a decidere il futuro del Paese. Chi decide è il complesso militare industriale, costituito dalla grande finanza, come BlackRock, e dall’industria che produce armi. In sostanza, il famoso 1% della popolazione statunitense, di cui l’industria delle armi è una componente fondamentale, seguita da quella delle medicine, cioè Big Pharma.
Ma, come tutte le crisi, questo momento offre grandi opportunità. Io auguro a quello che resta della sinistra americana un honeymoon period. Adesso ci sarà la luna di miele di Trump. Io auspico che ce ne sia una analoga per la sinistra degli Stati Uniti, dove esistono personalità interessanti. Ci sono stati dei terzi, quarti, quinti candidati che avevano cose da dire: la candidata verde Jill Stein in primis. Ma la sconfitta dei democratici statunitensi offre un’opportunità anche alla sinistra europea. È il momento di mettere in discussione un gruppo dirigente che è europeo ma non è europeista.
La sconfitta di Kamala Harris agevola anche l’apertura di un dibattito in Italia, perché la sua linea politica è molto simile a quella della sinistra (o cosiddetta sinistra) di casa nostra. Ma non solo. L’insuccesso democratico può racchiudere sorprese anche più in generale per l’Europa. Un’amministrazione Trump potrebbe rendere evidente la differenza di interessi dell’Europa rispetto a quelli degli Stati Uniti. E quindi accentuare gli obiettivi di una battaglia per creare un’Europa più indipendente, che prenda posto in un quadro globale che sia multipolare e non più unipolare. Come diceva una mia vecchia amica degli anni Cinquanta, l’economista britannica Barbara Ward-Jackson, «we need relevant utopias». Abbiamo bisogno di utopie rilevanti. Perché le utopie danno il senso della direzione.