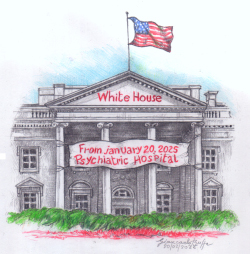Il discorso programmatico che Draghi ha tenuto alle Camere e su cui ha ottenuto, com’era scontato, una larga maggioranza quanto mai composita politicamente non ha fatto che confermare quanto già era stato messo in evidenza nei giorni precedenti. I new entry nella maggioranza, la qualità e il modo della scelta delle ministre (poche) e dei ministri, quindi la composizione del nuovo esecutivo e il come ci si è arrivati, faceva capire che eravamo di fronte ad una sterzata a destra. Era giusto tuttavia attendere il discorso programmatico per un giudizio più ponderato. Ma, appunto, quanto ha detto Draghi al Senato non ha certo attutito questa analisi.
Il suo è stato un discorso privo persino di quel pathos che la drammaticità della situazione avrebbe sollecitato. Il paese, e non solo il nostro, rischia seriamente una nuova massiccia ondata di contagi. Basta vedere l’aumentata pericolosità delle varianti del virus, denunciati da virologi e scienziati esperti in calcoli statistici, come è emerso nella intervista di pochi giorni fa al Prof. Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia dei Lincei. Draghi si è richiamato allo spirito repubblicano. Ma ben altra forza morale, politica e programmatica avrebbe dovuto mettere in campo. Non basta dire che si è uniti da “l’amore per l’Italia”. Nessuno da quello scranno avrebbe potuto dire il contrario.
Draghi ha sentito il bisogno di motivare la ragione per cui un così ampio arco di forze tra loro ben diverse lo sorreggono. Lo ha fatto con affermazioni palesemente contradditorie, segno di un certo imbarazzo. Prima ha lodato il senso di responsabilità delle forze politiche “alle quali è stata chiesta una rinuncia per il bene di tutti”, immediatamente dopo, per cercare di negare il fallimento della politica – cioè quello cui abbiamo effettivamente assistito – ha sostenuto che “nessuno fa un passo indietro rispetto alla propria identità”. Il confine invalicabile resta l’irreversibilità dell’euro e la prospettiva di una Ue capace di sostenere i paesi in recessione. Ma questo era già stato metabolizzato dalla Lega che ha preferito spostare la sua conflittualità sull’apertura delle piste da sci.
Per il resto Draghi ha non solo riservato un omaggio formale a Conte, ma ha sussunto il lavoro del precedente governo sul Recovery Plan, che si tratterebbe solo di approfondire e completare. Del resto non molte ore prima dagli uffici del commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni, era giunta la sollecitazione al nuovo governo a “rimettere le mani sulla granularità dei progetti, sulle riforme che vanno insieme ai progetti di investimento e sulla governance”. Ed è quello che Draghi intende fare, senza grandi sconvolgimenti dell’impianto generale. A dimostrazione che è lì proprio per incarnare, oltre allo spirito repubblicano, anche e soprattutto quello europeo. S’intende: non certo l’Europa dei paesi frugali, o di quelli che negano i più elementari diritti, come Polonia e Ungheria, non certo l’Europa degli Schauble o dei Weidmann, cioè delle vestali più conservatrici del rigore. Ma l’Europa, di cui Draghi negli ultimi anni ha fatto parte in ruoli protagonisti, basata sul rinnovato asse franco tedesco che ha capito che la vecchia politica dell’austerity non poteva funzionare ed ha costruito il “compromesso storico” di fine luglio da cui sono derivati, il Recovery Fund, il debito europeo, il prolungamento della sospensione del patto di stabilità. L’Italia è la terza forza economica nella Ue, il terzo contributore diretto al bilancio europeo: il fallimento del Recovery Plan italiano sarebbe anche la sconfitta del piano europeo.
Quindi Draghi ha subito precisato che la governance deve essere in mano al Mef, guidato da un uomo di sua stretta fiducia, quale Daniele Franco. La crisi non è come un blackout elettrico – ha detto – per cui girato l’interruttore tutto torna come prima. Ma questa ovvia considerazione non lo ha spinto minimamente sul terreno di riforme capaci di incidere sul modello di sviluppo. Neppure ha fatto intendere il modo con cui sciogliere il nodo di come verranno utilizzati i fondi del europei. Secondo i numeri lasciati dal governo uscente, quasi il 40% (circa 74 miliardi) dei fondi che arriveranno come prestiti, dovranno finanziare progetti già esistenti, sostituendo i precedenti prestiti con i nuovi di provenienza europea per ottenere così un risparmio di interessi, peraltro non molto significativo. Ma in questo modo si rinuncerebbe a qualunque innovazione nella scelta sul cosa e sul come investire, con scarse possibilità di incidere su crescita ed occupazione.
In tutto il discorso di Draghi è assente l’idea di uno Stato imprenditore e innovatore sui cui fondare la ricostruzione. Il tema del Mezzogiorno compare oltre la metà del suo discorso, come se non fosse necessario, come ha più volte avvertito il presidente della Svimez, utilizzare la maggioranza dei fondi europei almeno per ridurre le distanze fra Nord e Sud. Oltretutto l’ultimo Fiscal Monitor del Fondo monetario sostiene che investimenti pubblici nelle aree deboli possono avere un moltiplicatore quattro volte più elevato del normale, realizzando un tasso di sviluppo anche quantitativamente, oltre che qualitativamente, superiore. Mentre invece il Piano italiano calcola un moltiplicatore assai ridotto (lo 0,3%), in linea con l’impatto dei modesti investimenti pubblici italiani degli ultimi anni.
Draghi ha parlato molto di ambiente, ma la parola idrogeno è comparsa solo di striscio, quando invece quello verde, ottenuto attraverso energie rinnovabili, è la chiave strategica della conversione ecologica senza cui gli obiettivi di riduzione delle emissioni restano lettera morta. Non è un caso che la Germania si proponga di diventare il pivot mondiale in questo campo strategico.
Il neopresidente del Consiglio ha citato l’aumento delle diseguaglianze, ma non ha pronunciato una parola sul reddito di cittadinanza. Ha ricordato la diminuzione delle aspettative di vita, ma ha detto troppo poco sulla necessità di una riforma sanitaria fondata sul pubblico, nulla contro l’allontanamento dell’età pensionabile. Ha riproposto, seppure in modo più prudente, la tesi del gruppo dei Trenta, da lui finora codiretto insieme a Raghuram Rajan, di sostegni selettivi per evitare di tenere in vita imprese zombie. Il che ha ricordato a molti la “distruzione creatrice” di Schumpeter. Ha fatto riferimento alla fine del blocco dei licenziamenti senza dire che fare concretamente. Ha insistito sull’attenzione agli istituti tecnici, rivelando una propensione verso una dimensione professionalizzante della scuola.
Ha parlato di riduzione del carico fiscale senza precisare come e per chi. Non basta certo il richiamo, costituzionalmente dovuto, alla progressività, che va non solo “preservata” ma reintrodotta, dopo diversi interventi legislativi che l’hanno violata. Siamo al di sotto delle stesse raccomandazioni del 2019 della Commissione europea, la quale chiedeva di “utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico/PIL; spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati”. Così per la pubblica amministrazione vi è solo il richiamo allo smaltimento del lavoro accumulato, mentre sul tema giustizia ha evitato di entrare sulla vexata quaestio della prescrizione. Draghi ha fatto appello ai privati e al terzo settore, non una parola sui sindacati che pure si erano spinti a un endorsement davvero precipitoso.
Per il resto vaghi e stringati cenni sul mondo tenuti insieme da un filoatlantismo a doppia mandata, come se le cose non fossero cambiate in questi ultimi decenni e non stiano mutando nel corso di questa crisi mondiale e epocale. Quasi nulla sugli immigrati. Non una parola per ricordare una vicenda emblematica che ha scosso le coscienze degli abitanti di questo nostro paese ed è tutt’ora squadernata davanti a noi tutti come una ferita aperta: la dolorosa vicenda di Giulio Regeni.
Il fare è il suo credo, ma esiste anche una banalità del fare se questo non è guidato da un forte animo riformatore. Quanto si decide oggi sul Recovery durerà fino al 2026, visto anche il regolamento recentemente deciso in sede europea, superando quindi di un bel tratto i confini dell’attuale legislatura. E le tranche dei finanziamenti seguiranno l’attuazione del programma. Altro che governo a termine. Il programma che è stato tracciato ne prevede addirittura l’ultrattività nella prossima legislatura. A meno che Draghi non venga scelto come successore di Mattarella nelle elezioni del nuovo capo dello Stato nel 2022, cosa che in parecchi ritengono probabile.
Ma proprio la sproporzione fra le dichiarazioni di Draghi e l’enormità dell’impegno da contrarre è tale da considerare indispensabile la costruzione di un’opposizione di sinistra in Parlamento e nel paese. La (ri)definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (pessimo termine quest’ultimo, ma va di moda) non potrà essere un pranzo di gala. Sarà inevitabilmente oggetto di uno scontro tra le diverse parti sociali, fra il Nord e il Sud, oltre che all’interno della maggioranza, visto che Salvini non ha affatto dismesso la sua bellicosità. D’altro canto il M5stelle è travolto da un’ondata di dissensi e di espulsioni che per dimensione assomigliano più a una scissione forzata.
Di fronte a questa situazione, ricca di pericoli quanto di potenzialità, non si capisce perché chi è di sinistra debba rinunciare alla propria identità, ad una propria originalità di proposta sui problemi del paese, infilandosi nella maggioranza di governo. Sento dire e leggo che non bisogna tenersi fuori altrimenti si diventa marginali. Ma fuori da cosa ed eventualmente dentro a che? Non credo che una visione democratica della dialettica politica contempli il fatto che l’area di governo si allarghi a tutto il Parlamento, né che l’opposizione possa essere interpretata dai neofascisti della Meloni. Sarebbe un pessimo servizio alla nostra Costituzione – mai citata nel discorso di Draghi – e soprattutto ad un paese, come il nostro, in preda alla più grave crisi dal dopoguerra ad oggi.