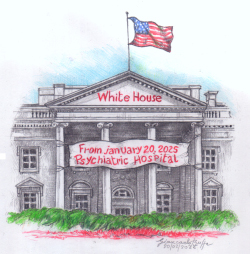La politica, si sa, è fatta di forma e di sostanza. Ed è sotto entrambi questi profili che vanno valutati i primi atti della neopresidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Sul piano formale, la discontinuità rispetto al passato è netta. Così netta da risultare dolorosa, per chi ha ancora a cuore la Repubblica nata dalla Resistenza. Anni e anni di (falsa) retorica imperniata sulla fine delle ideologie, sull’anacronismo delle identità politiche, sulla mancanza di alternative sono stati spazzati via nel breve tornante del processo di formazione del governo. Dalla scelta di ministri dal profilo modestissimo, ma iper-ideologicizzato (come la premier, d’altronde); alla ridenominazione, forzata sino al ridicolo, dei ministeri; alle pose, fisiche e verbali, assunte nell’aula della Camera dalla Presidente durante il discorso sulla fiducia (e, ancor di più, durante la strafottente replica agli interventi delle opposizioni): ciò a cui abbiamo assistito è stata l’ostentazione plateale della propria identità politica da parte dell’estrema destra. La sola area politica rimasta fuori dal patto costituzionale siglato nel 1947, eppure la sola ad avere oggi, a oltre settant’anni dalla sconfitta subita allora, la forza – meglio: la spudoratezza – di mostrarsi esattamente per quello che è. È questo che, più di tutto, addolora: che tale oscena ostentazione avvenga proprio mentre a provare vergogna di se stessi – della propria storia e dei propri ideali – siano oggi le aree politiche animate dagli eredi di coloro che nella guerra di Liberazione, prima, e nella costruzione della Repubblica, dopo, seppero stare dalla parte giusta.
Sul piano sostanziale, il ragionamento è più complesso. Sia pure mantenendo i toni su un registro sempre politicamente sguaiato, solo in parte il contenuto dell’intervento meloniano è risultato in rottura con il passato. Al contrario, tratti importanti della concezione dello Stato esposta dalla leader di Fratelli d’Italia sono in continuità non solo con la visione politica del governo Draghi, ma, più in generale, con quella dei governi che hanno essenzialmente connotato la, così impropriamente detta, Seconda Repubblica.
Si può partire dalla risalente idea liberista dello Stato guardiano notturno, il cui compito essenziale è quello non di guidare, ma di lasciar fare i proprietari, eliminando ogni ostacolo al virtuoso dispiegarsi dell’iniziativa economica privata («il nostro motto sarà “non disturbare chi vuole fare”»). Un’idea a cui logicamente si ricollegano sia la concezione dello Stato della crescita, che subordina la questione ambientale all’economia (la priorità è «rimuovere tutti gli ostacoli che frenano la crescita economica»), svilendo la natura a risorsa economica («è … soprattutto una risorsa economica di valore inestimabile, che alimenta la nostra industria turistica e culturale»); sia la concezione dello Stato minimo, che, riducendo quanto più possibile il prelievo fiscale, non redistribuisce ricchezza né riguardo al passato (grazie a condoni ribattezzati «tregua fiscale»: come se far rispettare la legge agli evasori fosse un atto di guerra), né riguardo al futuro (grazie alla flat tax, presentata come si trattasse di una misura di equità).
A giustificazione delle conseguenti, inevitabili diseguaglianze ecco, quindi, la visione dello Stato meritocratico, che, concependo, come nell’Ottocento, l’uguaglianza in termini solo formali, cristallizza le diseguaglianze esistenti non solo tra le persone, ma anche tra i territori (esattamente quello a cui mira il regionalismo differenziato: a premiare le regioni più meritevoli). Quanto ai rischi potenzialmente derivanti dall’abbandono degli ultimi a se stessi sarà lo Stato forte a farvi fronte («vogliamo fare della sicurezza un dato distintivo di questo esecutivo»). E ciò tanto all’interno, quanto all’esterno dei confini statali: contro le lotte scaturenti dal disagio sociale, così come contro i migranti («intendiamo proporre il blocco delle partenze dei barconi dal nord Africa»); oltre che, ovviamente, nelle relazioni internazionali, dove l’atlantismo armato fino ai denti rimane dogma indiscutibile («l’Italia continuerà ad essere partner affidabile in seno all’Alleanza Atlantica»).
A coronamento del tutto, la trasformazione dello Stato democratico in uno Stato autoritario, da sancirsi, grazie al presidenzialismo in ambiente pluripartitico (e, dunque, con un Presidente inevitabilmente di minoranza), attraverso il definitivo spostamento della centralità del sistema istituzionale dal Parlamento, organo che rappresenta tutti, al Presidente, organo monocratico di parte, posto in condizione di spadroneggiare per la durata della legislatura (vogliamo «una riforma che consenta all’Italia di passare da una “democrazia interloquente” a una “democrazia decidente”»).
Sono tutti temi, quelli sinora ricordati, che sono stati spinti all’estremo da Giorgia Meloni – apertamente rivendicati, anziché mistificati, se si vuole – ma che certamente non risultano avulsi dalle politiche realizzate, o quantomeno perseguite, dai governi degli ultimi trent’anni: e ciò vale per il dominio dell’economia sulla politica, per il culto della crescita economica fine a se stessa, per l’abbandono della lotta alle disuguaglianze, per l’adozione acritica dell’ideologia del merito, per la repressione securitaria di poveri e migranti, per il bellicismo sul piano internazionale, per la ricerca della torsione verticistica a livello istituzionale.
Diverso discorso vale, invece, per gli ultimi due profili dell’idea di Stato propugnata dalla Presidente del Consiglio innanzi alla Camera.
Sicuramente in discontinuità anche sostanziale con il passato è la visione dello Stato confessionale e patriarcale che emerge dal rifiuto di ogni apertura sulle questioni etiche che investono i diritti civili: l’aborto, l’eutanasia, le relazioni omosessuali, le questioni di genere. Dice tutto, nella sua volgarità, il passaggio in cui Meloni irride gli oppositori affermando di non aver «mai considerato che la grandezza della libertà delle donne fosse potersi far chiamare “capatrena”».
E altrettanto discontinua rispetto al passato risulta l’idea, ossessivamente ripetuta, dello Stato nazionalista, in nome del quale non solo è prospettata una relazione potenzialmente conflittuale con l’Europa, quantomeno tutte le volte in cui sarà in gioco la prevalenza dell’interesse nazionale, ma, soprattutto, è avanzata la riproposizione in veste nuova di temi identitari chiaramente riconducibili alla visione politica propria del fascismo. Ricorre proprio a tale proposito il passaggio più orribile dell’intero discorso meloniano, quello in cui proclama: «sono pronta a fare quello che va fatto, a costo di non essere compresa, perfino non essere rieletta, per rendere il destino di questa Nazione più agevole». Il destino della Nazione! Da agevolare a qualsiasi costo, anche quello, estremo, del sacrifico personale: la più pura ideologia totalitarista, per la quale l’individuo non è un fine in sé, ma un mero strumento del più grande disegno nazionale che tutto trascende. Non è, dunque, un caso che l’intero discorso di Meloni sia privo di una chiara e univoca condanna del fascismo, ricorrendo soltanto la solita furbesca equiparazione tra fascismo e comunismo («non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime, fascismo compreso»: come se il rapporto con il totalitarismo fosse una questione di simpatia…) e la solita lamentosa invocazione della «pacificazione» tra le vittime e i carnefici: equiparazione e pacificazione – va ribadito – costituzionalmente insostenibili, perché, mentre i comunisti furono parte decisiva del patto costituzionale, i fascisti, proprio in quanto tali, ne risultarono radicalmente esclusi.
Ricapitolando: Stato guardiano notturno, della crescita, minimo, meritocratico, forte, autoritario, confessionale e patriarcale, nazionalista. Sono queste le qualificazioni apertamente rivendicate dall’estrema destra di governo quali componenti costitutive della propria visione del mondo. La sfida per le forze democratiche all’opposizione è oggi quella di riconoscerle come tali e di rifiutarle tutte, incluse quelle nei confronti delle quali in molte si sono dimostrate, sinora, culturalmente succubi. La forza odierna della destra deriva (anche) dalla sua capacità di costruire un discorso politico coerente: e, quindi, convincente. C’è da essere certi che l’opposizione saprà essere altrettanto salda e coesa nel respingere e combattere il confessionalismo, il patriarcato e il nazionalismo identitario. La questione è: saprà fare lo stesso nei confronti degli altri elementi della visione politica meloniana? È lecito dubitarne, dal momento che, per farlo, dovrebbe ricostruire, praticamente da zero, una cultura politica capace di assumere quali valori di riferimento – oltre alla laicità, alla non discriminazione e all’internazionalismo – la centralità della politica, il raggiungimento dell’equilibrio economico e ambientale, l’intervento pubblico nell’economia, l’uguaglianza in senso sostanziale (da realizzarsi tramite i diritti sociali e la progressività fiscale), la solidarietà internazionale e la pace, la valorizzazione del dissenso, il parlamentarismo basato sulla legge elettorale proporzionale e su partiti politici nuovamente solidi e radicati. Vasto programma, si dirà. In realtà, nemmeno tanto: molte delle cose da fare sono oramai ben note e studiate sin nelle proposte di dettaglio. Il vero problema è la (mancanza della) volontà politica: è su questo che bisognerà iniziare al più presto a lavorare.