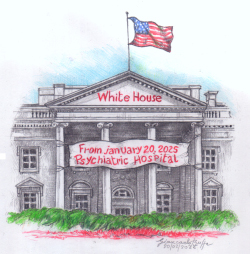Il dibattito in corso su questo giornale sul fallimento delle Regioni, condotto da F. Barbera, A. D’Orsi, L. Ronchetti, B. Sangineto merita di essere ripreso. È il caso di ricordare che le istituzioni non si inventano a tavolino, ma rappresentano forme di regolazione degli interessi collettivi sorgenti da bisogni locali, morfologie del territorio, culture diffuse, tradizioni storiche. E qui torna in mente Carlo Cattaneo, che nel suo La città considerata come principio ideale delle istorie italiane notava come nessun abitante di Bergamo o di Lodi si definisse lombardo, identificandosi quale abitante di quella regione, ma come bergamasco e lodigiano.
A lungo tuttavia quella dei comuni è stata immaginata come una storia limitata all’Italia centro-settentrionale, pagina di indubbio splendore civile, trascurando le esperienze coeve del Mezzogiorno. Che non sono state alla pari, ma certo non marginali, come mostra la recente ricerca storica, non solo per il ruolo avuto dai comuni (università), pur all’interno dell’ordinamento feudale del Regno, ma per il protagonismo di tante città. Non è del resto senza significato se ancora oggi un napoletano o un salernitano stenteranno a presentarsi come campani cosi come un abitante di Bari o Lecce non sente alcuna necessità di dirsi pugliese al cospetto di un forestiero.
Ovviamente l’osservazione vale per regioni “artificiali” come il Lazio e a maggior ragione per quelle del Centro-Nord. Dunque un rapporto di identificazione storica dei cittadini col territorio regionale si può rinvenire forse per la Calabria, con più deboli tradizioni cittadine (ma a lungo definite le Calabrie), e le isole, ma ricordando la preminenza delle città nella storia della Sicilia.
Dunque a una lunga vicenda di ordinamenti amministrativi incentrati sui comuni, coordinati da un’altra istituzione storica di antica data, le province, rispondenti alla necessità di una tessitura di più ampio raccordo territoriale, si è sovrapposto, nel 1970, un castello istituzionale che non rispondeva ad alcun bisogno amministrativo, senza alcun fondamento culturale, privo di radici storiche che non fossero le remote regioni augustee.
Il nuovo organismo, cui erano affidate più cospicue risorse pubbliche e più estese autonomie, veniva a comportare per i cittadini un ulteriore compito di partecipazione e di controllo democratico, che si aggiungeva a quello richiesto storicamente dagli altri organismi. Un compito che poteva essere svolto solo grazie alla presenza di forze organizzate, i partiti, in grado di assolvere i nuovi impegni di rappresentanza.
E difatti alcune regioni del centro Nord, nei primi decenni, hanno svolto con qualche efficacia i nuovi compiti, soprattutto laddove il Partito comunista italiano – il principale agente di disciplinamento civile dell’Italia repubblicana – aveva più estesi insediamenti, come in Emilia e Toscana ed Umbria. Significativamente, la progressiva degenerazione di questo istituto, diventato un centro moltiplicatore di spesa pubblica incontrollata, inizia con la dissoluzione clientelare dei grandi partiti, di cui gli stessi governi regionali hanno costituito un terreno di coltura e sviluppo. Sarebbe oltremodo interessante una ricostruzione storica del ruolo avuto da tali organismi nella formazione del nostro debito pubblico.
Naturalmente la degenerazione delle Regioni ha preso a galoppare dopo la riforma del sistema elettorale del 1999. L’elezione diretta del presidente, diventato ben presto una sorta di sovrano assoluto, con conseguente emarginazione del Consiglio regionale e l’affidamento di fatto del controllo di legalità agli organi della magistratura. La riforma del Titolo V della Costituzione ha inevitabilmente portato alla situazione attuale: le regioni non tendono ad allargare il potere, stanno disarticolando le stato, puntano, con l’autonomia differenziata, a smembrare il Paese.
Uno stato-unitario che ha poco più di 150 anni di vita. Una prova inquietante di questa deriva è venuta lo scorso anno dal semiconsenso alla richiesta di autonomia differenziata da parte di Veneto, Lombarida e Emilia esibito da De Luca ed Emiliano e dal silenzio degli altri presidenti meridionali. E’ evidente che tutti i nostri cacicchi, a Nord e a Sud, un pugno di politici mediocri e irresponsabili, sono pronti a fare ritornare l’Italia agli statarelli preunitari per pura ambizione personale.
Ora non si tratta di difendere il vecchio centralismo, occorre rafforzare al contrario il potere dei comuni, l’organo più vicino alla possibilità di controllo dei cittadini, rendendo più democratico e trasparente il loro governo e ridando nuove e più ampie funzioni di raccordo territoriale alle province. È il modo di rispondere ai bisogni di decentramento di uno stato moderno senza mandarlo in pezzi. Occorre ricordare che la politica è vittima del crollo antropologico subito dalle società in Occidente. Nessun legame ideale tieni più uniti i Narcisi solitari che son diventati i cittadini. Lasciare pezzi di territorio in mano a poteri personali è un rischio che l’Italia non può correre.