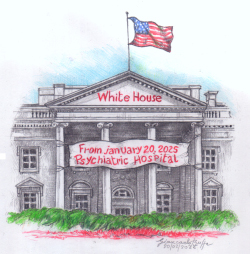Verrebbe persino da provarne pietà, se non fosse per tutto il male che ha fatto e tutto l’odio che ha sparso. Il pomeriggio del 20 di agosto nell’aula del Senato è stato per Matteo Salvini una via crucis dai cui dolori nessun rosario ha potuto alleviarlo. Nei quaranta minuti della durissima, fredda e implacabile requisitoria di Giuseppe Conte dalla tribuna del Governo e nei venti della sua sgangherata replica dai banchi della Lega – un’ora esatta, in tutto – l’immagine del Capitano si è sfaldata come un presepe di sabbia, lasciando dietro di sé uno sguardo ebete, smarrito, di chi stenta a rendersi conto dell’urto che lo ha travolto, un volto gonfio e sfatto per mancanza di sonno e di idee, e infine un gruppo di sodali allo sbando portati sull’orlo di una crisi di nervi da un uomo solo al comando che si è buttato nell’abisso.
“Pugile suonato”, “pallone sgonfiato”, “cane bastonato”, “Beach leader spiaggiato” imperversano i social. E poi “Capitan Schettino”, “Capitan Mitraglia (a salve)”, persino “pistola” (“quando un pistola incontra un uomo con il fucile – ha scritto Travaglio parafrasando Clint Eastwood – il pistola è un uomo morto”). Mentre sulle prime pagine dei grandi giornali si affonda il coltello: “L’ultimo Bacione” (Repubblica), “Irresponsabile, ignorante e codardo” (Il Fatto), “Le sberle di Conte a Salvini” (Il Resto del Carlino)…
Nemmeno la dignità che in genere ci si riserva per i gran finali si è concesso Matteo Salvini, tentando, a conclusione del suo miserando intervento, di cancellare le tracce del proprio operato per attribuire ai colloqui “da mesi in atto” tra Di Maio e Renzi la vera causa della crisi che tutti noi, praticamente a telecamere aperte, abbiamo visto aperta invece da lui in persona, senza intermediari né mezze parole. E ordinando allo scudiero Centinaio di ritirare fuori tempo massimo la sfiducia al governo che lui stesso, dieci giorni prima, aveva dichiarato morto, come se quell’espediente postumo potesse estinguerne la colpa. Il tutto dopo aver aperto il discorso con la fatidica frase: “rifarei tutto quello che ho fatto”…
Da tempo aspettavamo che, secondo le ferree leggi dei tragici greci, alla Hybris del truce potente seguisse l’inevitabile Nemesis voluta dagli dei. E potremmo dire che questa è venuta con particolare prontezza, persino bruciando i tempi della normale maturazione drammaturgica (per Berlusconi c’erano voluti quasi vent’anni, per Renzi mille giorni…). E tuttavia aspetterei a festeggiare, nonostante l’impazienza del coro a proclamare il “Giustizia è fatta” e ad attaccare il “Te Deum”. Per almeno due ragioni.
Intanto perché se ieri Salvini è morto in Senato, non è detto che non possa rinascere nel Paese domani. Se tra i legni e i broccati ben pettinati dell’aula di Palazzo Madama è potuto apparire per quel nulla che è, non altrettanto vale per quella specie di suburra in cui si è trasformata la parte più bassa e disgregata della società italiana, dove la sgrammaticatura (linguistica e politica) paga, la millanteria premia e la povertà mentale può apparire concretezza o, quantomeno, condivisione di destino. E attenzione! Quella parte “bassa e disgregata” non è affatto un’area ristretta e residuale, periferica e minoritaria come poteva esser considerata un tempo, è un bacino che si è esteso e intorbidito negli ultimi anni, man mano che si erodeva e disgregava l’intera struttura della società sotto la forza distruttiva di una crisi economica e sociale che è risalita per li rami dalle antiche classi lavoratrici (massacrate dalla precarizzazione e dalla concorrenza sul mercato del lavoro globale) al vecchio e nuovo ceto medio.
Forse non abbiamo dedicato alla cosa la necessaria attenzione: ma i successivi “salti in avanti” del consenso per Salvini e la sua Lega in quest’anno di governo giallo-verde coincidono quasi perfettamente con le sue esibizioni di maggior “scorrettezza” e di più ostentata disumanità: la guerra dichiarata alle Ong che salvano, a cominciare dal caso dell’Aquarius (una settimana prima del diniego di sbarco per i 629 salvati dalla nave di Medici senza frontiere, cioè all’inizio di giugno del 2018, la Lega era quotata al 23%, alla fine del mese era balzata al 28%), il salto di qualità con la Diciotti (il sequestro dei suoi 190 naufraghi è incominciato il 20 di agosto, in quello stesso mese il consenso per la Lega è passato dal 29% al 32%, sorpassando i 5 Stelle), l’ossessiva politica dei “porti chiusi”, la solidarietà militante con i giustizieri di se stessi (il gommista di Monte San Savino, il tabaccaio di Ivrea), la tolleranza benevola con i responsabili di atti di razzismo o di xenofobia. Simmetricamente dovrebbe farci pensare che non ha spostato di un millimetro la curva del consenso per Salvini lo scandalo Rubligate, anzi questa ha continuato a salire (era al 35,7 alla fine di giugno, è passata al 37,7 alla metà di luglio), così come non hanno pesato i 49 milioni di Euro fatti sparire…
La lunga lista di scorrettezze istituzionali, abusi di potere, sconfinamenti, ignoranza o trasgressione delle regole presentata da Giuseppe Conte al suo Ministro fedifrago hanno colpito la ristretta cerchia degli addetti ai lavori e dei cronisti parlamentari, gli ammalati di politica come noi, ma all’Italia del Papeete e delle grigliate di Ferragosto non ne è arrivato neppure un refolo di vento, figurarsi la tempesta che servirebbe per spazzar via quell’ammasso di voti rancorosi che chiede riti barbarici e sacrifici umani… Se si votasse oggi, o tra due mesi (il che è lo stesso) quel consenso greve resterebbe probabilmente inchiodato su percentuali non molto minori di quelle di prima della crisi. Senza passare per una fase, non breve, comunque non brevissima, di decompressione o di decontaminazione – una qualche tregua di Dio in cui al Capitan Fracassa di ieri sia tolto il piedistallo ministeriale – difficilmente si intaccherebbe il capitale di cieco consenso accumulato in questi mesi di uso spregiudicato dei propri gradi dorati di ministro di polizia.
Una buona parte del successo di Matteo Salvini in questo anno abbondante di permanenza al Viminale è legata al Viminale stesso. A quello straordinario megafono mediatico che è la carica di Ministro di Polizia: l’uomo della forza, quello che può chiudere i porti e mettere a tacere le coscienze con una firma. La sua immagine si è dilatata a dismisura, fino a ridurre nell’ombra il resto della squadra di governo, perché era lui, in qualche modo, il Governo: il governo delle cose, non delle carte, quello che poteva sdoganare i peggiori sentimenti perché istituzionalmente custode della Legge e dell’Ordine, che con un gesto o un fonogramma poteva provocare la sofferenza e minacciare la morte di centinaia di esseri umani, il che, nella visione primordiale delle cose, è il solo, autentico segno del potere.
Ci pensino bene quelli – e non sono pochi – che guardano con una certa indifferenza, o magari anche con simpatia, alla possibilità del “voto subito”. Che pensano che in fondo, dato che con le europee gli equilibri nel paese sono cambiati, è bene adeguare il parlamento a quel nuovo assetto. O che si fregano le mani all’idea che gli odiati 5 Stelle siano finalmente dimezzati, ridotti a un terzo, cancellati. O magari che si illudono che il “gatto di Schrödinger”, chiuso nella scatola confezionatagli dal suo ex premier, sia defunto. Ci pensino davvero bene, perché il “voto subito” significherebbe non solo dar ragione, postuma, al Salvini che ha voluto e aperto la crisi di governo (riabilitare Capitan Schettino elevandolo al rango dell’eroe De Falco), ma anche aprirgli un’autostrada verso la conquista di una maggioranza (in ticket con la Meloni) che schiaccerebbe ogni residua resistenza di legalità costituzionale. Ci pensi bene soprattutto Zingaretti, magari controllando in qualche modo la voglia matta che ha di liberarsi finalmente della zavorra renziana, perché se per togliersi quello sfizio consegnasse il Paese alla peggior destra della nostra storia repubblicana, nessuno glielo potrebbe mai perdonare.
Naturalmente può darsi che tutto questo non basti. Che una drastica astensione dal potere non produca il dimagrimento sperato, e che la possibilità di gestire dalle piazze anziché dal Palazzo il drammatico passaggio di una manovra economica che non sarà di certo popolare (anche se indispensabile a evitare il default) permetterebbe allo sconfitto nel duello istituzionale un’ulteriore abbuffata di voti e simpatie “popolari”. Una ragione in più non per “votare subito” ma per tentare di mettere insieme una coalizione di governo di “sicurezza costituzionale”, capace di durare almeno fino all’inizio del 2022 (quando si eleggerà il nuovo Presidente della repubblica) e di fare una riforma elettorale in senso proporzionale puro che allontani il rischio che una maggioranza nero-verde di tipo weimariano possa manomettere la Costituzione senza neppur bisogno di un referendum confermativo e ridisegnare a propria immagine la composizione della Corte.
Questa non è – con tutta evidenza – una normale crisi di governo. E’ una crisi di sistema. Una situazione di disgregazione istituzionale e sociale in cui nessuna forza in campo appare più credibile non solo alle altre ma neppure a se stessa. In cui, come si dice, nessuno si fida più di nessuno. E ognuno dei player in campo è uno e bino, diviso al suo interno in frazioni e in fazioni diffidenti e gelose. Una di quelle condizioni in cui filosofi e teologi consigliano il ricorso al “principio di prudenza” più che a quello di prestazione.