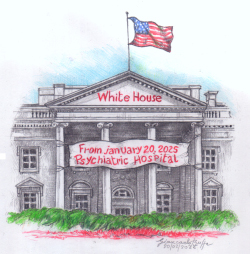“Preferirei chiamarlo nuovo socialismo. So che a molti non piace questo termine, ma è l’unico che abbiamo a disposizione per parlare del superamento del capitalismo”. Fanno rumore, le idee di Thomas Piketty. Salito alla ribalta delle cronache – e delle classifiche di vendita – dopo le crisi dei debiti in Italia e Grecia con “Il capitale nel XXI secolo” (2013), un monumentale saggio sulle disuguaglianze economiche nell’era delle globalizzazione, l’economista francese è diventato l’ideologo della sinistra alla ricerca di una nuova identità dopo le terze vie mercatiste di Clinton e Blair. “Capitale e ideologia” (La Nave di Teseo) è il titolo del suo nuovo saggio, che in comune col predecessore ha il numero di pagine e l’uscita in coincidenza con una crisi di sistema. Di diverso, un’agenda ancora più politica e radicale: “Il processo verso un economia più giusta e sostenibile si è messo in moto già dopo la crisi finanziaria del 2008 – dichiara Piketty a Fanpage.it – ,ma questa pandemia sarà un nuovo punto di svolta di questo lungo processo di costruzione di un’organizzazione economica e di una globalizzazione migliore”.
Professor Piketty, In un suo articolo uscito su Le Monde lei ha detto che gli sconvolgimenti politico-ideologici sono solo all’inizio. Di quali sconvolgimenti parla?
Questa crisi contribuirà a porre importanti questioni all’ideologia economica dominante oggi, a partire dall’idea che non ci siano abbastanza soldi per investire in strutture pubbliche come gli ospedali. E più in generale ogni certezza sulla globalizzazione e sul commercio mondiale sarà messa in discussione da questa crisi.
In che direzione cambierà tutto?
Per l’appunto, Il problema è capire come. Quando dico che gli sconvolgimenti sono solo all’inizio non parlo solo della profondità del cambiamento, ma del fatto che non vi sia ancora un’ideologia alternativa a quella attuale. Alla fase acuta dell’epidemia si è reagito in un modo molto semplice: abbiamo chiuso tutto. Molto più difficile è capire, in questo nuovo mondo, quale globalizzazione sia giusta, quale commercio internazionale sia giusto. E che limiti porre a tutto questo.
Il problema è se saranno mai posti dei limiti…
Anche. Il rischio enorme è che in assenza di alternative si torni all’attuale ideologia dominante: che finiremo per tenerci la globalizzazione, la libera circolazione di merci e capitali e i paradisi fiscali, come se il Coronavirus non ci fosse mai stato. Questa è l’ideologia dominante degli ultimi decenni, quella che dobbiamo cambiare. Con “Capitale e ideologia” ho provato a dare il mio contributo, ma è un compito collettivo cui siamo chiamati a rispondere: ci vorrà molto tempo per avere anche solo un corredo di principi alternativi al dogma della proprietà privata e alla libera circolazione di merci e capitali.
Dobbiamo necessariamente mettere in discussione la proprietà privata e il libero mercato?
Io credo di sì, anche se diverse persone, in buona fede, pensano che non sia il caso: se cominciamo a mettere limiti a tutto questo attraverso tasse, tariffe e altre limitazioni alla libera circolazione dei capitali dove ci fermeremo, pensano?
Già, dove ci fermeremo?
Queste persone fanno lo stesso errore di chi sacralizzando la proprietà privata, frena ogni possibilità di redistribuzione reale della ricchezza. Io penso che si possa arrivare a decidere collettivamente dei limiti. Ad esempio, le merci che arrivano da molto lontano producono emissioni di anidride carbonica in eccesso e non ci sarebbe nulla di male nel prevedere tasse o tariffe per queste emissioni in eccesso.
La famosa Carbon Tax di cui si parla da anni in Europa…
Ma non si fa, e lo sa perché?
Perché?
Perché per fare una Carbon Tax europea è necessaria l’unanimità di tutti i Paesi dell’Unione. E nessuna delle grandi potenze europee, né la Germania, né la Francia, né l’Italia sembrano voler cambiare questa semplice regoletta.
La sua agenda è molto più radicale di una semplice Carbon Tax, però. Lei nel suo libro dice che vuole superare il capitalismo. Che cosa intende, con questa frase?
Intendo dire che dovremmo guardarci alla spalle, al ventesimo secolo, e chiederci quali sono le idee che hanno funzionato meglio, quelle che hanno fatto crescere la ricchezza e ridotto le disuguaglianze.
Quali sono, queste idee?
Sono tre, soprattutto: giustizia educativa, più diritti ai lavoratori e progressività fiscale per redistribuire ricchezza e benessere.
Partiamo dalla giustizia educativa…
Questo è un punto centrale, perché è il fattore principale con cui riduciamo l’ingiustizia sociale e aumentiamo la produttività economica. Sfortunatamente proprio negli scorsi decenni si è registrata una stagnazione della spesa per la formazione, nonostante abbiamo una percentuale sempre maggiore di persone che vanno all’università. Questo è uno spreco enorme di tempo, risorse e di capitale umano: chi oggi frequenta le università dovrebbe pretendere una formazione migliore, adeguata ai suoi bisogni, cosa che troppo spesso non accade. Questa è la prima cosa.
La seconda?
La seconda e la terza assieme. Perché entrambe puntano allo stesso obiettivo: andare oltre alle relazioni di pura proprietà privata. E questo si ottiene attraverso maggiori diritti ai lavoratori e una maggiore progressività fiscale.
Partiamo dai maggiori diritti ai lavoratori…
E torniamo al Novecento. Nel secondo dopoguerra, c’erano Paesi come la Svezia o la Germania in cui i lavoratori e le loro rappresentanze avevano più del 50% dei voti nei consigli di amministrazione di alcune grandi imprese, indipendentemente dalle quote di azioni che possedevano. E in più, detenevano pure il 10% o il 20% delle azioni dell’impresa. Questo è un altro modo di intendere la proprietà, che è già esistito, e che ha mostrato ottimi risultati nella pianificazione delle strategie a lungo termine delle imprese.
E allora perché non c’è più, nemmeno in Germania e Svezia?
Perché non piace per nulla a chi possiede il restante 80%, 90% delle azioni. E perché tutti i governi pongono la stessa obiezione: che non possiamo farlo da soli, che dobbiamo aspettare l’Unione Europea o le Nazioni Unite. È una pazzia, questa. Germania e Svezia hanno fatto da soli allora: perché non si può più fare da soli oggi?
Come, ad esempio?
Si potrebbe porre un limite del 10% a ciascun azionista di una società per azioni, qualunque sia la sua percentuale di quote. E lo faremmo sfidando la sacralità della proprietà privata, perché una struttura più bilanciata del potere economico porta benefici alla società, e lo sappiamo perché è già successo. Per di più viviamo in una società estremamente istruita: l’idea che le idee migliori possano venire solo a quell’individuo singolo di 30, 50, 70 o 90 anni che controlla quella società è semplicemente assurda.
Arriviamo alla progressività fiscale…
La progressività fiscale dei redditi e delle ricchezze ereditate è stata usata anch’essa a piene mani durante il Novecento. Per dire, tra gli anni 30 e gli anni 80 del secolo scorso, l’aliquota più alta, quella per la frazione maggiore della ricchezza, era pari all’80% circa. In quel periodo l’economia è cresciuta due volte tanto quanto è cresciuta nei quarant’anni successivi e la produttività era alle stelle, mentre ora è stagnante. L’aumento della disuguaglianza, che secondo la narrativa attuale, avrebbe portato più innovazione e più crescita, noi non l’abbiamo vista. La promessa di Reagan, che tutti avrebbero vinto, con più disuguaglianza, è stata semplicemente tradita. La verità, semplice e banale, è che oggi abbiamo molti più miliardari rispetto a trent’anni fa ma molta meno crescita economica. La verità è che per avere più prosperità economica devi avere un economia più inclusiva. Questa per me è la via giusta per superare il capitalismo.
E quella sbagliata?
Distruggere il sistema senza pensare a quel che verrà dopo. Che è quello che è successo durante la rivoluzione bolscevica, che di fatto è stata la presa di potere di un clan che ha tenuto per sé tutti i diritti di proprietà e ogni potere di decisione politica. Tutto centralizzato. Un nuovo socialismo partecipativo, che propongo nel mio libro, si basa invece sulla decentralizzazione e sulla distribuzione della proprietà e del potere decisionale. Una società scalabile attraverso la formazione, in cui tutti partecipano alle decisioni, in cui le rendite di posizione come le ricchezze ereditate finanziano beni pubblici attraverso la progressività redistribuzione fiscale. È un socialismo che si fonda su una proprietà privata di grandezza relativa. Non sui soviet.
Non è un paradosso?
No, è un evoluzione. Il problema dei socialisti e dei comunisti è che non hanno mai trovato una collocazione alla proprietà privata, che era alternativamente da distruggere o da accumulare. Io non credo di aver trovato il sistema perfetto, ma credo che possa essere un buon compromesso fondato sulle migliori idee del passato.
Potremmo chiamarla “terza via”, se non avessero già il copyright Tony Blair e Bill Clinton…
Preferirei chiamarlo nuovo socialismo. Perché alla fine questo è. So che a molti non piace questo termine, ma è l’unico che abbiamo a disposizione per parlare del superamento del capitalismo.
C’è un altro rischio all’orizzonte. Che il capitalismo lo superino i giganti tecnologici e gli Stati fondando il nuovo mondo sul controllo sociale e sulla fine della privacy, legittimate dall’emergenza sanitaria. Lei considera possibile uno scenario simile? E come crede sia possibile evitarlo?
Il rischio c’è ed è un rischio serio. I giganti tecnologici hanno beneficiato parecchio della crisi a discapito delle piccole aziende, e si sono ingranditi ulteriormente. Né Trump oggi né Obama ieri, del resto, sono riusciti a regolare il loro strapotere.
Ha fiducia del fatto che una vittoria di Joe Biden contro Donald Trump possa migliorare le cose?
Potrebbe migliorare sicuramente le cose anche se non è la miglior leadership democratica possibile. Però credo che non abbia senso aspettare la miglior leadership democratica possibile, ora come ora. Soprattutto noi in Europa dobbiamo regolare questi fenomeni, senza aspettare che lo facciano gli americani. Parliamo tanto di sovranità, ma la sovranità passa anche e soprattutto dalla capacità di regolare i grandi processi economici globali. E in questo caso sì, di farlo su scala macro-regionale.
Però lei prima ha detto che gli Stati non devono aspettare le grandi entità sovra statuali per attuare riforme radicali…
Le scale sono diverse. Io sono internazionalista e credo che vada ricostruito l’internazionalismo partendo da un numero limitato di Paesi e mettendo una serie di condizioni, regolazioni e sanzioni per chi non le rispetta. Anche in Europa.
Torniamo a parlare di Unione Europea, allora, e delle misure prese per combattere la crisi del Coronavirus. Che ne pensa del recovery fund? Può essere l’embrione di una nuova Europa?
Non credo sia così. Il problema del Recovery Fund è che non ha una dimensione democratica. È ancora figlio di un processo decisionale opaco figlio della regola dell’unanimità e delle riunioni a porte chiuse tra capi di Stato e di governo. Non è il giusto processo. Io credo che l’idea del Recovery Fund, che è buona, vada combinata con un diverso processo democratico europeo. Che è già in atto, peraltro, anche se ci siamo dimenticati dove.
Dove?
Francia e Germania lo scorso anno hanno creato un’assemblea parlamentare congiunta che si incontra a Strasburgo formata da 50 parlamentari francesi e tedeschi provenienti da ciascun gruppo politico. Quest’assemblea ha due problemi: il primo è che è solo franco-tedesca. Il secondo, che è solo consultiva. Però potrebbe essere diversa.
Come?
Francia e Germania potrebbero votare domani un loro recovery fund che avrebbe un’enorme legittimazione democratica di fronte ai cittadini di entrambi i Paesi. E farlo a maggioranza, peraltro. Quell’assemblea potrebbe decidere dove investire quei soldi, potrebbe decidere quali settori tassare.
Questo cosa significa?
Che domani quell’assemblea potrebbe essere composta da più di due Paesi e prendere decisioni simili, a maggioranza, senza bisogno di nessuna unanimità, con un processo decisionale pubblico e trasparente. E in quel contesto ci sarebbe la possibilità di prendere decisioni, non solo di discutere. Quell’assemblea, a mio avviso, avrebbe costruito qualcosa di migliore dell’attuale Recovery Fund.
Lei crede accadrà?
Io credo che potrebbe accadereì. Perché la Germania, che pure in quel contesto rischierebbe di perdere parte del suo potere sull’Europa, non potrebbe dire di no. I tedeschi credono nel parlamentarismo, e nella democrazia rappresentativa. Sarebbe difficile giustificare la propria contrarietà in un progetto simile.
C’è un problema però. Francia, Germania, Italia e Spagna non hanno governi nazionalisti, ma movimenti nazionalisti in testa ai sondaggi o in rapida ascesa. Non teme che prima di questo processo possa avvenire la loro ascesa? I dati economici si annunciano terribili, per l’Europa…
Aggiungo: anche i processi decisionali di cui parlavamo prima, tecnocratici e poco trasparenti, concorrono ad alimentare lo scetticismo nei confronti dell’Europa. Serve un agenda radicale e servono misure simboliche per cambiare la traiettoria nazionalista. In Italia e Francia oggi i nazionalisti si sentono poco, ma torneranno, e torneranno fortissimo se non cambiamo tutto prima che sia troppo tardi.
Intervista all’economista francese, da poco in libreria col suo nuovo libro “Capitale e Ideologia”: “Bisogna andare oltre al dogma della proprietà privata e del libero scambio. E bisogna dare più potere ai lavoratori nelle imprese