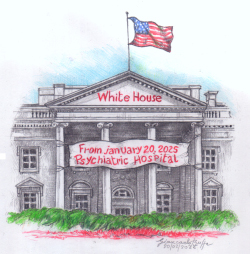1.
Allarme. Credo sia questo il sentimento che accomuna tutti noi critici dell’autonomia differenziata. È fondato? Sarebbe questa immagino la domanda che ci porrebbero, non dico i fautori dell’autonomia differenziata, ma coloro che seguono distrattamente e – forse – con poca consapevolezza il dibattito politico sul tema. In fondo, potrebbero dirci, si tratta solo di attuare la Costituzione, dando seguito a quanto previsto all’articolo 116, 3° comma. Un argomento che potrebbe addirittura essere rivolto in termini polemici a chi, come noi, ha sempre sostenuto la necessità di dare una rigorosa applicazione ai principi costituzionali. Qualcuno potrebbe persino pensare che le nostre preoccupazioni siano dettate da una preconcetta avversione a ogni tipo di autonomia regionale.
Per rispondere all’interrogativo e fugare certi timori è necessario chiarire che la nostra inquietudine non riguarda il principio di autonomia, che può essere declinato in diversi e opposti modi, piuttosto concerne specificatamente questa autonomia “differenziata”, in particolare per come viene proposta negli atti posti in essere nel recente passato e per come viene preannunciata dall’attuale maggioranza. La ragione di fondo del nostro “allarme”, il pericolo maggiore che avvertiamo, è proprio quello che in tal modo ci allontaneremmo dal modello di autonomia disegnato in Costituzione. Altro che attuazione.
In proposito è opportuno precisare che il modello di autonomia definito dalla nostra Costituzione è rinvenibile, più che nel Titolo V, nei primi articoli del testo costituzionale. Com’è noto, infatti, sin dall’Assemblea costituente la discussione sul tipo di regionalismo non fu univoca e forse neppure del tutto lineare (non avendo tempo per esaminare la discussione che allora si sviluppò, rinvio ai chiari studi di Umberto Allegretti e Antonio D’Atena). L’intervento sul Titolo V del 2001 ha confuso ulteriormente il quadro (e ci è voluto l’incisivo intervento “creativo” e “sistematico” della Consulta per dare un volto al regionalismo del nuovo millennio). Ciononostante, il “modello” costituzionale del regionalismo italiano è stato ben definito principalmente negli articoli dedicati a configurare i principi fondamentali della Repubblica. Non v’è dubbio, infatti, che nell’articolo 5, e nei precedenti articoli 2 e 3, è delineato un regionalismo chiaramente e fortemente “solidale”. Basta leggere gli articoli richiamati. L’autonomia deve essere riconosciuta e anzi promossa al fine di assicurare l’unità e indivisibilità della Repubblica. Così anche i diritti inviolabili devono essere garantiti sempre, su tutto il territorio nazionale e – come da sempre ci ricorda la Consulta – per tutti, compresi gli stranieri, imponendo doveri inderogabili di solidarietà all’intera Repubblica; non possono riguardare, invece, solo le diverse comunità locali o regionali. Per non dire del principio d’eguaglianza formale, ma ancor più sostanziale, che impone di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo della persona umana, certamente anche quelli di ordine territoriale. Questi sono i parametri costituzionali di riferimento.
Se si leggono in questa prospettiva le proposte dell’attuale maggioranza (ma in realtà anche quelle dei governi precedenti) si evidenzia senza ombra di dubbio la distanza tra la solidarietà che sorregge il concetto di autonomia individuato in Costituzione e le logiche competitive e di natura brutalmente appropriativa che si sta cercando ora di imporre nei rapporti tra le Regioni e lo Stato centrale. Gianfranco Viesti ha scritto che si sta preparando una vera e propria “secessione” dei ricchi, ma se anche si volesse essere più cauti, non si potrebbe comunque negare che sia l’appropriazione sfrenata ed egoistica dei poteri e di tutte le competenze possibili ciò che lega e spiega la richiesta delle Regioni. La riprova è la pre-intesa Veneta raggiunta con Gentiloni nel 2018 e relativa a tutte le 23 materie indicate nel 3° comma del art. 116, nessuna esclusa. Una scelta che prescinde dalle reali specifiche esigenze di differenziazione del territorio veneto, ed è sorretta, invece, da una volontà da parte della Regione di impossessarsi di quanto più potere, funzioni e gestione di interessi sia possibile, senza tenere in nessun conto le necessità delle altre parti del territorio nazionale e dei diritti delle persone altrove residenti. Un modello, dunque, che sconta una diseguaglianza nei territori, ciascuno dei quali è artefice del proprio destino e dell’efficienza dei servizi forniti per garantire i diritti fondamentali esclusivamente agli abitanti di quel territorio (non solo in materia di sanità, scuola, lavoro, ma in relazione a tutti i diritti coinvolti in qualche modo nei trasferimenti richiesti). Persino con una torsione che porterebbe a discriminare tra le persone nell’ambito dello stesso territorio, come dimostrano le proposte – per fortuna sino ad ora fermate dalla Consulta – di riservare ai soli residenti pluriennali l’accesso ai servizi pubblici locali, con palese violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
D’altronde che si voglia superare definitivamente il modello regionale, fissato sin dal 1948 e poi rivisto nel 2001, appare evidente: si rifletta solo sul fatto che nel caso della devoluzione di tutte le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117, l’effetto sarebbe quello di svuotare per intero la legislazione “concorrente” tra lo Stato e le Regioni “differenziate”. Si affermerebbe dunque un modello di regionalismo “separatista”, con competenze divise tra quelle assegnate in via esclusiva allo Stato centrale e quelle devolute in via altrettanto esclusiva alle Regioni. Un modello che non ha eguali altrove. Persino l’ordinamento federale tedesco – com’è ben noto – si regge sulla concorrenza nella legislazione tra Länder e Federazione. Una modalità di co-gestione delle competenze relative a diritti fondamentali essenziali per conservare l’unità ed indivisibilità dello Stato. Solo in Italia abbiamo avuto – già in passato – alcuni tentativi di superamento di questo tipo di legislazione. Il primo, infatti, che ritenne si potesse fare a meno della “concorrenza” fu Matteo Renzi con la sua imprudente proposta di riforma della Costituzione. È interessante notare che in quel caso la rottura della logica del sistema costituzionale avveniva con l’opposta intenzione di ricentralizzare gran parte delle competenze delle Regioni riconducendole allo Stato, mentre ora si propone di devolverle ai territori. Muta il segno della riforma, non cambia il risultato: l’abbandono del modello solidale di regionalismo italiano.
2.
In questa situazione quale può essere la nostra proposta? Come si può rispondere al tentativo in atto di abbandonare il modello costituzionale di regionalismo? Semplicemente richiamando l’esigenza di tornare ai principi definiti negli articoli 5, 2 e 3 della Costituzione. Mi limiterò qui a fare alcuni esempi che mi sembrano significativi e che coinvolgono le questioni più dibattute, per cercare di dimostrare come siano altre le priorità che dovrebbero essere proposte da chi volesse cambiare per rendere effettivo il regionalismo solidale in Italia.
Il primo riguarda la discussione – oggi così accesa – relativa ai livelli essenziali delle prestazioni (i famosi Lep). Dovremmo ricordare in proposito che prima ancora di attuare l’art. 117, 2° comma, lettera m, è necessario rispettare l’art. 2 della nostra Costituzione, il quale non si accontenta di assicurare (solo) i livelli essenziali dei diritti civili e sociali, ma pretende di garantire i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale su tutto il territorio nazionale. In questa prospettiva, seppure non si possa giungere a sostenere l’incostituzionalità dei Lep per violazione di principi supremi, si deve però aver chiaro che questi rappresentano solo l’asticella minima, mentre un revisionismo coraggioso e conforme al modello costituzionale dovrebbe parametrarsi sull’art. 2 Costituzione prima ancora che sull’art. 117. Perché nessuno dice che accontentarsi della tutela minima non è espressione di un coraggioso revisionismo in linea con i tempi? Basterebbe, in fondo, rilevare che quanto più si accentuano le differenze territoriali tanto più appare insufficiente limitarsi a salvaguardare i Lep, dovendo invece proporsi di colmare le diseguaglianze nell’effettività delle prestazioni fornite in materia di diritti civili e sociali.
La non conformità delle attuali proposte si evidenzia anche con riferimento all’interpretazione distorta che viene data dell’art. 117, 2° comma, lett. m (dunque in relazione a quella tutela che abbiamo definita “essenziale”, ovvero minima). Infatti, la procedura per l’attuazione dei Lep così come prevista nella legge di bilancio, ma ripresa sostanzialmente anche nel disegno di legge promosso dal ministro Calderoli, si preoccupa principalmente di stabilire tempi certi per giungere alla “determinazione” dei Lep, ma dimentica che la nostra Costituzione finalizza – direi ovviamente – tale opera di definizione alla loro necessaria ed effettiva “garanzia” («determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»). Di questo secondo, decisivo, profilo non sembra si abbia consapevolezza. Ci si limita, infatti, solo a prevedere una procedura che possa costringere entro brevissimo tempo – a una cabina di regia e ad una commissione di tecnici – a giungere a una semplice individuazione (“determinazione”) delle prestazioni, senza invece preoccuparsi di come poi effettivamente assicurare (“garantire”) le prestazioni così individuate. Dov’è che emerge l’ipocrisia di una simile prospettiva e si rivela la falsa coscienza dei proponenti? Esse risiedono nella volontà espressa di non operare variazioni di bilancio, limitandosi a prevedere che con DPCM si determinano i costi e fabbisogni standard, senza oneri finanziari aggiuntivi e, comunque, in coerenza con gli attuali equilibri di bilancio. È evidente invece che se si volessero effettivamente garantire tali livelli su tutto il territorio nazionale, sarebbe necessario non solo aumentare le entrate da riservare ai diritti civili e sociali ritenuti “essenziali”, ma anche definire una redistribuzione delle risorse a favore dei territori svantaggiati, dove sarà più complesso rispettare gli standard delle prestazioni essenziali una volta individuati.
E qui tocchiamo un aspetto decisivo che dovrebbe rappresentare il nostro punto di forza e l’argomento polemico di maggior pregio. Se si vuole realmente dare attuazione ai principi della nostra Costituzione ci si dovrebbe convincere che prima di poter realizzare una qualche possibile ulteriore devoluzione di materie alle Regioni (anche ai sensi dell’art. 116, 3° comma), vi è una priorità logica e di fatto che bisognerebbe rispettare. Occorre, anzitutto, operare una redistribuzione delle risorse tra i territori, privilegiando quelli meno in grado di produrre reddito. È scritta nell’art. 119 la necessità di istituire un fondo perequativo senza vincoli di destinazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante (3° comma), ma è poi un’ulteriore prescrizione costituzionale (5° comma del medesimo art. 119) che impone di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. Risorse aggiuntive sono imposte per superare le diseguaglianze territoriali, altro che limitarsi a rimodulare la spesa storica o definire i fabbisogni standard. Senza prima effettuare un riequilibrio a favore delle regioni svantaggiate, non si può pensare a devolvere materie, competenze e poteri relativi alle regioni che godono già di un maggior favore economico e sociale. Bisogna pensare a una devoluzione al contrario, una redistribuzione delle risorse in grado di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza delle persone nei territori svantaggiati. Una redistribuzione solidale che non può accontentarsi di qualche “mancia” o fondo perequativo residuo, ma che sia invece in grado di riequilibrare strutturalmente il divario territoriale. Una volta conseguito l’obiettivo di porre tutte le Regioni su un piano di eguaglianza sociale ed economica, a quel punto non credo ci sarebbe nessuno che obietterebbe a una successiva diversa distribuzione anche delle materie di competenza regionale, che si renderebbe necessaria non foss’altro per attuare un altro articolo della nostra Costituzione, il 118, il quale indica i principi che devono essere seguiti per meglio amministrare i servizi pubblici e le prestazioni sociali nei diversi territori della Repubblica: una devoluzione di funzioni amministrative sorrette dai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà.
È questa, in sintesi, un’interpretazione progressista della sistematica costituzionale e una lettura coordinata degli articoli 2; 3; 5; 116, 3° comma; 119, 3° e 5° comma; 118, 1° comma. Una lettura agli antipodi di quella corrente. Qualcuno potrebbe obiettare che si tratta di una prospettiva distante dalla realtà. Lontana dagli equilibri culturali, oltre che politici, dominanti. Tutti ormai protesi a realizzare un regionalismo di tipo competitivo. In fondo, sono state le maggioranze di centro-sinistra gli apripista: dal Titolo V e l’inserimento in Costituzione dell’autonomia differenziata (promosso nel 2001 dal Governo D’Alema), alle prime pre-intese sottoscritte dal Governo Gentiloni nel 2018. Qualcuno – con malizia, ma non dicendo il falso – potrebbe rilevare che la situazione nella quale ci troviamo in fondo è parte della “nostra” storia, più che un frutto dalla maggioranza politica dei nuovi governanti di destra. Una considerazione che dovrebbe certamente farci riflettere criticamente sul passato e sugli errori compiuti, ma che dovrebbe anche richiamare alla responsabilità e alla necessità di un cambiamento radicale. Ricercando ora – prima che sia troppo tardi – una rottura di continuità. Non possiamo continuare a giocare di rimessa, non possiamo limitarci contrapporre solo il più netto rifiuto al regionalismo differenziato che ci viene proposto. È giunto il tempo per provare a indicare un’altra rotta per giungere a un diverso regionalismo, quel regionalismo solidale cui la nostra Costituzione aspira e che non è mai stato realizzato in Italia. Se non lo rivendichiamo ora, rischiamo di non poterlo più neppure immaginare in futuro.
L’articolo è tratto, in virtù di un accordo di collaborazione dal sito del CRS (Centro per la Riforma dello Stato)