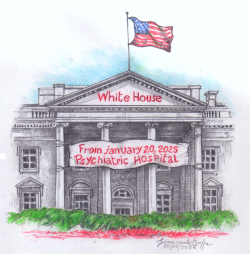Lo sapevate che il Nobel per l’economia non è… un vero premio Nobel? Io no. L’ho scoperto leggendo Dominio, un libro, davvero interessante, di Marco d’Eramo [1], che racconta come è perché questo premio abbia avuto origine. In realtà, basterebbe dare un’occhiata su Wikipedia alla voce Premio Nobel per l’economia per essere informati del fatto che Alfred Nobel (1833-1896), che si era arricchito con le sue scoperte, tra cui la dinamite, destinò nel testamento la maggior parte del suo patrimonio all’istituzione di un premio per personalità che si fossero distinte nei seguenti campi: fisica, chimica, medicina, letteratura, pace. Tra i premi, assegnati per la prima volta nel 1901, non ce ne era affatto uno per l’economia, perché Nobel dichiarava di non avere alcuna formazione in quella disciplina e di odiarla dal profondo del cuore.
In effetti, quello che comunemente chiamiamo Premio Nobel per l’economia, è ufficialmente denominato Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel: è stato istituito nel 1968 dalla Banca centrale svedese, in occasione dei 300 anni dalla sua fondazione, e assegnato per la prima volta nel 1969. E allora, chiederà il lettore, se questi fatti sono noti, cos’è che fa scoprire il libro di d’Eramo? Fa scoprire la rilevanza di questi fatti, per lo più taciuti o sottovalutati e, inserendoli nel contesto, mostra l’impatto che essi hanno avuto sull’economia mondiale.
Un premio che sostiene un’ideologia
Nel linguaggio corrente, infatti, si continua a parlare del Nobel per l’economia, e chi lo riceve ottiene un prestigio a livello mondiale. Ma non è un caso che, il più delle volte, il premio venga assegnato a economisti conservatori: nel 1974 a Friedrich August von Hayek, nel 1976 a Milton Friedman, seguace di von Hayek, e da allora, ricorda d’Eramo, i premi «si riversarono a cascata sui Chicago Boys», cioè economisti formatisi all’Università di Chicago, in cui avevano insegnato sia Hayek che Friedman.
L’assegnazione del Nobel per l’economia, dunque, sembra avere uno scopo ben preciso: sostenere un’ideologia conservatrice, accrescendo il prestigio dei suoi esponenti, per far prevalere il pensiero liberista – che esalta il libero mercato e chiede la riduzione dell’intervento dello Stato in economia – su quello di John Maynard Keynes, sino ad allora predominante, che sosteneva la necessità dell’intervento statale nell’economia, anche aumentando la spesa pubblica per favorire l’occupazione.
L’istituzione di tale premio, dunque, non è che uno dei fattori che ha contribuito al successo di quella vera e propria rivoluzione che è avvenuta nel campo dell’economia nell’ultimo cinquantennio, una rivoluzione che ha provocato la sconfitta della sinistra, tanto che essa – nota d’Eramo – «è giunta perfino a vergognarsi della propria ideologia». Oggi, in effetti, espressioni come ‘padronato’, ‘sfruttamento dei lavoratori’, ‘lotta di classe’, sono del tutto assenti nel linguaggio quotidiano, come se fosse inaccettabile una visione della società basata su quelle idee.
Tutto ciò, argomenta d’Eramo, non è avvenuto per caso, ma perché la destra ha combattuto nell’ultimo cinquantennio una vera e propria guerra ideologica, consapevole che la battaglia decisiva si gioca sul piano culturale: come diceva William Simon, ministro del Tesoro con Richard Nixon (1969-1974) e poi con Gerald Ford (1974-1977), «le idee sono armi, le sole armi con cui altre idee possono essere combattute». Peccato che la sinistra se ne sia dimenticata!
Numerosi miliardari statunitensi, invece, hanno compreso l’importanza di questa battaglia e hanno fondato, con la donazione esentasse di enormi somme di denaro, vari think tanks, gruppi di intellettuali capaci di elaborare, ad alto livello, una visione conservatrice dell’economia, visione che doveva poi essere tradotta in un linguaggio accessibile alle masse, e quindi essere diffusa attraverso i mezzi di formazione dell’opinione pubblica: scuola, televisione, social network.
Due caratteristiche accomunano questi pensatoi: anzitutto mettere in guardia i cittadini americani dall’incombente pericolo comunista – pericolo sempre attuale, tanto che il 4 luglio 2020, per esempio, in sintonia con una di queste prestigiose Fondazioni, Donald Trump affermava in un suo comizio che «il Paese è sotto assedio da parte del fascismo di estrema sinistra» [2]– e poi offrire collaboratori ai presidenti per attuare politiche conservatrici: un centinaio di loro, per esempio, divennero pubblici funzionari nel corso dei due mandati dell’amministrazione Reagan.
Proprio con la presidenza di Ronald Reagan (1981-1989) e con Margaret Thatcher, primo ministro in Gran Bretagna (1979-1990) – per entrambi Milton Friedman era il principale punto di riferimento – «l’incontrastato consolidamento e l’universale diffusione del neo-liberismo» sono ormai un fatto compiuto. La destra ha stravinto la sua battaglia, usando appunto l’arma delle idee; sbaragliata la sinistra, che abbandonava il campo rinunciando alle proprie posizioni, reaganismo e thatcherismo trionfavano al punto che un noto storico inglese, Perry Anderson, si stupiva per un successo pochi anni prima difficilmente prevedibile: «Se gli anni 1989-91 avevano visto la distruzione del comunismo sovietico, non era immediatamente ovvio che un capitalismo di libero mercato senza freni avrebbe dilagato a est e a ovest». Oggi, in effetti, pare scontato che non ci siano alternative al capitalismo, tanto che, ricorda ancora d’Eramo, anche Barack Obama (2009-2017) considerava Reagan un grande statista e un “punto di riferimento” fondamentale per la sua epoca.
Cambiamento nella concezione della società, dell’individuo e del lavoro
In effetti, è cambiato il modo di concepire la società: anzi, nella prospettiva conservatrice la società non esiste, non ci sono comunità unite dagli stessi interessi e da rapporti di solidarietà. Come ha detto Margaret Thatcher in una famosa intervista del 1987, «non esiste una cosa come la società». Non ci sono classi sociali, non ci sono datori di lavoro e lavoratori: si è imposta una visione individualistica, in cui appunto l’individuo è il soggetto che deve affermarsi con le proprie capacità, in un clima di competizione con altri individui.
In questa prospettiva, è cambiata anche la concezione dell’essere umano. Se ci chiediamo ‘che cos’è un uomo’, come possiamo definirne il carattere essenziale, la risposta è questa: è un individuo “proprietario di se stesso”. Il linguaggio dell’economia ha sostituito quelli, considerati ormai superati, della filosofia e della religione. Ed è cambiata anche la concezione del lavoro: non ha più senso parlarne come di un diritto e di un dovere, cioè come di un’attività essenziale per realizzarsi e per contribuire al benessere della comunità. Ciascuno va sostanzialmente considerato come un imprenditore di se stesso, pronto a mettere in vendita sul mercato il proprio capitale: il capitale umano, cioè le proprie doti fisiche o intellettuali – la bellezza del proprio giovane corpo, la propria forza muscolare o le proprie competenze in campo artistico o informatico… – per ottenere per se stesso ricchezza, potere e successo.
Persino il migrante, che attraversa il Mediterraneo su un barcone, sta affrontando dei rischi per ottenere un certo benessere. Fatica, umiliazione, sofferenza sono costi accettati in vista di un obiettivo: sono “un investimento”. «Il migrante – osserva D’Eramo – è un imprenditore di sé che affronta spese per ottenere un miglioramento». E, se affoga nel Mediterraneo, ciò prova che ha fatto, come può capitare, un cattivo investimento.
È evidente che, in questa prospettiva, scompare la distinzione tra capitalista e operaio: siamo tutti capitalisti, «dal lavapiatti immigrato all’oligarca russo». E perciò non ha più senso parlare di sfruttamento, sciopero, lotta di classe: questa «non c’è più, semplicemente perché non ci sono due classi diverse, ci sono solo capitalisti». Il tuo successo dipende solo da te: se fallisci, è solo perché non hai saputo investire adeguatamente il tuo capitale umano!
Tutte le attività, tutte le iniziative, tutti gli interessi – siano essi culturali, spirituali, o affettivi – vanno considerati come mezzi per raggiungere obiettivi che appagano i nostri desideri: il calcolo economico – cioè il rapporto investimento-soddisfazione di un bisogno – è l’unico criterio ragionevole «per studiare, comprendere, narrare e giudicare tutte le sfere dell’agire umano». E, in una prospettiva individualistica, nessuno può aspettarsi un sostegno dallo Stato: se questo intervenisse con spese eccessive per aiutare i cittadini-imprenditori meno capaci, rischierebbe di mettere a repentaglio l’intera economia.
Un’ulteriore conseguenza di questa logica è che il cameriere o il manovale non sono più dipendenti di un datore di lavoro ma sono professionisti che offrono un servizio, come un avvocato o un notaio. Ma all’avvocato e al notaio si paga la parcella, non si pagano certo le ferie o la pensione. E allora perché al cameriere e al manovale si devono pagare «assistenza sanitaria, contributi pensionistici, ferie e congedi di malattia o parentali»?
D’Eramo cita, in proposito, Wendy Brown, docente di scienze politiche all’Università di Berkeley, che nel 2015 osservava che, se «ogni cosa è capitale», scompare il lavoro come diritto-dovere, come scompare «pure la sua forma collettiva, la classe», e di conseguenza vien meno «la ragione di esistere dei sindacati». Ecco perché oggi si rimettono in discussione «secoli di leggi sul lavoro» e tutele faticosamente conquistate «nel mondo euro-atlantico!».
Cambiamento nella concezione dello Stato
Appare, infatti, assolutamente comprensibile, in questa logica, la crescente insofferenza per i “dipendenti fissi a tempo indeterminato”: professori e burocrati, per esempio, non sono che capitalisti che «beneficiano di ‘indebiti’ sussidi pubblici». Non sorprende, perciò, che si tenda a privilegiare il privato rispetto al pubblico, e a eliminare il posto fisso dei dipendenti statali. Anche in Italia si registrano segnali del genere: si vorrebbero trasformare le scuole in strutture private, che i genitori possono scegliere in base alle proprie idee, e in competizione tra loro per attrarre studenti, oggi considerati clienti; le sedi del Servizio sanitario nazionale, poi, non si chiamano più Usl (Unità sanitarie locali), ma Asl (Aziende sanitarie locali), con l’obiettivo di farle competere sul mercato.
Ma come raggiungere l’obiettivo di ridurre gli ingiustificati benefici di cui godono intere categorie di cittadini? In una parola: come smantellare il welfare state, cioè il sistema per cui lo Stato si assume il compito di occuparsi del benessere dei cittadini garantendo assistenza sanitaria, istruzione, previdenza sociale? Semplice: presentando le tasse come un furto operato dallo Stato e non come la riscossione delle risorse necessarie per fornire servizi essenziali! Da qui, l’idea di una ‘tassa piatta’, in contrasto col principio della progressività delle imposte, il rifiuto di ogni proposta di patrimoniale sui redditi più alti, e la benevola tolleranza per i grandi evasori. Scontato il risultato, consapevolmente perseguito, di una simile politica fiscale: un aumento delle diseguaglianze, con i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri [3].
Ed è facile convincere l’opinione pubblica che un ceto di governanti corrotti si preoccuperà più di arricchirsi che di gestire efficacemente il denaro pubblico. I soldi versati allo Stato vengono “spesi male, sperperati”, mentre sono sicuramente più efficienti le istituzioni private. È questa la visione elaborata da prestigiose università, sintetizzata nello slogan di Reagan «lo Stato non è la soluzione, è il problema», e diffusa da «migliaia di trasmissioni tv, programmi radio, articoli, tutti abbondantemente foraggiati dalle fondazioni conservatrici».
Forse non è affatto vero che il privato funzioni meglio del pubblico: il sistema sanitario privato statunitense, per esempio, «costa il doppio pro capite dei sistemi sanitari pubblici europei, producendo una più breve speranza di vita e un peggiore stato di salute medi»” dei cittadini. Ma quello dell’efficienza del mercato è ormai un mito, accettato pure dai Paesi dell’Unione Europea, e che resiste anche di fronte alle più evidenti smentite fattuali.
Oltre alla concezione della società, dell’uomo e del lavoro, è dunque cambiata anche la concezione dello Stato, il cui scopo non è più quello di operare per il bene comune. Lo scopo dello Stato è diventato quello di «facilitare l’economia, e la sua legittimità è legata alla crescita economica». È questa la nuova realtà, a cui siamo ormai abituati: «uno Stato sotto sorveglianza del mercato, piuttosto che un mercato sorvegliato dallo Stato». Il mercato è di fatto diventato la vera autorità, a cui i governi devono rispondere: un tribunale che giudica, promuovendo o punendo gli Stati, in base alla crescita o meno del PIL [4]. Forse ha proprio ragione Wendy Brown quando sostiene che il neoliberismo non ha privatizzato solo scuola, sanità, trasporti, ma ha privatizzato anche il “nostro cervello”: il nostro modo di pensare è quello dell’ideologia dominante!
Inevitabile, a questo punto, chiedersi: è possibile una controrivoluzione? Nelle attuali condizioni, è evidente, non è facile essere ottimisti. In ogni caso, credo che sia utile riflettere e confrontarsi sull’analisi della contrapposizione tra dominanti e dominati proposta da Marco d’Eramo. Perché è una realtà la lotta di classe, come riconosceva il miliardario americano Warren Buffett, che nel 2011 aggiungeva: e quella lotta l’abbiamo vinta noi. Gli uomini e le donne che si riconoscono nelle posizioni di quella che un tempo era la sinistra, potrebbero trovare nel libro di d’Eramo un invito, ben argomentato e convincente, per tornare a lottare per le idee, perché queste, come hanno dimostrato le forze di destra, sono le vere armi che permettono di vincere l’inevitabile lotta di classe. Non è un’impresa facile, ma credo che non ci siano altre soluzioni.
Note
[1] M. d’Eramo, Dominio. La guerra invisibile dei potenti contro i sudditi, Feltrinelli 2020. Le citazioni, anche di altri studiosi, in assenza di espliciti riferimenti in nota, rimandano a quest’opera.
[2] E recentemente, in un comizio in Iowa, per rassicurare cittadini allarmati da certe candidature, Trump ha ribadito: «Come Presidente degli Stati Uniti, proclamo qui e ora che l’America non diventerà mai comunista in nessun modo, forma o aspetto», Agenzia Vista, 4/7/2025.
[3] Questo per esempio, sostiene Alessio Marchionna, sarà l’effetto della ‘Grande e bellissima legge’, voluta da Trump e approvata il 3/7/2025 dal Congresso degli Stati Uniti: il reddito del 20 per cento più povero degli americani si ridurrà “del 2,3 per cento”, mentre quello dell’1 per cento più ricco aumenterà “del 2,1 per cento” (Tre conseguenze del taglio alle tasse voluto da Trump, in Internazionale, 8/7/2025).
[4] E quando il mercato entra in crisi, la guerra, come scrive l’economista Domenico Moro, è la soluzione per riavviare l’accumulazione dei profitti: «La guerra è soprattutto un elemento propulsivo dell’economia capitalistica nei suoi momenti di crisi strutturale»; in quei momenti, «la spesa militare e le immani distruzioni dovute all’uso delle armi moderne arrivano puntuali in soccorso dei profitti» (D. Moro, Il legame inscindibile del capitalismo con la guerra, 21/5/2025).