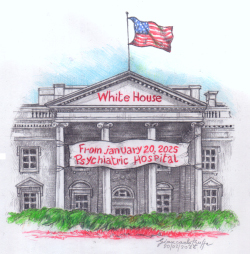L’autonomia differenziata è affidata dalla riforma del titolo V ad intese tra governo e regioni, che emarginano il Parlamento. Ma, di più, l’attuazione che se ne sta dando con il disegno di legge ora all’esame della Camera non si pre-occupa della perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante e rischia così di acuire il divario tra regioni quanto all’effettività delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali. La frammentazione esporrebbe la legge e le intese al rischio di incostituzionalità per contrasto con il principio supremo di unità e indivisibilità della Repubblica.
1. Un inquadramento
Il disegno di legge Calderoli (in seguito: ddl) approvato dal Senato è passato alla Camera (AC 1665). E, per effetto dell’ormai vigente monocameralismo di fatto, si prevede che sarà approvato così com’è. Il quadro legislativo si è, quindi, praticamente completato e permette di svolgere congrue considerazioni a ragion veduta. Tanto più perché si vanno moltiplicando gli inviti a valutare il disegno di legge, diciamo così, laicamente: è l’attuazione – si dice - di un dettato costituzionale, introdotto peraltro proprio dal centro-sinistra, che ora però si oppone, e anzi migliorato dalla destra, già con il comma 791 dell’art. 1 della legge di bilancio 29.12.2022, n. 197, con la conditio sine qua non della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (lep) in ben 15 delle 23 materie attribuibili alle Regioni. Nessuna frammentazione dell’unità della Repubblica, che già tollera senza problemi l’esistenza di cinque regioni addirittura a statuto speciale.
In effetti, queste regioni insieme a quelle ordinarie sono parte di una generale istanza autonomistica, generata dai movimenti federalisti risorgimentali e condivisa all’Assemblea costituente dalle stesse formazioni di centro e di sinistra sia per reazione al centralismo autoritario del regime fascista sia per il timore che, sia pure a seguito di elezioni democratiche, un tale esito potesse riproporsi negli anni a venire. La riforma del titolo V della Costituzione del 2001 – senza rivisitare la condizione delle regioni a statuto speciale, come pure sarebbe stato auspicabile ed era stato da alcuni proposto - ha proseguito questo percorso prevedendo la possibilità di attribuire ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario. Di per sé, quindi, l’autonomia differenziata non è uno sbrego costituzionale, una infedeltà allo spirito della Costituzione. Può diventarlo però – ed è questo il rischio che si paventa – se non attuata compatibilmente con gli altri princìpi costituzionali, tra cui spicca quello supremo, perché non modificabile neppure con procedimento di revisione costituzionale, dell’unità e indivisibilità della Repubblica, posto dall’art. 5 e specificato anche in norme dello stesso titolo V: “unità giuridica” e “unità economica (art. 120); “coesione e solidarietà sociale (art. 119); “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali (art. 117, 120).
A fronte della piega tendenzialmente secessionistica della sua attuazione, perciò, hanno preso corpo movimenti “contro ogni autonomia differenziata”: un’istanza che si presta all’accusa di voler impedire l’attuazione di una parte della Costituzione da parte di movimenti che ordinariamente nella pratica politica e sociale alla Costituzione si rifanno, quasi custodi e paladini. Indubbiamente, però, la riforma del 2001, approvata come si ricorderà a maggioranza risicatissima in scadenza di legislatura, anche se poi confermata da un referendum, fu fatta a maglie così larghe da mettere a repentaglio il principio sancito dall’art. 5 Cost.
Sotto il governo Renzi fu approvata una riforma che restringeva di molto le materie devolvibili alle Regioni (escludendo, in particolare, quelle ora più contestate: salute, istruzione, lavoro, ambiente, grandi reti di trasporto), ne subordinava l’attribuzione alla condizione di equilibrio tra entrate ed uscite del bilancio regionale e introduceva la clausola di supremazia dello Stato per tutelare l’unità giuridica ed economica della Repubblica e, comunque, l’interesse nazionale. Si riconobbe già allora, anche da parte degli oppositori, che si trattava della bona pars di quella riforma, che per ragioni relative alle altre parti, giustamente ritenute prevalenti nella valutazione complessiva, fu poi bocciata con il referendum del 2016.
Nella stessa direzione, limitativa delle materie attribuibili, s’è mosso di recente un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare, sottoscritto da oltre centomila elettori, ma affossato dal Senato senza specifica discussione dopo essere stato calendarizzato, con patente forzatura regolamentare e logica, il giorno successivo all’approvazione del ddl Calderoli.
2. Le intese
L’autonomia differenziata, quindi, si farà, se si farà, senza aver raddrizzato le più forti criticità della disciplina del titolo V. Dato l’oscuramento di questo peccato originale, provocato dalla priorità del dibattito sul ddl, appare opportuno ricordarle, cominciando da quella più incidente nel tessuto costituzionale: la bilateralità, invece della unilateralità, della legislazione attributiva di nuove competenze alle regioni. L’autonomia differenziata fu attribuita alle regioni a statuto speciale con legge unilaterale, la Costituzione stessa. Rientra, invero, nella funzione legislativa assegnata esclusivamente al Parlamento (art. 70 Cost.) l’autolimitazione della stessa mediante attribuzione in alcune materie e funzioni alle regioni. Invece, l’art. 116 novellato l’attribuisce in attuazione di intesa tra Governo e regione interessata, che il Parlamento dovrà bensì approvare con apposita legge ma senza poterla emendare: potrà solo respingere l’intesa in blocco, che è evenienza praticamente inverosimile specie se il governo dovesse porre la questione di fiducia.
Il difetto principale sta, quindi, nell’aver adottato nel 2001 il procedimento delle intese previsto dall’art. 8, co. 3, Cost. per regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Ma l’assimilazione è del tutto impropria. Quelle intese non privano né menomano poteri dello Stato, come invece quelle con le regioni, ma sono finalizzate a rendere effettiva la libertà di religione e di culto dei cittadini aventi parte nelle confessioni stipulanti e ad estendere loro, in aderenza al principio dell’uguale libertà di tutte le confessioni religiose ex art. 8, co. 1, norme favoritive (efficacia civile del matrimonio religioso, otto per mille ecc.) riconosciute alle altre confessioni e, in particolare, alla chiesa cattolica. Fu questa sostanzialmente la ragione per cui si ritenne di assimilare la legge di approvazione delle intese a quella di approvazione degli statuti regionali prevista dall’art. 123 vecchia formulazione, che esprimeva allora – motivò il sottosegretario alla presidenza del consiglio Amato – “il massimo di autonomia riconosciuta all’interno dell’ordinamento dello Stato”. Tale legge è pacificamente inemendabile (cfr. l’intervento della presidente Iotti alla seduta 9 luglio 1984 della Camera), a meno che non si tratti di punti in cui la legge non è fedele all’intesa (così precisò il relatore Galloni). Non sono ammessi, invece, emendamenti di sostanza perché essi inciderebbero, diminuendola o azzerandola, sull’effettività dei diritti di libertà individuali e confessionali.
Senonché le intese governo-Regioni, invece, sono volte a trasferire competenze legislative costituzionalmente assegnate allo Stato e, quindi, a spogliarne il Parlamento, per cui è irragionevole che il disegno di legge di approvazione non possa essere emendato al fine di trattenere la funzione legislativa in alcune materie in capo al Parlamento. Questo, infatti, secondo il ddl (art. 2, co. 4-5), può esprimersi sulle intese preliminari solo con atti di indirizzo, obbligatori ma non vincolanti perché il Presidente del Consiglio può non conformarvisi in tutto o in parte, limitandosi a fornire adeguata motivazione. Al Parlamento non rimane che prendere o lasciare. Per i detti motivi di tenuta politica della maggioranza prenderà: sia pure con qualche rimostranza, forse, dei parlamentari appartenenti alle Regioni, incise dalle esternalità negative del rafforzamento di quell’autonomia e del livello dei servizi offerti alle proprie popolazioni. Basterà una “deliberazione”, recita l’art. 2 con lessico amministrativo, stridente con la funzione legislativa ma in fondo corrispondente alla realtà.
3. (segue:) Limiti e controlimiti
La scelta del procedimento aggravato intesa/legge produce effetti limitativi anche sui rimedi legislativi e giurisdizionali. Le (leggi di approvazione delle) intese Stato-regioni godono, infatti, di una particolare forza, in pratica assimilabile a quella delle fonti costituzionali, di resistenza passiva alle modificazioni o abrogazioni che si vogliano introdurre con legge non preceduta a sua volta da intesa. Questa garanzia costituzionale di norme interne legislative, non ulteriormente modificabili con legge priva del previo accordo, è conseguenza del principio di competenza delle fonti. La legge di approvazione di un’intesa, pur essendo ordinaria, è una “legge rinforzata” dall’aggravamento procedurale e, quindi, resiste, con una forza uguale a quella delle leggi costituzionali, alla modificazione o all’abrogazione mediante leggi non costituzionali né di approvazione esse pure di intesa (così, in riferimento al prototipo dell’art. 8, Colaianni). Per almeno dieci anni (durata ordinaria dell’intesa), quindi, il Parlamento potrà legiferare nelle materie attribuite alle regioni con intesa solo con riferimento alle regioni senza intesa (art. 6).
Ci sono dei controlimiti. È principalmente da ritenere la legittimità di una legge unilaterale che sia espressiva non di un illegittimo esercizio della sovranità dello stato in materia bilateralmente regionalizzata ma dell’adattamento della sovranità ad una superiore istanza: in attuazione, in particolare, di direttive unionali - per effetto dell’art. 117, che pone il vincolo dell’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali – ma anche in osservanza dei diritti fondamentali della persona.
Inoltre, per quanto rafforzata, la legge di approvazione dell’intesa ha natura, come detto, di legge ordinaria ed è perciò suscettibile di essere sottoposta per l’intero – non, in analogia ai ricordati poteri del Parlamento, in parte – a referendum, salvo che venga collegata alla legge di bilancio. Non si incontrano gli altri limiti previsti dall’art. 75 Cost. L’intesa, infatti, è atto di diritto interno, non assimilabile ai trattati internazionali, e non ha un carattere costituzionalmente obbligatorio o a contenuto costituzionalmente vincolato. Per quanto questa distinzione non sia perspicua nella giurisprudenza costituzionale, comunque è evidente che le intese sono meramente facoltative e non obbligatorie e il raggiunto componimento degli opposti (in teoria) interessi di Stato e regioni non è l’unico possibile: quella concordata, insomma, non è l’unica e/o necessaria disciplina per attuare il dettato costituzionale.
Bisogna dire che per lo stesso motivo neppure il ddl, se approvato, rivestirebbe quel carattere, come invece sostenuto (Ainis). Tuttavia, al contrario della legge di approvazione dell’intesa, è in effetti, esso sì, insuscettibile di referendum ma a motivo del dichiarato collegamento alla legge di bilancio. Il collegamento appare del tutto strumentale, vista la clausola di invarianza finanziaria (art. 9), ma è difficile che la Corte costituzionale entri nel merito e lo dichiari in sede di ammissibilità del referendum (De Minico). Peraltro, l’abrogazione della legge Calderoli non scalfirebbe la legge 197/2022, solo farebbe venir meno termini e fasi del procedimento di intesa, producendo una completa deregulation, come quella che portò in men che non si dica alle intese preliminari approvate dal governo Gentiloni con Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna: un ritorno indietro, quindi, evidentemente controproducente.
Un rimedio giudiziario potrebbe essere il ricorso in via principale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge da parte di una Regione che si assuma lesa nelle sue attribuzioni, senza aver potuto esprimere una effettiva opposizione. Un esempio è l’art. 2.4, che consente non alle singole regioni che si assumano danneggiate da una specifica intesa ma alla conferenza unificata stato – regioni – comuni, e quindi alla maggioranza che in quella sede verrà a formarsi in senso verosimilmente favorevole, il potere di opporsi con un semplice parere, peraltro non vincolante, allo schema di intesa preliminare.
Infine, la rilevanza costituzionale delle intese approvate con legge ex art. 116 (esattamente come quelle ex art. 8, co. 3) Cost. non attribuisce a quelle norme una specifica copertura costituzionale, per cui il sindacato di costituzionalità non è limitato ai ristretti parametri dei supremi principi costituzionali. Esso, invece, si dispiega in tutta la sua pienezza alla stregua di ogni singola norma costituzionale. Il che potrà avvenire in via incidentale o, previamente, in via principale con ricorso di regioni senza intesa, che si assumano lese nelle proprie attribuzioni dalle esternalità negative dell’intesa approvata.
4. Le materie
Le criticità dell’autonomia differenziata non toccano solo il procedimento legislativo di derivazione bilaterale ma anche la sostanza. Il campo della devoluzione è assai esteso, fino a 23 materie, e non riguarda solo le materie di legislazione concorrente (dall’istruzione all’alimentazione, dalle grandi reti di trasporto all’ordinamento sportivo, dalla salute al lavoro) – nelle quali, peraltro, allo Stato non spetta che la determinazione dei princìpi fondamentali – ma si estende alle materie di competenza esclusiva dello Stato, toccando la giustizia di pace e perfino le norme generali sull’istruzione e la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Questo irrazionale campo largo, siccome costituzionalmente definito, non può essere delimitato – come da molti, non solo dell’opposizione, auspicato – se non con procedimento di revisione costituzionale. Il ddl Calderoli ha previsto alcune limitazioni, o semplici modulazioni, come per esempio quella secondo cui (art. 4) oggetto del trasferimento non sono necessariamente le materie in tutta la loro estensione ma anche solo “ambiti di materie” e, quindi, specifiche funzioni in quegli ambiti. Ma esse rischiano di lasciare come la nebbia il tempo che trovano per ragioni di sottoposizione gerarchica non solo alla Costituzione ma anche alle future leggi di approvazione delle intese, cui, per il principio di competenza delle fonti, è riservata l’attribuzione delle materie. Governo e regioni, salvi i limiti indicati, sono gli unici organi competenti.
Altra criticità, affrontata ma non risolta (né, si ripete, risolvibile a Costituzione invariata), è quella derivante dalla mancata introduzione nel titolo V di una clausola di supremazia, che consenta allo Stato a fini, in particolare, di tutela dei lep non solo un potere sostitutivo della Regione nell’espletamento delle sue funzioni (ciò è già previsto dall’art. 120 Cost. e, come se una legge ordinaria potesse modificare o abrogare una norma costituzionale, graziosamente “fatto salvo” da ben due articoli del ddl, 3.5 e 11). Ma anche quello di sottrarre alle Regioni le funzioni alle stesse attribuite, cioè di disporre la cessazione integrale o parziale dell’intesa, quando si riscontri la mancata osservanza, direttamente imputabile alla Regione sulla base del monitoraggio previsto dal ddl, dell'obbligo di garantire i lep. Tale potere è stato incentrato nel Presidente del Consiglio dei ministri (art. 7), il Parlamento venendo chiamato solo ad approvare il provvedimento a maggioranza assoluta.
Analogo accentramento di potere si riscontra nel caso di quelle materie strutturalmente non negoziabili per intima contraddizione: le norme generali sull’istruzione o le grandi reti di trasporto e di navigazione o la distribuzione nazionale dell’energia o l’ecosistema. Il sostanziale accantonamento del Parlamento nel procedimento di approvazione dell’intesa ha condotto ad accentrare nella discrezionalità del presidente del consiglio il potere di “limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa” (art. 2.5) al fine di tutelare l'unità giuridica o economica della Repubblica.
Neppure affrontata è poi la questione della richiesta di attribuzioni senza causa da parte delle Regioni. Non sono previste, infatti, condizioni per l’accesso all’autonomia differenziata materia per materia. Esse possono chiedere (come del resto ha fatto il Veneto) la devoluzione di tutte le 23 materie senza giustificarlo con bisogni specifici del territorio, diversi da quelli generali a causa di condizioni territoriali, sociali, economiche, demografiche, nè con gli obiettivi che intendono raggiungere con il decentramento. Qui si coglie un divario profondo con le cinque regioni a statuto speciale. La loro autonomia differenziata trovava fondamento in ragioni storiche e demografiche specifiche, di modo che fu prevista dai costituenti originari per le due isole maggiori, la cui storia registrava la presenza di forti movimenti separatistici, e i territori di confine con consistenti minoranze linguistiche, quali la Valle d’Aosta, il Trentino - Alto Adige/Süd Tirol e il Friuli – Venezia Giulia (quest’ultima congelata per effetto della X disposizione transitoria della Costituzione a motivo della situazione ibrida di Trieste e formalmente costituita solo nel 1963, quasi dieci anni dopo che Trieste fu assegnata definitivamente all’Italia).
La ratio della devoluzione alle regioni ordinarie è, invece, aspecifica e dunque da ricercarsi implicitamente in una generica sussidiarietà per cui in tutte quelle materie, nessuna esclusa, si presume che l’esercizio delle relative funzioni da parte dell’ente Regione più vicino ai cittadini, e quindi più consapevole dei loro bisogni specifici, gli conferisca maggiore efficienza o efficacia. Ma se si rimane al livello della presunzione, questa dovrebbe valere per tutte le regioni indistintamente: il che dovrebbe indurre il Parlamento, previa sollecitazione delle iniziative regionali d’intesa, ad attribuire le nuove funzioni in via generale a tutte le Regioni. Al contrario, posto che la maggiore autonomia può essere attribuita regione per regione, va rilevata allora – come fatto dall'Ufficio parlamentare di Bilancio - la mancanza di indicatori verificabili di efficienza ed efficacia sulla base dei quali valutare la superiorità di una Regione rispetto allo Stato nell'esercizio di una competenza.
Come valutare allora materia per materia, o ambito di materia, i vantaggi e gli svantaggi della devoluzione a ciascuna regione istante? “Sarebbe invece consigliabile - ha inconfutabilmente osservato la Banca d’Italia nella memoria presentata al Senato il 13 giugno 2023 - prevedere un’istruttoria per ciascuna materia (ed eventualmente per specifiche funzioni all’interno della materia considerata), suffragata da un’analisi basata su metodologie condivise, trasparenti e validate dal punto di vista scientifico, per valutare i vantaggi del decentramento rispetto allo status quo – sia per la Regione interessata sia per il resto del Paese”.
In mancanza di questi criteri la causa della devoluzione sembra risiedere nella semplice domanda di maggior potere, insensibile alle conseguenze per le altre regioni.
5. La perequazione finanziaria
Pur nella lacunosità della disciplina del titolo V, comunque l’art. 116 una stella polare per l’autonomia differenziata la indica “nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 119”, necessari per la realizzazione di un regionalismo asimmetrico ma non competitivo. Cioè l’istituzione di un “fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante”, tale da impedire i rischi di ampliamento dei divari territoriali nella tutela dei diritti civili e sociali, e la destinazione di “risorse aggiuntive” per interventi speciali a favore delle regioni in ritardo per promuoverne lo sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale e di rimozione degli squilibri economici e sociali, favorendo l’effettivo esercizio dei diritti della persona. La pre-occupazione della perequazione dovrebbe orientare l’attuazione dell’autonomia differenziata. La pregiudizialità dell’art. 119 si coglie, del resto, anche sul piano logico: se le Regioni non sono allineate sul nastro di partenza, quanto a spesa pro capite e a numero di prestazioni per diritti sociali, il rafforzamento dell’autonomia di alcune di esse non farebbe che aumentare il divario esistente già con la semplice competenza regionale concorrente.
L’esempio della sanità è solo il più vistoso. Nel suo rapporto dell’ottobre 2023 la Fondazione Gimbe ha definito “frattura strutturale” quella tra Nord e Sud quanto all’adempimento dei livelli essenziali di assistenza. Nel decennio 2010-2019, tutte le regioni settentrionali (più le Marche e l’Umbria, centrali) si sono collocate nella parte alta della classifica, quelle centromeridionali nella parte bassa (tutte in piano di rientro, Calabria e Molise commissariate,). La mobilità sanitaria passiva interregionale verso il nord ha fatto registrare per 13 regioni, quasi tutte del centro-sud, un saldo negativo pari a 14 miliardi di euro e tra i primi quattro posti per saldo positivo si trovano le tre Regioni (Lombardia, Venero, Emilia-Romagna) che hanno firmato le pre-intese con lo Stato. In esse nel 2020 s’è concentrato il 94,1 per cento della mobilità attiva ammontante a 3,33 miliardi di euro, per l’83,4 per cento a spese delle regioni meridionali (più Lazio e Abruzzo). La conclusione è che “il regionalismo differenziato non potrà mai ridurre le diseguaglianze, perché renderà le Regioni del Centro-Sud – che avranno sempre meno risorse per riqualificare i loro servizi – “clienti” dei servizi prodotti dalle Regioni del Nord”.
Analoga è la disuguaglianza sul piano dei servizi sociali (assistenza a minori, disabili, anziani ecc.). Come risulta dal rapporto 2023 dell’apposito Osservatorio del CNEL il divario tra nord e sud è andato accentuandosi tra il 2015 e il 2019: la spesa media pro capite in Italia è di 124 euro ma nel nordest arriva a 177 mentre al sud scende a 58, con il punto più basso di 22 in Calabria. Quanto alle province: a Bologna risulta di 246 euro mentre a Vibo Valentia di 6 euro.
A risentire dell’attribuzione di autonomie differenziate senza previa perequazione finanziaria delle Regioni sarà, dunque, soprattutto il Mezzogiorno. Invero, lo Stato, nel disegnare un intervento pubblico nell’economia o nella società, sarà privato del potere di “avere ben presenti i divari potenziali di applicazione nei diversi territori e predisporre ex ante adeguati correttivi”. Questo auspicio fu formulato nel 2010 dall’allora direttore della Banca d’Italia, Mario Draghi, “affinché il Mezzogiorno diventi questione nazionale”. Appunto perciò, infatti, i costituenti avevano previsto che lo Stato assegnasse a singole Regioni contributi speciali “particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole”. Ma questa indicazione nominativa fu cancellata proprio dalla riforma del 2001 e sostituita con la predetta formulazione più estensiva ma generica, anche se nell’ottobre del 2022, con un’altra modifica costituzionale, le Isole sono rientrate in Costituzione con la previsione di “misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità”.
Comunque, anche quest’ultima specificità nel ddl è solo ricordata all’art. 10 tra i vari compiti di promozione dei diritti e di rimozione degli ostacoli ex art. 119, sulla cui attuazione il governo non assume alcun impegno se non quello di “informare” le Camere e la Conferenza unificata delle attività eventualmente poste in essere “nell'ambito delle risorse compatibili con i saldi di finanza pubblica”. Il limite consegue all’obbligo di non introdurre “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 9). La clausola di invarianza finanziaria finisce così per condizionare la determinazione degli stessi lep con i loro costi standard, funzionale all’attuazione dell’art. 119 sia per determinare l’entità del fondo perequativo sia per consentire alle regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite e, quindi, come ora si passa a vedere, i lep medesimi.
6. I livelli essenziali delle prestazioni (lep)
I lep sono stati dichiarati dalla Corte costituzionale, nella sentenza 220/2021, “nucleo invalicabile di garanzie minime» per rendere effettivi tali diritti (ex multis, sentenze n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020)”; “elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali (ex multis, sentenze n. 197 del 2019 e n. 117 del 2018)”. L’aspetto positivo del ddl, come già della legge di bilancio del 2022, sta nell’aver seguito finalmente la Costituzione subordinando il trasferimento delle funzioni stabilito nelle intese alla previa “determinazione dei lep e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio” (art. 4). È una svolta fondamentale, mancata nella scorsa legislatura dai tre governi alternatisi alla guida del paese, che hanno avuto come titolari del ministero per gli affari regionali una esponente leghista, uno democratico e una “terzopolista”. Del resto, allo scadere della precedente, nel 2018, incredibilmente il governo Gentiloni firmò addirittura tre pre-intese con Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna in assenza della determinazione dei Lep, pure previsti dalla legge sul cosiddetto “federalismo fiscale” (n. 42 del 2009) in relazione a quattro settori specifici: salute, istruzione, assistenza e trasporto pubblico locale. Ora l’apposita commissione, presieduta da Sabino Cassese, li ha individuati, sia pure, secondo alcuni commenti, in modo a tratti generico.
La definizione dei lep non implica che le prestazioni individuate come essenziali siano adeguatamente finanziate ed effettivamente erogate su tutto il territorio nazionale. Invero, la Costituzione adopera il termine “determinazione”, che rimanda ad una deliberazione, atto di volontà non solo di conoscenza, e implica perciò anche la garanzia di finanziamento se si vuole evitare un regionalismo asimmetrico, che colleghi i diritti civili e sociali alla residenza in violazione degli art. 117, lett. m), e 120 cpv. Cost. La convergenza verso un livello uniforme di servizi può avvenire solo attraverso una rimodulazione della spesa statale a favore delle Regioni in cui l’offerta di prestazioni è inferiore ai lep, pena la cristallizzazione degli attuali divari nell’offerta di prestazioni pubbliche sul territorio. Laddove l’effettiva erogazione dei lep nelle regioni con una spesa storica relativamente bassa richiederebbe risorse addizionali.
Qui si pone un problema giustamente segnalato da quattro componenti, poi dimissionari (Giuliano Amato, Franco Bassanini, Franco Gallo, Alessandro Pajno), della commissione Cassese. Esso deriva dal fatto che la valutazione dei fabbisogni standard di ogni ambito territoriale (in base alla popolazione, alle infrastrutture, al personale impiegato, all’efficienza dei servizi finora erogati, ecc.) non può essere fatta in assoluto ma compatibilmente ai vincoli di bilancio imposti dall’art. 81 Cost. Di conseguenza la determinazione dei lep avrebbe richiesto – hanno osservato - “una valutazione complessiva dei lep che il Paese è effettivamente in grado di finanziare, valutazione che non può essere fatta materia per materia, perché ci si troverebbe alla fine nella condizione di non potere finanziare i lep necessari ad assicurare l’esercizio dei diritti civili e sociali nelle materie lasciate per ultime”. Certo, questo compito non rientrava nei poteri conferiti alla commissione perché i limiti del finanziamento risultano stabiliti previamente dal legislatore con una clausola di invarianza finanziaria: si dovrà “comunque” operare “nell’ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente”. Ma ciò comporta un forte rischio di ineffettività dei lep, visto che inizialmente le spese saranno computate in base ai valori di spesa storica e dei costi standard, se stabiliti.
Solo a regime l’art. 5 della Calderoli prevede che il finanziamento delle funzioni attribuite avvenga attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale. Questa modalità, corrispondente praticamente alla vecchia rivendicazione del residuo fiscale (la differenza tra quanto versato a titolo d’imposta e quanto ricevuto in spesa pubblica era oggetto di un quesito referendario in Veneto, poi non ammesso dalla Corte costituzionale nella sentenza 118/2015), potrebbe arrecare alle regioni con maggior gettito fiscale un extra-finanziamento non legato a maggiore efficienza ma dovuto solo alla loro maggiore ricchezza. Un’aliquota costante fissata nel primo anno dell'intesa farà dipendere l'effettiva disponibilità di risorse della Regione con autonomia rafforzata dall'andamento nel proprio territorio del tributo compartecipato. Negli anni successivi alla stipula dell'intesa, questo meccanismo può determinare un extra-finanziamento svincolato da meccanismi di responsabilizzazione ed efficientamento della spesa. (Per esempio, secondo le simulazioni operate dalla Svimez relativamente alle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che avevano stipulato le pre-intese approvate nel 2018, esse, compartecipando ad IRPEF e IVA, avrebbero conseguito un surplus di risorse di circa nove miliardi e mezzo di euro – il 30 per cento dell’intero gettito nazionale -, sottratte a tutte le altre regioni, prevalentemente del Sud).
Ad impedire la conseguente diminuzione in cifra assoluta del monte irpef o iva, di cui lo Stato dispone per i trasferimenti di risorse a tutte le Regioni, dovrebbe essere una clausola di salvaguardia, approvata durante l’iter al Senato, che si preoccupa di garantire le regioni senza intesa: “Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP” ed è “comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante” (art. 9). Ma politicamente e finanziariamente la salvaguardia è tutt’altro che granitica tanto da far temere – per dirla con la metafora colorita del presidente della regione Calabria, Vittorio Occhiuto, esponente della stessa maggioranza governativa – che “il primo vagone del treno, quello con la legge sull'autonomia, arrivi puntuale in stazione mentre gli altri vagoni, che contengono il finanziamento dei Lep e il meccanismo di perequazione, finiscano su un binario morto”.
7 . I tempi del procedimento
Per l'individuazione dei lep il ddl (art. 3) prevede una delega legislativa “sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui alla legge 197/2022: che in realtà non fa riportare la dizione dell’art. 117 lett. m) Cost. Si tratta, quindi, di una delega a maglie larghe, per il cui esercizio è previsto un termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Ma medio tempore il governo potrà agire sulla base della “normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge” (art. 1), cioè della legge di bilancio 197/2022, che al comma 793, lett. d), dell’art. 1 prevede che i lep siano determinati con uno o più decreti del presidente del consiglio (DPCM), che saranno approntati entro il 31 dicembre 2024 dalla cabina di regia formata dai ministri interessati con i presidenti della Conferenza delle Regioni, dell’Anci e dell’Upi istituita presso la presidenza del consiglio dal comma 792.
Se si considera che la determinazione dei lep è riservata dall’art. 117, lett. m), cit. alla legislazione esclusiva del Parlamento risalta con evidenza lo sbrego costituzionale dell’affidamento di quell’attività ad un organo amministrativo collegiale o, se questo non provvede in tempo, addirittura ad un commissario ad acta, che provvederà entro gennaio 2025. Ad ogni modo da febbraio 2025, se i termini saranno rispettati, sarà possibile attivare il procedimento d’intesa e in maniera anche accelerata per le tre regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna) che avevano concluso intese preliminari sotto il governo Gentiloni nel 2018: questi atti, infatti, conservano validità e “sono esaminati secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge” (art. 11).
Ancora più celermente si potranno avviare le procedure nelle otto materie per le quali non sono previsti lep: giustizia di pace; rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; protezione civile; previdenza complementare e integrativa;
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. In queste materie (e, in generale, nelle funzioni) no-lep le intese – come espressamente previsto dall’art. 4 - si possono fare subito, a partire dalla data di entrata in vigore della Calderoli, senza aspettare il febbraio 2025.
Nell’uno e nell’altro caso saranno le intese a stabilire modalità, procedure e tempi per il trasferimento delle relative funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie. Va pure considerato che in base all’art. 117, co. ottavo, appena ricevute le attribuzioni di competenza, le Regioni potranno collegarsi tramite intese tra loro istituendo “organi comuni” per la migliore gestione delle competenze ottenute: per dire, un assessore unico ai servizi relativi alla giustizia di pace o all’istruzione o alla salute ecc. Praticamente una “secessione dei ricchi” (Viesti), con cui prende corpo lo spettro della “Padania” delle regioni settentrionali, abbastanza verosimile, dato il medesimo orientamento politico della quasi totalità delle giunte che le governano.
D’altro canto, a completare questo scenario distopico contribuisce la previsione che (come già accaduto dopo le ricordate pre-intese, quando anche la Campania, ora pur con la stessa giunta tra le più fiere oppositrici del progetto) che, stipulate le prime intese con le tre regioni in lista di attesa, anche le regioni meridionali si adeguino al nuovo corso e chiedano anch’esse la devoluzione di alcune funzioni e, per non essere da meno agli occhi dei loro cittadini, nel numero massimo concesso alle altre regioni. Con questo spezzettamento incurante dell’intero un’Italia simil-federale potrebbe essere un esito non inverosimile.
8. Autonomia differenziata e premierato
“Massima prudenza” nel valutare rischi ed opportunità dell’autonomia differenziata era stata raccomandata ancora una volta dalla Banca d’Italia nell’audizione del novembre 2023 avuto riguardo ad “un contesto caratterizzato da elevata incertezza economica e geopolitica, da condizioni finanziarie diventate meno favorevoli ai paesi ad alto debito pubblico e da ampi ritardi accumulati da alcune regioni del Paese”.
Tralasciando le condizioni economiche e finanziarie, che rimandano ad un contesto anche internazionale, rileva puntualmente in questa sede l’accennato ritardo oggettivo delle regioni del sud. Il fenomeno è risalente, data sostanzialmente dall’avvento della riforma regionalistica. Lo rilevò già quarant’anni fa il politologo statunitense Robert Putnam sul radicamento dell’istituto regionale nel sistema politico italiano, assai debole nel sud. E in un libro di qualche anno più tardi lo attribuì alla scarsa civicness (traducibile con civismo, ma comprendente, di più, senso dello Stato, coinvolgimento nella gestione del bene pubblico) del sud rispetto al nord. Sarebbe questo divario a spiegare l’ottimizzazione del nuovo quadro di espansione dell’autonomia da parte delle regioni del nord rispetto a quelle del sud, incapaci di raccogliere la sfida.
Per quanto discusso all’epoca e per diversi aspetti fondatamente criticato, all’iperdualismo Nord-Sud teorizzato da Putnam sembra arridere ora nuova fortuna nella concezione, per dir così, meritocratica dell’autonomia differenziata. Una sorta di premio dato a chi merita e può rendere di più, migliorando le condizioni di vita dei suoi abitanti, in primo luogo, ma anche di tutti i cittadini che possono godere delle migliori (si pensi a quanto già avviene con la mobilità per cure sanitarie dal sud al nord). Nel contempo un invito alle regioni meridionali ad accogliere questa sfida per migliorare la loro policy e così poter competere con le regioni settentrionali. Questo classico cavallo di battaglia contro le regioni meridionali, in qualche misura fondato ma non esaustivo, riecheggia in un’intervista rilasciata dal presidente della Clep, Cassese, “Noi possiamo dire quale è il diritto, lo Stato stanzia una cifra, ma se chi gestisce quella cifra non la gestisce bene l'ultimo miglio diventa difficile da coprire se l'amministrazione non funziona bene". Ma, a parte che si dà per scontato proprio lo stanziamento di quella “cifra”, che rappresenta, invece, il punto dolente della riforma, s’è visto come tutti gli indicatori facciano presagire, tuttavia, una continuazione, e verosimilmente un approfondimento del divario con le regioni del nord.
Ma ciò che rileva in questa sede è la frammentazione della Repubblica una e indivisibile in “venti staterelli” (Villone), con i propri egoismi territoriali in competizione tra loro anche al costo di una minore competitività dello Stato nell’agone europeo e internazionale. Formalmente indivisa, la Repubblica affiderebbe la realizzazione dell’unità declamata dall’art. 5 alla persona del premier, eletto dal popolo anche se non a maggioranza assoluta, che con un altro disegno di legge s’intende introdurre in Costituzione. Nei commenti, finora susseguitisi, è prevalente la considerazione di uno scambio politico tra i partiti di maggioranza, considerato intrinsecamente contraddittorio in quanto un premier forte, dominus del parlamento avendone il potere di scioglimento, si troverebbe a gestire un potere centrale molto più ridotto dell’attuale, in quanto spogliato della serie di funzioni attribuite alle regioni. Il combinato disposto delle due riforme autorizza sicuramente questa previsione. Ma va pure considerato che il manico, il potere di intesa dalla stipulazione alla cessazione anche anticipata, è saldamente nelle mani del presidente del consiglio.
Questi ha il potere di:
a) anche senza il parere dei ministri interessati e solo informandone le Camere, avviare “comunque” il negoziato (art. 2)
b) limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie individuati dalla Regione nell'atto di iniziativa (art. 2)
c) predisporre lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. (art. 2)
d) non conformarsi in tutto o in parte, sia pure motivatamente, agli atti di indirizzo delle Camere (art. 2)
e) non conformarsi ai pareri parlamentari sui lep ed emanare ugualmente i relativi decreti legislativi (art. 3);
e) aggiornare i lep e i costi dei fabbisogni standard con semplici dpcm, anche qui “saltando” all’occorrenza le competenti commissioni parlamentari (art. 3);
f) disporre verifiche e monitoraggio sul raggiungimento dei lep e, in caso di esito negativo, assumere l’iniziativa legislativa di cessazione, integrale o parziale, dell’intesa (art. 7);
g) esercitare, infine, il potere sostitutivo del Governo già previsto dall’ art. 120 Cost.
Considerati questi profili disciplinati dal ddl, si può dire che l’autonomia differenziata non è senz’altro in contraddizione ma costituisce già ora, a costituzione invariata, una prova di premierato forte.
9. Un’autonomia incostituzionale?
Si può essere uguali e diversi? La domanda che in riferimento agli Stati Uniti si pose Horace Kallen esattamente un secolo fa ha ricevuto nel costituzionalismo una risposta positiva e articolata. Le differenze possono e anzi debbono essere valorizzate ma facendo attenzione perché non diventino disuguaglianze da evitare. L’incubo dell’egualitarismo – che mortifica le performance, il merito, il talento, la libera concorrenza – non deve rovesciare le discriminazioni positive in negative.
Il principio vale anche per le Regioni. É ancora bruciante l’esperienza fatta durante la pandemia, quando, pur essendo la profilassi materia di competenza esclusiva dello Stato, ogni regione aggiungeva discipline particolari, approdate anche davanti alla Corte costituzionale. Una disuguaglianza simile potrebbe accadere, ad esempio, per la scuola. È la fonte primaria dell’identità nazionale. Ma il trasferimento di competenze anche generali potrebbe indurre a differenziare regione per regione i programmi di studio in maniera escludente la storia e la letteratura dell’Italia unita. Regionalizzare, poi, la gestione dei rapporti di lavoro del personale scolastico, e pubblico in generale, per esempio offrendo una maggiore retribuzione o richiedendo certificazioni o abilitazioni di carattere regionale, comporterebbe un depotenziamento del contratto collettivo nazionale e dell’uguaglianza dei diritti dei lavoratori. E peraltro, unitamente alla regionalizzazione di porti, aeroporti, autostrade, ecc., potrebbe ostacolare di fatto la stessa libertà delle imprese, costrette quando abbiano carattere sovraregionale a misurarsi con regolamentazioni diverse da luogo a luogo. Ciò spiega l’atteggiamento prevalentemente oppositivo dei sindacati e delle associazioni degli imprenditori.
Gli elementi e le caratteristiche che fanno di ciascuna regione un territorio diverso dagli altri non devono ostacolare la crescita di una comunità di persone uguali alle altre. Certo, c’è il pluralismo sociale, che può essere anche territoriale, sfociando nell’autonomia, ma sempre nel quadro dell’unica Repubblica: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali» (art. 5 Cost.). Qui non si tratta di applicare il criterio del bilanciamento tra princìpi ugualmente meritevoli di tutela giacché, come già ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza 118/2015 con cui bocciò il referendum secessionistico del Veneto, “l’unità della Repubblica è uno di quegli elementi così essenziali dell’ordinamento costituzionale da essere sottratti persino al potere di revisione costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988)”. Si è al cospetto, cioè, di un principio supremo, o fondamentale, sovraordinato anche alle norme revisionate del titolo V, che, se interpretate e attuate in modo praticamente antiunitario, non si sottrarrebbero ad un giudizio di incostituzionalità. Del resto, la Costituzione non manca di fornire la corretta chiave interpretativa dell’unità e indivisibilità della Repubblica. La offre nell’art. 2 (Azzariti) e nei numerosi articoli che concorrono alla costruzione dello stato sociale: la solidarietà. C’è una soglia minima di “doveri inderogabili” che dev’essere rispettata. Con tutti i suoi difetti il titolo V su questo è chiaro: autonomia differenziata ma nel rispetto della perequazione a favore delle regioni con minore capacità fiscale, realizzabile, oltre che con interventi speciali, soprattutto attraverso il finanziamento dei lep.
Non implementando questo rispetto è da chiedersi non che cosa di più e di meglio sotto il profilo dei diritti civili e sociali possa fare l’autonomia differenziata ma che cosa l’autonomia differenziata può fare dello stato costituzionale di diritto e dello stato sociale. C’è il rischio che non serva a differenziare ma piuttosto a privilegiare quelle parti del Paese che già sono più avanti: una autonomia privilegiata, contraria al principio supremo posto dall’art. 5 della Costituzione.