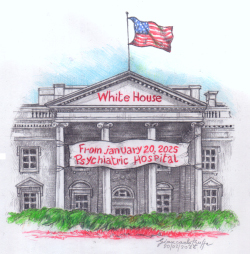Non ce l’ha fatta, è poco, è troppo, ma è così. Quello che vince oggi, giovedì 7 maggio, è l’eloquenza del dolore, cioè la verità. Nelle ultime 48 convulse ore s’era aperto lo spiraglio di un altro destino. D’altro canto, Theodor Adorno lo aveva spiegato in modo crudele quanto lucido: la necessità di far sì che il dolore diventi eloquente è la condizione della verità. No, non ce l’ha fatta, İbrahim Gökçek. Non ha neanche avuto il tempo per vedere se il regime di Erdoğan concederà ai compagni del Grup Yorum di suonare davvero in luglio senza far scorrere fiumi di sangue.
Un altro tempo, però, quello sufficiente a vedere come l’immensa debolezza che ha segnato i suoi 323 giorni senza mangiare sia riuscita a piegare un potere ritenuto invincibile, quello sì, İbrahim è riuscito a strapparlo. Anche alla morte. Il tempo è tiranno, si dice non senza ragione, ma non sempre è alleato della tirannia. Anche se quel tempo, il tempo degli orologi, molto diverso da quello del nostro fare, si ostina a lasciarci credere che possiamo ancora solo limitarci a scegliere nient’altro che una delle varianti del dominio dell’accumulazione di denaro sulle persone. Il collettivo degli Yorum ha, tra gli altri, l’ormai rarissimo merito di non essersi mai rassegnato a quell’idea, la menzogna più indecente e indiscutibile del secolo scorso e di quello che già entra nel terzo decennio.
İbrahim Gökçek è morto, dunque, stamattina, in ospedale a Istanbul. Nella notte le sue condizioni si erano aggravate, mentre ancora decine di migliaia di persone, in Turchia e in molti altri angoli del mondo, festeggiavano la sua vittoria. Quella sancita martedì 5 maggio dal tribunale di Istanbul, che aveva accolto la richiesta del Grup Yorum di tornare a tenere finalmente un concerto. È stato soprattutto per quella essenziale manifestazione di libertà, un atto simbolico la cui portata politica era diventata di valore mondiale perfino al tempo della pandemia, che Helin Bölek e Mustafa Kocak – lasciati morire entrambi a 28 anni, il 3 e il 23 aprile, e adesso anche il loro amato bassista İbrahim -, hanno condotto una lotta così estrema. Una lotta che, come abbiamo avuto modo di vedere nelle ultime settimane, ha tenuto con il fiato sospeso e il cuore in gola anche diverse migliaia di lettori di queste nostre pagine, in queste settimane così attanagliate dall’ossessione totalizzante del tema coronavirus.
La forma di lotta delle tre persone che le istituzioni turche hanno condannato, lasciandole morire, non ha mai avuto considerazione rilevante nella storia dei movimenti anti-sistemici. È questa un’altra, forse molto particolare, eloquenza del dolore. Proprio il 5 maggio di 39 anni fa, mentre un altro giovane militante irlandese veniva lasciato morire di fame nel tremendo carcere inglese di Long Kesh, Margaret Thatcher, la lady di ferro che ha segnato in modo epocale le politiche europee contro i movimenti di lotta, si limitò a dire: “Bobby Sands era un criminale. Ha scelto di togliersi la vita”.

Helin Bölek
Non era stata, naturalmente, quella forma di lotta a uccidere Bobby Sands. Era stata la Thatcher. Così come non è stata la forma di lotta ad ammazzare i tre ragazzi turchi. Sarà bene non stancarsi di attingere a tutta la pazienza possibile per ripeterlo fino allo sfinimento. È il minimo che dobbiamo a quelle resistenze impensabili. Anche se saranno sempre in molti a sostenere il contrario, lo sappiamo, qualcuno perfino in buona fede. “Ci hanno lasciato solo i nostri corpi per combattere”, aveva detto senza esitazioni Helin, prima di andarsene.
Quel che ha ucciso Helin, Mustafa e İbrahim è un potere cieco e sanguinario su cui sono stati versati fiumi di inchiostro e uno Stato che gli consente di farlo. Dalla persecuzione dei suoi avversari politici allo sterminio del popolo cui è proibito perfino di parlare, tanto fa paura al secondo esercito della Nato (che conta 29 paesi), i Kurdi. Dal ruolo di gendarme e carceriere per chi fugge dagli inferni siriani o afghani, un ruolo consapevolmente e lautamente stipendiato dall’Europa, alla recente benzina scagliata con protervia su un altro inferno, quello libico. Tutto è stato detto, sul nazionalismo delirante e omicida di Erdogan. Pochissimo viene raccontato sulla resistenza di chi gli si oppone, fatta eccezione, forse, per la rivolta del 2013 al Gezi Park, schiacciata anch’essa nel sangue.
Quel che ci lasciano Helin, Mustafa e İbrahim non è solo una testimonianza tremenda quanto essenziale per chi lotta contro l’oppressione e per l’affermazione della libertà e della dignità della vita in Turchia, nel Rojava e in ogni altro scenario del pianeta. È soprattutto l’urgenza di ricondurre a una dimensione etica la condizione umana della verità e della lotta politica. In un tempo segnato dalla consuetudine di chi non fa mai quello che dice e non dice mai quello che fa, si tratta di un compito immenso. Il tempo per cominciare ad affrontarlo, come insegnano la vita e la morte di İbrahim Gökçek, non è infinito.
Mi aggrapperò alla vita. La lettera di İbrahim Gökçek del 27 aprile
Bella Ciao eseguita dal Grup Yorum al concerto di Istanbul davanti a un oceano di persone: