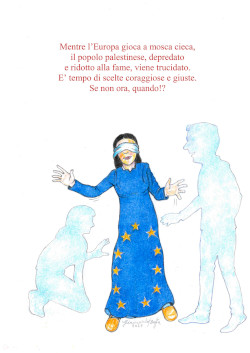Il principio della divisione dei poteri è all’origine del costituzionalismo moderno. «Perché non si possa abusare del potere, bisogna che, per la disposizione delle cose, il potere freni il potere», tuonò Montesquieu. Senza separazione dei poteri a garanzia dei diritti nessuna società ha una costituzione, sancì la dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1789.
È questo il principio che viene messo in discussione quando si afferma che la magistratura non può sindacare le scelte politiche del governo. È ben possibile che alcune decisioni del potere giudiziario siano sbagliate: si ricorra in appello, si utilizzino tutti gli strumenti che il nostro ordinamento prevede per assicurare il diritto di difesa e il giusto processo.
Si può certamente criticare l’operato di qualunque procura o le sentenze di qualsiasi tribunale, quel che invece non può essere messo in discussione è la legittimità del controllo giurisdizionale sugli atti dei governanti. I giudici fanno politica quando omettono di sanzionare i comportamenti illegittimi del governo, non quando esercitano l’azione penale nei confronti del potere.
Sbaglia chi afferma che non si può processare chi difende i confini, perché anche le politiche di sicurezza e migratorie sono tenute a rispettare il diritto, tanto quello nazionale, quanto quello internazionale. Ogni volta che si è difronte ad un fatto determinato e non inverosimile, astrattamente qualificabile come reato, un’indagine giudiziaria è doverosa.
Un’obbligatorietà dell’azione penale che potrà condurre, auspicabilmente, alla non iscrizione del reato, alla archiviazione ovvero all’assoluzione dell’indagato, ma ciò solo dopo che l’autorità giudiziaria avrà svolto le sue indagini per l’accertamento dei fatti.
Tanto più sarà obbligata l’azione se essa coinvolge la responsabilità di un ministro nell’esercizio delle sue funzioni, dove il controllo deve essere ancor più severo, nel rispetto del principio della soggezione dei poteri alla legge.
L’idea opposta secondo la quale chi viene eletto – per il solo fatto di avere una indiscutibile legittimazione popolare – sia al di fuori da ogni controllo giurisdizionale è premoderna. La sovranità non appartiene al governo, bensì al popolo, il quale l’esercita nelle forme ed entro i limiti posti dalla costituzione, dalle leggi nazionali e dai vincoli derivanti dagli ordinamenti sovranazionali.
È questo che rende inaccettabile la vicenda legata alle ripetute deportazioni di migranti in Albania. Non siamo qui davanti ad una decisione isolata di un giudice che non viene condivisa e che potrebbe tranquillamente essere impugnata in Cassazione senza tanto clamore, ma ci troviamo di fronte ad una caparbia volontà di imporre una decisione politica contra ius.
Come è stato scandito: il centro albanese e le procedure abbreviate di reimpatrio «funzioneranno» perché così vuole il governo, oltre ogni regola di diritto. E allora, è certamente possibile dire che chi ostacola questo disegno si pone contro il governo, ma si deve aggiungere che si colloca a difesa della costituzione.
Chi invece continua a cercare strade per eludere quanto stabilito dai giudici (derogando al principio del giudice naturale e andando alla ricerca di tribunali proni, che per fortuna non trova), senza neppure attendere che altri giudici – quelli europei – rispondano alle questioni loro poste, mostra una preoccupante propensione alla trasgressione della legalità. Se questi sono i poteri costituiti c’è da riflettere sulla tenuta dello stato di diritto.
Vero è che esistono «immunità» a tutela della rappresentanza parlamentare e di chi ricopre cariche di governo che valgono a salvaguardare le funzioni. In questi casi sono previste procedure particolari che i magistrati devono adottare (richiesta di autorizzazione al parlamento, limiti alle proprie capacità di indagine, trasferimento degli atti loro pervenuti ad altri tribunali).
Ci sarebbe da preoccuparsi se il potere giudiziario non rispettasse tali procedure speciali, non quando diligentemente le segue, avvisando poi gli interessati degli atti compiuti, come doverosamente gli impone la legge costituzionale.
L’ultimo caso è quello che appare il più significativo della crescente propensione degli «eletti» a non sottoporsi più ad alcun controllo: né giurisdizionale, ma ora neppure politico. Un’immunità che si traduce in privilegio, rendendo insindacabile ogni atto compiuto durante il mandato. Sarà poi solo la folla plaudente a decidere se confermare o meno l’operato del sovrano, secondo il rito barbaro dell’acclamazione del capo.
Nella vicenda che ha visto coinvolto il presunto torturatore Elmasry bisogna partire dal fatto che la Corte penale internazionale ha richiesto all’Italia l’arresto e l’estradizione, mentre è stato scarcerato dalla Corte di appello di Roma e poi riportato in Libia dal governo del nostro Paese. Non v’è dubbio, dunque, che l’Italia deve rispondere per non aver dato seguito ad un obbligo internazionale cui pure è vincolata (dalle norme che hanno dato attuazione al Trattato istitutivo della Cpi).
Può darsi – come fa intendere senza dirlo – che vi siano state ragioni legate agli accordi con la Libia che si sono ritenute di dover far prevalere rispetto agli obblighi contratti con la Corte penale internazionale, né può escludersi che siano stati fatti valere motivi di tutela della sicurezza nazionale.
Ma proprio ciò – la necessità di chiarire i fatti per poterne poi valutare le responsabilità politiche ed eventualmente giuridiche – rende necessario, per la salvaguardia dello stato di diritto e della democrazia costituzionale, che il governo dia conto del suo operato. In sede politica, dinanzi al parlamento; in sede giurisdizionale, quando dovrà necessariamente rispondere alla Cpi. Mentre al giudice nazionale è richiesto di verificare se tutto si è svolto nel rispetto della legalità.
Essendo attività compiuta nell’esercizio delle funzioni di governo da ministri responsabili per gli atti dei propri dicasteri e dal presidente del Consiglio in qualità di responsabile della politica generale del governo, tale verifica, conformemente a quanto definito dalle prerogative costituzionali, dovrà essere eseguita dal tribunale dei ministri. Dov’è lo scandalo? Il controllo è dovuto, ma dovrebbe essere anche voluto.